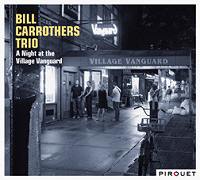Home » Articoli » Lyrics » L'apocalisse dietro le spalle. Il Jazz e il Vietnam.
L'apocalisse dietro le spalle. Il Jazz e il Vietnam.
Se il blues e il rock hanno molto cantato, negli anni Sessanta e Settanta, della tragica esperienza vissuta dagli Stati Uniti in Vietnam, il jazz è parso a lungo indifferente a questa sanguinosa pagina della storia americana. Ma forse la realtà è un po' diversa. Genere eminentemente strumentale, questa musica ha sempre commentato l'attualità in modo simbolico e trasversale, rifiutando (salvo eccezioni individuali) declamazioni retoriche e semplicismi descrittivi. In verità ogni fase del suo sviluppo risponde alle vicende dell'attualità come l'ago di un sensibilissimo sismografo; ma ha bisogno di essere interpretata, decodificata.
Qualche esempio: l'ottimistica esplosione del jazz, divenuta "moda" negli ultimi anni Dieci del Novecento, si sovrappone in modo palmare all'entusiasmo vitale che segue la fine della Grande Guerra; la definizione del suo problematico individualismo negli anni successivi, con i primi grandi solisti, è parallela al disorientamento sociale del proibizionismo; l'edonistica "età dello Swing" corrisponde (lo notano già tutte le tradizionali storie del jazz) al desiderio d'evasione diffuso durante la Depressione; l'angoscioso bebop si afferma nel paesaggio americano successivo a Pearl Harbor; un'apparente crisi "direzionale" del jazz (in effetti un lontano preludio alla multipolarità contemporanea) sopravviene negli anni oscuri del maccartismo; la rinascita delle istanze africaniste s'intreccia alla grande stagione del movimento per i diritti civili dei neroamericani; la fase più rovente del free jazz affianca gli sconvolgimenti sociali dei secondi anni Sessanta (ed è anche, appunto, l'epoca del Vietnam); la forte pulsione individualistica degli anni Settanta rispecchia l'epoca di una profonda ridefinizione sociale, causata dalla crisi del modello fordista (con ampie ripercussioni anche nell'industria musicale); subito dopo, la percezione millenaristica della fine di un'epoca (la crisi delle ideologie, l'indebolimento delle frontiere, l'attrito fra globalizzazione e localizzazione) si è concretizzata in un jazz ripiegato su se stesso o meglio disposto a riflettere su se stesso, con una nuova coscienza della propria storia.
Naturalmente, le coordinate qui tratteggiate non hanno la pretesa di "spiegare" la realtà estetica di un movimento complesso qual è il jazz; sono lineamenti generali quanto generici, utili come ipotesi di lavoro per approfondimenti ben più accurati. E del resto, "riflettere" gli avvenimenti non significa necessariamente volerne interpretare il senso. Da questo punto di vista, per quanto il jazz del decennio 1965-1975 abbia in qualche misura espresso anche i sentimenti e le sofferenze della guerra americana in Estremo Oriente, senza dubbio l'esperienza del Vietnam ha rappresentato una sorta di "rimosso" per questa musica, ben diversamente da quanto è avvenuto nel cinema statunitense, che ha dato vita molto presto a un vero e proprio "sottogenere".
I dischi emersi in modo doloroso ma anche liberatorio dall'animo di Billy Bang con l'aprirsi del nuovo millennio, "Vietnam: The Aftermath" del 2001 e Vietnam: Reflections del 2004 (cui nelle intenzioni dell'autore dovrebbe seguire un album conclusivo in collaborazione con l'orchestra sinfonica nazionale vietnamita), rappresentano l'importante elaborazione di un ex veterano nei confronti di un'esperienza devastante. Bang (anzi il sergente William Walker, matricola 51613087) ha combattuto diciannovenne nella giungla del Paese asiatico, come illustra l'impressionante foto di copertina del primo dei due dischi, e ha vissuto i successivi trent'anni cercando di ignorare o almeno di sopire gli incubi che ne sono derivati, prima di saper trasformarli in affresco sonoro. Ma questo stesso silenzio attraversa gli ultimi decenni dello sviluppo del jazz, tanto che per comprendere il senso della musica di Bang varrà la pena di citare alcuni rarissimi "segnali," quasi sommersi dalla gran corrente musicale degli anni Settanta Ottanta e Novanta, nei quali il Vietnam è in diverso modo evocato.
Il più palese è anche il più lontano nel tempo, nonché quello che crea suggestive connessioni con il lavoro di Billy Bang. Si tratta del primo disco inciso nel 1972 dal Revolutionary Ensemble, un'improvvisazione che copre senza soluzione di continuità le due facciate di un long playing e s'intitola appunto Vietnam. Negli anni più sofferti della guerra, il titolo pare più un'invocazione, o una denuncia, che non una dichiarazione d'intenti: nel lungo brano non ci sono echi musicali diretti della cultura orientale (il piccolo tema che appare qualcosa come otto minuti dopo l'inizio potrebbe appartenere a molte tradizioni), né descrizioni "impressionistiche" di come poteva essere percepito il lacerante conflitto. Ma l'album si propone come un vistoso segnale, una freccia puntata verso lo spinoso argomento: par di sentire, di risposta, l'establishment mormorare "Vietnam? E perché tre negri citano il Vietnam per suonare la loro avanguardia?".
Nel Revolutionary Ensemble è preminente la voce appassionata del violino (e della viola) di Leroy Jenkins, il principale ispiratore di Billy Bang. Il gruppo, completato dal percussionista Jerome Cooper e da Norris Jones, che qui suona contrabbasso e violoncello, rappresenta (benché troppo misconosciuto) uno dei grandi punti di riferimento dell'estetica nata a Chicago negli anni Sessanta; è interessante che proprio da questa nuova corrente stilistica giunga un segnale che sposta l'attenzione rispetto al continente africano, privilegiato da tutti gli sperimentatori della generazione precedente.
Ancora un piccolo segnale: otto mesi dopo aver inciso Vietnam, Leroy Jenkins partecipa al primo album firmato dal batterista Paul Motian per dar via a un brano che s'intitola Inspiration from a Vietnamese Lullaby. Qui gli echi orientali sono evidenti, anche se Motian preferirà eliminare ogni riferimento al Vietnam quando riprenderà, cinque anni dopo, il brano con il più anonimo titolo di Lullaby.
La tappa successiva della nostra piccola e forse pretestuosa ricerca ci porta a uno dei primi lavori pubblicati da John Zorn, Archery: elaborato ed eseguito dal vivo nel 1979, inciso nel 1981. Si tratta di uno dei celebrati game pieces del compositore e sassofonista newyorkese, ideato non intorno a una partitura ma a "regole" analoghe a quelle dei giochi sportivi o di società. Qui il riferimento al Vietnam è molto più indiretto, ma non meno istruttivo. Racconta Zorn, riferendosi al periodo successivo alla pubblicazione dell'album: "Un giorno ricevetti una lettera da un ascoltatore - non la chiamerei precisamente la lettera di un fan, ma significò molto per me a quell'epoca. Ascoltava la radio, a notte fonda, e una volta gli capitò di sentire Archery. Ne fu molto colpito. Trafitto. Capitano dei marines - un Berretto Verde -, viveva in una base militare nel Texas occidentale, e Archery gli aveva ricordato nientemeno che la sua straziante esperienza delle operazioni di guerriglia nelle giungle del Vietnam. E si era sentito spinto a raccontarmelo; confrontando la "tensione e imprevedibilità" della musica con le sue lotte per la vita o la morte nell'inferno della guerra".
Potrebbe sembrare un dettaglio poco significativo, ma che dire del fatto che tanto il marine quanto il compositore abbiano sentito la necessità di riferirlo? In effetti l'ascolto del primo Zorn, nel panorama jazzistico a cavallo fra anni Settanta e Ottanta, è profondamente perturbante. Con lui, e con altri autori della generazione cui appartiene, si afferma una modalità d'improvvisazione che contrasta continuamente e ostentatamente con le aspettative di chi ascolta. È davvero una prassi "guerrigliera" che da un lato erode radicalmente le convinzioni dello spettatore, dall'altro ne altera le sensazioni percettive. Si può dire che, da un punto di vista schiettamente artistico, con questi esperimenti il jazz sia riuscito a tradurre simbolicamente la devastante esperienza psicologica vissuta vent'anni prima non solo dai militari ma dall'intera società statunitense.
Dopo di allora si è allargato a macchia d'olio il fenomeno della world music e l'uso, troppo spesso meramente commerciale, delle tradizioni non occidentali. Anche il ricchissimo patrimonio sonoro proveniente dall'Estremo Oriente ha iniziato a essere pane quotidiano per gli ascoltatori della musica di vasta diffusione. Il jazz, che aveva una lunga e autonoma tradizione relativa all'uso "creativo" di elementi provenienti dalle musiche del Terzo Mondo, ha dovuto fare i conti con questa tendenza che rischiava di depotenziare la carica espressiva di alcuni suoi elementi espressivi. Le strategie messe in campo per risolvere questo problema sono state, dagli anni Ottanta in poi, molte e molto varie (non tutte convincenti). Una ha riguardato l'accentuazione delle componenti emozionali, per sottolineare il carattere di spontaneità da sempre associato al jazz; la strada per recuperare "affettivamente" le tragiche vicende della guerra in Vietnam era aperta. E non è un caso che per la prima volta (siamo nel 1996) sia stata imboccata da un musicista che ha stretto legami familiari con il Paese asiatico, sposando una vietnamita: il sassofonista Michael Blake (noto soprattutto per i suoi trascorsi nei Lounge Lizards), con l'album "Kingdom Of Champa" che, raccontando l'esotica magia di un antico impero, la mette anche a confronto con la musica e la stridente diversità dei recenti aggressori.
In fondo Billy Bang fa qualcosa di simile, pur partendo da un'esperienza più estrema. I suoi due dischi tracciano un percorso di progressiva elaborazione (e non è improbabile che ora, dal vivo, passati altri tre anni, la musica si sia ulteriormente decantata). Il primo album utilizza con grande pathos ogni possibile riferimento agli stili con cui il violinista è cresciuto, quasi a costruire un solido terreno per tornare ad affrontare (insieme a vari commilitoni: Ted Daniel, Frank Lowe, Ron Brown, Michael Carvin, Butch Morris) i suoi "demoni personali," come scrive lui stesso. Ne nasce una musica di forte attualità stilistica, in cui però sarebbe ingenuo cercare la "traduzione" delle vicende d'allora. Bang non vuole realizzare un Apocalypse Now del jazz, ma proporre una mappa sonora delle proprie emozioni, fra le quali ci sono (represse, rivisitate, discusse collettivamente) quelle causate dal Vietnam degli anni Sessanta.
Nel secondo disco il violinista è riuscito a operare un più preciso distacco dall'infuocata materia dei suoi ricordi; non a caso vi s'incontrano temi della tradizione orientale dal disteso afflato melodico. Soprattutto, Bang ha trovato la serenità per affiancare al suo gruppo alcuni musicisti vietnamiti, in un abbraccio artistico e umano che è davvero al tempo stesso globale e locale. La parabola della sua esperienza è perfettamente rappresentata dalle rispettive copertine dei due dischi: nella prima c'è il macho invasore, torso nudo e micidiale mitraglia sulle spalle, lo sguardo rivolto solo alla linea sottile che divide la vita dalla morte; nella seconda è ritatto un violinista che abbraccia il suo strumento, intento ad ascoltare con sensibilità quasi femminile la musica interiore destinata a emergerne. I suoi occhi sono chiusi, ma certo guarda molto più lontano del sergente Walker di quarant'anni fa.
Foto di Claudio Casanova (Billy Bang) e Eye Shot Jazz (Michael Blake).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.