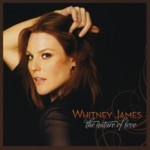Home » Articoli » Lyrics » La continuità evolutiva del jazz
La continuità evolutiva del jazz
In campo jazzistico è molto più evidente il concetto di evoluzione e di continuità fra esperienze diverse; in pratica esso viene negato solamente da alcuni critici e storici i quali, per una eccessiva esigenza di ordine, hanno innalzato barriere nette fra stili, scuole, aree geografiche, periodi storici. Non mi risulta che alcun musicista abbia negato di collegarsi al proprio patrimonio musicale, pur ammettendo di sottoporlo a un'estensione, a un rinnovamento attraverso il proprio lavoro. Sono inoltre abbastanza rari quei jazzisti, ormai consacrati dalla fama, che hanno ostentato pubblicamente un'avversione per il linguaggio proposto dai più giovani esponenti dell'avanguardia.
Memoria del passato, esperienza presente e progettazione del futuro sono dunque compresenti in ogni momento della musica afroamericana. Fred Anderson, sassofonista aderente all'A.A.C.M. di Chicago, nel corso di una intervista pubblicata su Jazz Forum n. 68, afferma: «... quando tu conosci tutto ciò che è venuto prima, hai migliori probabilità di trovare te stesso... Qualsiasi cosa io faccia ora, non sarebbe stata possibile se io non avessi imparato dalle guide venute prima di me... Io non sto suonando una nuova musica, sto solo cercando di essere una estensione (delle precedenti)... Se tu non cerchi di preservare la tua tradizione, nessuno si preoccupa di conservarla per te...».
Il trombettista Leo Smith, uno dei più "indigesti" ed incompresi esponenti del Post Free degli anni '70, proprio perché con la sua musica sembra tradire la tradizione jazzistica, mette perentoriamente in guardia da false interpretazioni affermando: «Fu mio padre a rendermene cosciente per la prima volta: ricordo bene una cosa, mi disse: più avanti vai, più indietro devi guardare.» (da Musica critica società, opuscolo edito dal C.R.I.M. di Pisa nel 1979).
A differenza di ciò che accade nel mondo dell'arte visiva, nella pratica operativa dei musicisti jazz non c'è mai contrapposizione al passato, non c'è volontà di superare dialetticamente l'esperienza che li ha preceduti per proclamare la propria diversità. Contrariamente a quanto hanno fatto credere alcuni critici, male interpretando la musica e le dichiarazioni di certi jazzmen, si riscontra una integrazione, una continuità nell'evoluzione anche nei periodi di più accentuato rinnovamento del linguaggio jazzistico (negli anni '40 col Bebop e negli anni '60 col Free Jazz).
Pertanto concordo con Gian Carlo Roncaglia quando rileva come «... le innovazioni sempre abbiano salde radici nella tradizione. Il jazz degli anni '40 e dei decenni seguenti, insomma, solo dalla tradizione avrebbe potuto alimentarsi per assumere gli stilemi che lo avrebbero caratterizzato. » (da Il jazz e il suo mondo, Einaudi, 1979).
Lo stesso Smith nel famoso saggio Creative Music, pubblicato interamente in Italia a cura del C.R.I.M., con queste parole sintetizza l'evoluzione del Bebop, struttura portante del jazz moderno, fino a congiungersi con la Musica Creativa degli anni '70: «All'inizio il bop risultò complicato come la più giovane musica nera, coi gruppi che improvvisavano collettivamente, permettendo comunque ad ogni improvvisatore di crearsi un suo proprio stile. In seguito il bop si aprì ad una musica molto meno complicata. L'hard bop si incanala in linee più semplici. Ancor più si avvicinò alla semplicità il funk. A sua volta, l'extension bop era complicato come il bop originale; esso contribuì al rinnovamento della nostra musica incorporando strutture armoniche più avanzate e ampliando la gamma ritmica».
Ogni proposta quindi viene acquisita, sviscerata, rinnovata nelle infinite possibili variazioni dei diversi approcci compositivi ed improvvisativi. A tale proposito non sono d'accordo con Gunther Schuller quando assegna all'improvvisazione solistica, o meglio agli esecutori-strumentisti, un ruolo privilegiato rispetto ai compositori, ai fini dell'evoluzione del jazz. Egli nel suo libro Il jazz classico (edito nel 1968 dalla Oxford University Press e pubblicato in Italia da Mondadori nel 1979) sostiene: « È pressoché assiomatico che ciascuno degli stili di jazz che si sono susseguiti si è basato sulle invenzioni della precedente generazione di esecutori, non di compositori».
E dopo aver chiarito che la distinzione fra composizione ed esecuzione nel jazz è assai sfumata e che di fatto le due prassi operative sono intimamente connesse, continua: «È manifesto che i principali progressi stilistici e concettuali nel jazz sono stati provocati dai grandi compositori-strumentisti - Louis Armstrong, Earl Hines, Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, John Coltrane, Ornette Coleman - non da Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Thelonious Monk, John Lewis, George Russell e Charlie Mingus. Gli strumentisti possono ammirare e rispettare l'opera di costoro, possono perfino esserne influenzati per qualche verso secondario, ma non sono questi gli uomini che essi emulano sul loro strumento. Le ragioni sono evidenti: uno strumentista non può emulare in tutto e per tutto una concezione compositiva basata in sé sull'apporto collettivo di un certo numero di persone (come nel caso di Ellington e Mingus). In secondo luogo, la maggior parte dei compositori sopra citati non sono virtuosi nel senso di un Parker o di un Armstrong, o sono strumentisticamente così antiortodossi da precludere l'emulazione, sicché in nessun caso il risultato potrebbe portare all'emulazione. Emulando un Parker o un Armstrong, il musicista ha di fronte a sé un problema molto semplificato. Benché una concezione quasi compositiva stia alla base dello stile di questi strumentisti, l'accento ricade chiaramente sullo strumento e sull'esecuzione».
Io concordo con Schuller sul fatto che per un jazzman "strumentista" risulti difficoltoso, e direi inutile, emulare un grande "compositore"; ciò che egli non prova e che io non condivido è l'asserzione assiomatica che i "compositori-strumentisti," e non i "compositori" veri e propri (e ne riporta i nomi), hanno dato il maggior impulso all'evoluzione della musica afro-americana.
Personalmente penso che sia più giusto parlare di due modi diversi di influire ed incidere sullo sviluppo del jazz. L'influenza dei grandi solisti è immediata, assai evidente e riconoscibile nelle sue caratteristiche, di grande rilevanza quantitativa, ma a volte si tratta di una acquisizione superficiale, passiva, quasi accademica da parte dei discepoli. Al contrario, l'insegnamento esercitato dai compositori ha un effetto a lunga scadenza, esso viene interiorizzato, sviluppato, stravolto anche, da pochi musicisti che ne danno un'estensione personale, contribuendo maggiormente al rinnovamento del linguaggio jazzistico.
D'altra parte ciò è comprensibile: il solista dà una compiuta esposizione di contenuti personali curando la forma improvvisativa, inventando una tecnica strumentale e una pronuncia originale; pertanto è logico che il suo stile favorisca una "emulazione" (termine usato dallo stesso Schuller) che si ferma alla sintassi, cioè una imitazione degli aspetti più esteriori e sensoriali. Diversamente il compositore o l'arrangiatore agiscono nell'organizzazione della materia sonora, sulla struttura del brano, a volte sul coordinamento di una orchestra, precisando un proprio metodo di lavoro: è chiaro che un simile modello operativo, se intimamente assimilato, spinge unicamente a sviluppare una ricerca faticosa, approfondita e personale e non ad una riproposizione pedissequa.
Nel primo caso la quantità dei discepoli non supera mai la qualità del maestro (si pensi ai parkeriani, ai coltraniani, ai colemaniani...), mentre credo che non sia azzardato affermare che il lavoro di Duke Ellington è stato ripreso ed esteso in maniera originale da Mingus e da Sun Ra, per esempio, e che l'insegnamento di Monk ha dato il via alle esperienze del New York Art Quartet, del New York Contemporary Five, di Steve Lacy e di altri esponenti dell'avanguardia (come viene confermato dagli stessi musicisti), oltre ovviamente ad influenzare molti pianisti (bravissimi, ma più derivativi, monkiani appunto).
Ancora a sostegno della mia convinzione che gli insegnamenti dei compositori-arrangiatori stimolano nei musicisti più giovani un'applicazione più profonda e personale, si possono ricordare le parole pronunciate da George Russell, nell'evidenziare la propria discendenza da Gil Evans, anche se tale eredità non è facilmente identificabile nella sua musica: «... chiunque cerchi di sviluppare compiutamente la propria personalità, trasforma i dati originali, e le informazioni che riceve, in qualcosa di proprio. Ma ciò non vuole assolutamente dire che il bagaglio di idee accumulato non abbia peso.» (dalla intervista rilasciata a Mario Luzzi e riportata su Uomini e avanguardie jazz, edizione Gammalibri, 1980).
Inoltre, come ha rilevato Shepp nel corso dell'intervista pubblicata sul medesimo libro di Luzzi, il fatto che la critica, soprattutto quella americana, esalti gli aspetti interpretativi e strumentali di jazzmen quali Coleman e lo stesso Shepp e ne trascuri le capacità compositive, ha un recondito significato: quello di sminuire il reale valore di questi musicisti e, più in generale, di non riconoscere una oggettiva, duratura ed universale dimensione artistica alla musica jazz. In altre parole, per questi critici di estrazione tipicamente colta ed occidentale, il jazz rimane una espressione provvisoria e contingente, in quanto non possiede quell'approccio compositivo che rende eterna ed immutabile la musica classica.
Nonostante che, come ho cercato di dimostrare, nel jazz sia perfettamente individuabile il processo evolutivo che collega i vari momenti storici e nonostante che in esso non sia riscontrabile quella contrapposizione fra movimenti di avanguardia che caratterizza un certo modo di vivere e di concepire le esperienze dell'arte visiva, anche nel jazz tuttavia si verifica una rapida acquisizione delle forme musicali ed un continuo avvicendarsi di personaggi sulla scena dell'attualità. Tale fenomeno è assai più accentuato allorquando musicisti, critici, impresari ed appassionati concepiscono il jazz come forma di spettacolo, come musica di consumo, anziché viverlo come musica d'arte compiuta ed autonoma, come espressione di cultura.
È soprattutto il mondo dello spettacolo e del mercato discografico che richiede un certo tipo di ricambio, suscitando nell'utente l'esigenza di un rinnovamento che è più formale che sostanziale. Spesso i musicisti, per cercare di emergere professionalmente e di trarne un guadagno economico, sono costretti a cedere ai ricatti di impresari e case discografiche, sottoponendo il proprio stile ad una banalizzazione formale e smussando gli spigoli che potrebbero offrire un attrito alla percezione dell'ascoltatore disattento e disimpegnato. I critici a volte avallano spudoratamente queste operazioni commerciali e la maggior parte del pubblico le subisce in maniera acritica.
Ecco quindi che cominciano ad emergere similitudini e soprattutto divergenze fra i modi di produzione estetica e di fruizione inerenti all'arte e quelli relativi al jazz, per cui sarà opportuno approfondire ulteriormente le differenti matrici sociali che generano i due fenomeni artistici.
Foto di Claudio Casanova (Smith) e Paolo Mura (Shepp)
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.