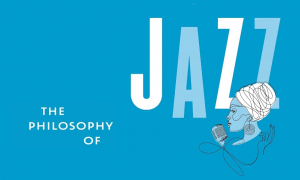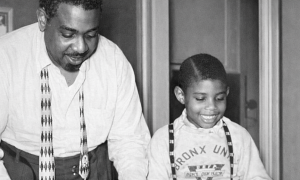Home » Articoli » Lyrics » Jimmy Giuffre: gli anni Atlantic
Jimmy Giuffre: gli anni Atlantic
All'inizio del 1956 Jimmy Giuffre firmava il suo primo solido contratto discografico, destinato a legarlo fino a tutto il 1958 alla Atlantic di Neshui Ertegun. Il suo precedente album, Tangents in Jazz, inciso nel maggio '55, era uscito su Capitol, come già quello d'esordio, intitolato semplicemente Jimmy Giuffre. Il primo con la nuova etichetta, The Jimmy Giuffre Clarinet (numero di catalogo dell'LP originale 1238) è di dieci mesi posteriore: 21 e 22 marzo 1956, presso gli Atlantic Studios di Los Angeles. All'epoca il jazz sta vivendo le "rivelazioni" del sorprendente quintetto di Chico Hamilton e di Pithecanthropus Erectus, primo compiuto capolavoro mingusiano, e in simultanea gli ultimi fuochi del leggendario Roach & Brown Inc. (Clifford Brown morirà appena tre mesi dopo, il 26 giugno), il cui Plus Four è esattamente coevo di Clarinet (22 marzo), pur uscendo a nome di Sonny Rollins, il quale si prepara al grande balzo in proprio di Saxophone Colossus (22 giungo).
In mezzo a tanti fuochi d'artificio, la timida voce che sembra levarsi da Clarinet parrebbe proprio doversi soffocare con le sue stesse mani. Non è così: a tanti anni di distanza, ci risulta sempre più arduo non inserirla fra quelle destinate a influenzare maggiormente, prefigurandolo, certo jazz nei decenni a venire, specie dalla fatidica estate parigina del 1969 in poi.
Al centro delle operazioni sta - come suggerisce il titolo - quel clarinetto che fino a un paio d'anni prima Giuffre aveva riservato alle sue perlustrazioni in area "colta," concentrandosi, in ambito jazzistico, su sax tenore e baritono, per poi riunire i tre strumenti nelle sue opere non a caso fino a quel momento più rilevanti: i citati Capitol e le sei matrici in trio con Shelly Manne, leader di The Three & the Two (Contemporary). Qui, comunque, il ricorso al clarinetto si fa esclusivo (oltre che, non di rado, elusivo), il che rivela già di per sé con quale spirito Giuffre affronti la nuova avventura discografica: entrambe le sue anime dovranno scrostare la corazza, uscendo finalmente alla luce del sole.
Giuffre parte col clarinetto, dunque. E parte solo. Immaginiamolo durante il tragitto da un capolinea all'altro di una qualunque linea metropolitana (lui preferirebbe forse una gloriosa diligenza...) nel pieno della notte, il che ci introduce oltre tutto nel clima stesso di Clarinet, che è - come vedremo - inequivocabilmente notturno. Le stazioni sono otto: dopo quella iniziale, appunto solitaria, il nostro uomo vede salire a ognuna delle sette successive nuovi passeggeri, che spesso scendono e risalgono, magari cambiando posto in vettura... Prima che il métro termini la sua corsa, in ogni caso, il nostro fantomatico viaggiatore notturno si ritroverà nuovamente solo. Anzi: al punto esatto da cui era partito.
Al di là della metafora, che comunque si svelerà da sé, ogni stazione reca il titolo di un tema. Otto, appunto: cinque di Giuffre e tre standard, la cui scelta ci è illustrata dallo stesso clarinettista nelle note di copertina. Su "Deep Purple," il primo a comparire (seconda stazione), leggiamo ad esempio: "un tema che è stato a lungo tra i miei preferiti ed è ideale per il jazz". "My Funny Valentine" (quarta stazione) è invece "una ballad veramente adatta per il jazz moderno che sembra fatta apposta per il clarinetto". Infine "Fascinatin' Rhythm" (settima stazione) "richiama nell'organico il trio di Benny Goodman, ma con un'altra pulsazione ritmica". Tutti i temi usciti dalla penna di Giuffre sono stati invece composti per l'occasione e non avranno ulteriori esecuzioni, almeno ufficiali. Nei titoli si parla di cuochi tranquilli, pastori, pifferai. Il disco, quindi, non è solo notturno: è anche domestico, rilassato, bucolico.
La partenza solitaria reca comunque il titolo, già ampiamente programmatico, di "So Low" ("così basso," "così lentamente," a prescindere dall'evidente omofonia con "solo"). Il clarinetto vi rimugina un blues ovattato, scuro, come imbavagliato. L'insistito ricorso al registro grave, del resto tipico del Giuffre dell'epoca, enfatizza questo senso di olimpica staticità, mentre il battito del piede, reso intenzionalmente udibile (nonché vagamente asimmetrico), arricchisce l'idea che l'autore vuol trasmettere attraverso il brano: quella di un musicista solo con se stesso, chiuso nella sua stanza, perso dietro a chissà quali pensieri e a divagazioni musicali conseguentemente del tutto informali.
Sale il primo compagno di viaggio: si chiama Jimmy Rowles e suona la celesta. Il tema è il citato "Deep Purple". Il clarinettista solitario sembra non accorgersi di lui: seguita nelle sue cupe elucubrazioni. La celesta, che ha qui un timbro interlocutorio fra carillon e vibrafono, dota in ogni caso l'incontro di una sia pur minima colloquialità. L'abbinamento dei due strumenti ha comunque uno spunto ben preciso: Giuffre ha amato quell'impasto dopo averlo saggiato una notte in un sottopalco (ancora un sito buio e appartato). E' singolare come, vent'anni dopo, l'abbinamento ancia/celesta ammalierà un altro grande poeta solitario: Steve Lacy [Nota 2].
Rowles, comunque, scende alla prima. Salgono in quattro: Buddy Collette, Bud Shank e Harry Klee, rispettivamente ai flauti soprano in do, alto in sol e basso, e Shelly Manne, batteria. Il tema s'intitola "The Side Pipers" ed è forse l'apice dell'album. Il clarinetto sembra come animarsi per la qualificata compagnia: guida canoni a quattro voci e ha anche un breve interludio solitario, che è poi l'unica sezione (la seconda) aleatoria del brano, per il resto tutto scritto. Nella terza sezione il clima si fa spiccatamente pastorale, mentre la quarta chiude il cerchio in maniera speculare alla prima. "The Side Pipers" è rivoluzionario anche a non considerare l'insolito organico: per l'insistito uso del contrappunto, intanto (del resto usuale in Giuffre), e poi per il fatto di essere atonale e per metà in 5/4. La batteria, infine, si pone su un piano del tutto paritetico rispetto ai fiati: quel grande maestro che è Shelly Manne la utilizza in evidente funzione non già ritmica, bensì melodica. Non usa spazzole o tamponi: solo le dita delle mani.
Altro vertice dell'album, "My Funny Valentine" fa registrare un ricambio integrale dei "passeggeri". I tre flauti vengono rimpiazzati da altrettante doppie ance (Bob Cooper all'oboe, Dave Pell al corno inglese e Maury Berman al fagotto), mentre la batteria cede il posto al contrabbasso di Ralph Peña. Vi si ribadisce in toto il clima cameristico di "The Side Pipers". Il canto è ancora appannaggio del clarinetto, mentre oboe e corno stanno ora sullo sfondo, ora in controcanto (anche fra loro) e il fagotto punteggia le note d'appoggio sulle scale, fungendo qua e là anch'esso da fondale. La melodia risulta così scomposta dal lavoro dei fiati su basi polifoniche, mentre il basso fornisce un pulsare discreto ma onnipresente. L'effetto globale è quello di un ulteriore incremento delle dinamiche rispetto al dato di partenza.
Per un Ralph Peña che rimane in vettura, la batteria di Stan Levy rimpiazza le tre doppie ance in "Quiet Cook," venendo a comporre un trio canonico, almeno per il jazz, non certo per Giuffre [Nota 3]. Il quale così descrive il brano: "Tempo molto vivo. Umore soffice, luminoso, dinamico. Ispirato a "Miss Thing" di Basie. Abbiamo cercato di "cuocere," ma a fuoco molto lento. Di qui il titolo." Sembra il testo di un telegramma, ma è la pura verità. La stazione seguente, "The Sheepherder," completa il trittico cameristico. Peña e Levy sono rilevati da Collette e Klee, ai clarinetti rispettivamente contralto e basso. Interamente scritto tranne l'assolo centrale di Giuffre, "The Sheepherder" è l'episodio più "europeo" del disco. Scarno e incruento, accentua al tempo stesso l'humus agreste della poetica giuffreiana. Persi di vista dopo le prime stazioni, ecco rientrare in gioco, approssimandosi il finecorsa, Rowles (al piano) e Manne. Terzo trio consecutivo, "Fascinatin' Rhythm," contrappuntistico (quindi geometrico) ma con un beat - poco più di un soffio - continuamente spezzettato, è un po' l'ideale sintesi tra le varie anime che convivono nel disco.
Il nostro métro notturno, frattanto, è ormai prossimo al capolinea, e in molti decidono di salire in vettura: tre suonano la tromba (Jack Sheldon, Shorty Rogers e, un po' a sorpresa, Harry Sweets Edison), altrettanti il sassofono (i già incontrati Cooper, Pell e Berman, i primi due al tenore, il terzo al baritono). In più ci sono Peña e Levy. Attraverso "un soffice, dolce suono da big band," tutt'insieme attaccano l'ultimo tema in scaletta, "Down Home". Il clarinetto conduce come sempre la danza, lasciando spazio agli ospiti per una breve chase trombettistica. Poi si accommiata e recupera il suo angolino buio: tutto solo, col suo clarinetto e il suo piede a scandire il tempo. Il métro è ormai al capolinea. Lo stesso da cui era partito quaranta minuti prima [Nota 4].
Sceso dalla vettura di Clarinet,che lo rappresenta, oltre che come clarinettista, soprattutto come compositore, ribadendo una volta di più i suoi appetiti eurocolti, Jimmy Giuffre opta finalmente, certo anche grazie alle garanzie che gli offre il contratto Atlantic, per la costituzione di un proprio gruppo stabile, un trio. Con i canonici basso e batteria? Ovviamente no. E' già tanto che uno dei due elementi - il contrabbasso, nelle mani di Ralph Peña prima e di Jim Atlas poi - sopravviva, perché di lì a poco, come vedremo, Giuffre finirà per fare a meno anche di quello. Il terzo vertice del triangolo, in un caso come nell'altro, è una chitarra. Quella di Jim Hall.
Il trio Giuffre/Hall/Peña incide un unico album ufficiale, nel dicembre 1956. Sulle note di copertina, il leader fissa le coordinate operative del gruppo, dando l'impressione di volersi schermire riguardo alla rivoluzionarietà di un tale organico. "Questo o quello strumento - scrive - passano in secondo piano rispetto a fattori tipo: 1) la nostra capacità di comunicare e convivere sul piano umano e musicale; 2) un profondo rispetto reciproco; 3) la convergenza sul tipo di musica da suonare. Ritengo che ogni combinazione di strumenti possa produrre un'espressione musicale compiuta. Non c'è nessuno strumento indispensabile, e l'integrazione di tre strumenti, per me, è l'ideale per ottenere spontaneità, equilibrio e chiarezza. Ciò che desidero è un gruppo omogeneo, non dei solisti e degli accompagnatori. Ci sono molti momenti d'assieme, ma ognuno ha anche molte chances di uscire in assolo. Direi che scrittura e improvvisazione sono fifty-fifty".
Dei nove brani incisi, sette recano la firma di Giuffre, che fissa il tutto in tre diverse sedute (3, 4 e 24 dicembre), concentrandosi nella prima unicamente sul sax tenore, nella seconda sul clarinetto, nella terza sul sax baritono con una veloce quanto sostanziale puntata anche sugli altri due strumenti. Il più rilevante dei due episodi tenoristici è "That's the Way It Is," molto mosso, spigliato, che sembra preludere agli intrecci del ben noto "The Train and the River," appunto il momento polistrumentale dell'ultima seduta. Godibilissimo, in particolare, il rincorrersi fra tenore e chitarra nella parte centrale, il tutto sempre dall'alto di una souplesse, di una leggerezza di pronuncia, invidiabili.
Se qui è il senso del movimento (il treno) del brano richiamato a essere adombrato, nel primo dei quattro temi clarinettistici, "Two Kinds of Blues," è l'inequivocabile sapore country & western (il fiume) a colpire immediatamente. "My All," che segue, sembra invece ricollegarsi, specie nell'avvio a tempo libero, da un lato al clima di Clarinet, dall'altro a certe miniature clarinettistiche del periodo a cavallo fra anni Cinquanta e Sessanta, allorché Giuffre, ormai in pratica abbandonato il baritono, sembrerà voler separare sempre più nitidamente una propria vena - appunto - clarinettistica, astratta, europeizzante, da quella tenoristica, decisamente più corporea e diretta. Tale rilievo vale anche per la successiva "Crawdad Suite," altro momento di estrema raffinatezza e rigore formale. La seduta della vigilia di Natale si discosta alquanto da quella del 4 dicembre. I brani sono tre, brevi e scattanti, con Giuffre che recupera a piene mani il baritono, protagonista assoluto in "Gotta Dance" e "Voodoo," comprimario, con tenore e clarinetto, nel brano trainante dell'album, il già citato "The Train and the River," impagabile pagina di natura quasi onomatopeica, e in ciò così squisitamente giuffreiana. Dall'impasto delle tre sedute, nella loro complementarietà di ingredienti, nasce così The Jimmy Giuffre 3 (1254), altra gemma di una discografia esemplare [Nota 5].
Sempre su Atlantic, esistono tuttavia altre matrici che, unite a una manciata di brani live [Nota 6], ci forniscono un quadro più esauriente circa il first trio di Giuffre. La prima è in realtà una medley di due temi, "Da Capo" e "Fine" (23 agosto 1957), recanti le firme, rispettivamente, di John Lewis e dello stesso Giuffre. Si tratta infatti dell'episodio che apre il celebre Third Stream Music (1345) del Modern Jazz Quartet, con ospiti (fra i quali Günther Schuller) alle cui peculiarità Lewis adatta la propria scrittura con esiti, almeno in "Da Capo," di mimesi sorprendente. Per parte sua Giuffre, che svaria su clarinetto e sax tenore, interagisce col MJQ senza frizioni di sorta. In "Fine" molto prezioso risulta in particolare il fugato conclusivo in più quadri tra pianoforte, clarinetto, vibrafono, chitarra e contrabbasso.
Sempre col MJQ, in questo caso da solo col clarinetto, Giuffre aveva già inciso un anno prima (28 agosto 1956) tre brani al Music Inn di Lenox: "A Fugue for Music Inn," ancora di Lewis, "Serenade" di Dave Raskin, di carattere squisitamente liederistico, e il proprio "Fun," squisitamente giuffreiano nell'incedere contrappuntistico, e più in generale in quel tipico gusto per il frammento, per lo spezzettamento in tanti microepisodi, che fa apparire anche un brano di cinque minuti una sorta di suite in sedicesimo. Emblematico pure l'uso della batteria, ovviamente con le spazzole, molto alla Shelly Manne. Del tutto naturale, in ogni caso, l'innesto del clarinettista sull'ormai rodato tessuto quartettistico. E appena due giorni dopo, sempre al Music Inn, Giuffre aveva inoltre incrociato il proprio strumento con - fra gli altri - Oscar Pettiford, Rex Stewart, Teddy Charles e il clarinettista a cui all'epoca più mostrava di riferirsi, specie nel timbro: Pee Wee Russell [Nota 7].
Tornando al trio con chitarra e contrabbasso, restano da segnalare le due matrici incise a New York il 2 dicembre 1957 con Jim Atlas al posto di Ralph Peña rimaste inedite fino al 1989, allorché le si è inserite come bonus tracks nell'edizione in CD di The Jimmy Giuffre 3. Vi è ribadita la dicotomia poc'anzi rilevata fra le sedute del 4 e del 24 dicembre '56: un episodio clarinettistico, "The Green Country (New England Mood)," interamente scritto, e uno tristrumentale, "Forty-Second Street," più ampio - e stemperato, se si esclude il finale, sul piano ritmico-climatico - di "The Train and the River". Identica, invece, la successione strumentale: baritono, clarinetto, tenore. Altri sei brani della stessa seduta sarebbero inoltre comparsi nel 1997 nell'integrale Mosaic di cui si parla in nota 1, il tutto - due più sei - finendo per coincidere esattamente con i temi che sarebbero poi andati a comporre l'album d'esordio del trio successivo (e con tutta probabilità proprio per questo non pubblicati a suo tempo).
Ormai di stanza a New York, Jimmy Giuffre vara infatti a cavallo tra fine '57 e inizio '58 un nuovo trio, rinunciando al contrabbasso in favore del trombone (a pistoni) di Bob Brookmeyer. Con questo organico, entra una prima volta in sala d'incisione tra il 20 e il 23 gennaio 1958 per la realizzazione di Trav'lin' Light (1282). Solo pochi giorni prima, fra il 2 e il 6 gennaio, aveva frattanto preso corpo l'ambizioso The Music Man (1276), adattamento strumentale di una commedia musicale di Meredith Wilson, le cui composizioni (e in fondo lo stesso organico, un nonetto con tre trombe, fra cui Art Farmer, quattro ance, fra cui Al Cohn, basso e batteria) risultano non sempre in linea con la poetica giuffreiana, un po' troppo dirette, esteriori come spesso sono. Le cose migliori arrivano dai momenti (non rari, né, del resto, tutti dello stesso livello) in cui la musica si sviluppa attorno al clarinetto.
Venendo a Trav'lin' Light, l'album evidenzia fin dall'avvio come il nuovo organico accentui ulteriormente (e quasi fisiologicamente, del resto) il celebre concetto giuffreiano dell'implicitazione del ritmo: come una pulsazione, a tratti solo un respiro, che ogni membro ha dentro, e deve esternare in totale sintonia con i compagni, proprio in virtù dell'assenza di strumenti preposti a una scansione oggettiva. Ciò che stacca più scopertamente la linea poetica di questo trio rispetto al precedente è ovviamente il ruolo della chitarra. Jim Hall si è così espresso in merito: "Nel primo trio, ricoprivo un ruolo intermedio fra il contrabbasso e Jimmy, soprattutto armonico, mentre con Bob Brookmeyer sono per così dire sceso di un gradino, fungendo da perno ritmico. Per qualche tempo ho anche accordato la chitarra una quarta sotto (si/mi/la/re/fa diesis/si, n.d.a.), così come ho dovuto ammorbidire il mio tocco, in quanto il colpo di plettro non piaceva a Jimmy, non impastandosi troppo bene col timbro del suo clarinetto" [Nota 8].
Dopo Trav'lin' Light, in cui si segnalano brani come la titletrack, "The Loney Time" e "The Green Country," Giuffre approda al suo progetto più schiettamente sperimentale dai tempi di Clarinet, anche perché, come là si era concentrato unicamente sul suo strumento "accademico" per eccellenza, qui si ripete sul sax tenore, non a caso partendo dall'icona ad esso più legata, "Four Brothers". Il disco, appunto The Four Brothers Sound (1295), si apre in effetti col tema omonimo, e fa una certa impressione una partenza così bruciante, in fondo su climi ormai lontani dagli itinerari giuffreiani. Il sound del titolo è assicurato dai canonici quattro tenori, nella fattispecie tutti suonati da Giuffre in un pionieristico overdubbing. In due brani, "Ode to Switzerland" e "Come Rain or Come Shine," il multitenorista agisce in totale solitudine, mentre nei restanti sette, tre originals e quattro standard, ad assecondarlo con estrema misura sono sempre Hall e Brookmeyer, quest'ultimo, però, nell'insolito ruolo di pianista.
I quattro tenori di Giuffre occupano così costantemente il centro del proscenio, portandosi dietro, come conseguenza, una prevedibile univocità climatica. Pur nella sua monoliticità, tuttavia, The Four Brothers Sound s'impone come un'opera di estremo fascino e rigore, anche a non considerare la portata fortemente anticipatrice del lavoro, squarcio verso una formula - i gruppi di soli sassofoni - destinata ad affermarsi non prima di una ventina d'anni, e invece riabbracciata da Giuffre solo pochi mesi dopo (maggio '59) nell'album Lee Konitz Meets Jimmy Giuffre (Verve), stavolta con esecutori tutti in carne e ossa (Konitz e Hal McKusik all'alto, Warne Marsh e Ted Brown al tenore, Giuffre al baritono), per l'esattezza nel brano "Darn That Dream".
A meno di tre mesi dalla seduta principale di The Four Brothers Sound, per l'esattezza il 3 dicembre 1958, il trio di Giuffre (con Brookmeyer restituito al trombone) entra per l'ultima volta in sala d'incisione per il suo capolavoro, Western Suite (1330), che segna anche il commiato tra Giuffre e Atlantic. Ma c'è ancora un altro tratto che pone l'opera tra le vette della produzione giuffreiana: il sopravvento dell'elemento western, fin dal titolo, nella dicotomia ispirativa già palesata fin dai tempi di "The Train and the River". Vi si segnala anzitutto la suite omonima, in quattro movimenti. Nel primo, "Pony Express," il tenore di Giuffre, già di per sé piuttosto atipico, risulta quanto mai "baritonale," specie nell'articolazione delle note. E' comunque la chitarra lo strumento-guida, così come nel successivo "Apaches" il trombone, con Giuffre stavolta al baritono canonico. Ancora il trombone si spartisce il comando delle operazioni col clarinetto, dalla tipica pronuncia impastata e cogitabonda, nel terzo quadro, "Saturday Night Dance". Il procedimento permane comunque eminentemente collettivo, puntualissimo nell'incastonare tre voci fra loro, del resto, perfettamente complementari. Il conclusivo "Big Pow Wow," con Giuffre stavolta tenorista di (quasi) stretta osservanza, riprende per finire il tema di "Pony Express," richiudendo mirabilmente su di sé questo capolavoro di originalità concettuale e senso empatico delle proporzioni e delle architetture intestine [Nota 9].
Il lato B dell'originario LP è coperto, tutto sommato abbastanza a sorpresa, da due temi non di Giuffre: uno standard decisamente in the tradition come "Topsy," in una versione molto riuscita, col leader al clarinetto e Brookmeyer "imbavagliato" dalla sordina sopra l'accompagnamento frusciante, con basso incorporato, di Hall, e un per l'epoca insolito "Blue Monk," con identico assortimento strumentale, sordina compresa. Due episodi importanti, in fondo nella loro stessa distanza dal resto dell'album, nonché per il fatto di mostrarci un Giuffre clarinettista ormai proiettato verso quell'esplorazione integrale dello strumento (non più ruminato sempre attorno al registro grave, cioè), quel suono più cameristico e cristallino, che segneranno la successiva stagione su etichetta Verve. Come si diceva, infatti, Western Suite chiude il ciclo Atlantic, cui seguirà un felice approdo alla scuderia di Norman Granz, un'isolata incisione Columbia e poi, a partire dal 1963, un lungo silenzio da cui Giuffre riaffiorerà solo negli anni Settanta, anche se di lui, di fatto, si tornerà a parlare con una certa insistenza non prima della sua conversione al jazz elettrico, nei primi anni Ottanta, e più ancora col recupero dell'antico trio con Paul Bley e Steve Swallow, all'inizio dei Novanta. Con tale organico, nel 1995, Jimmy Giuffre sarà protagonista delle sue ultime apparizioni pubbliche. Poi la malattia, la lenta agonia che ce lo porterà via il 24 aprile 2008. Queste pagine vogliono di conseguenza essere anche un sia pur minimo omaggio postumo a un artista grande, spesso geniale, e forse fin troppo in fretta dimenticato da molti (almeno così pare).
______________________________________
Note
1) Risulterà curioso notare come nell'occasione si auspicasse la riedizione in CD del materiale oggetto del saggio da parte della Rhino, all'epoca adusa a riunire in preziosi box gli integrali Atlantic (Mingus, Coltrane, Coleman...). La cosa si sarebbe di fatto concretizzata fin dall'anno seguente (1997), però ad opera della Mosaic, in The Complete Capitol and Atlantic Recordings of Jimmy Giuffre, box di 6 CD (o 10 LP) allargato alle appena precedenti incisioni Capitol cui si accenna anche nel nostro testo.
2) "Hemline" e "Feline," in Straws, Cramps, novembre 1976. Alla celesta è lo stesso Lacy, in sovraincisione.
3) Di trii con basso e batteria, si ricordano soltanto quello (peraltro fugace) di metà anni Sessanta con Richard Davis e Joe Chambers, e soprattutto quello del decennio seguente con Kiyochi Kunaga e Randy Kaye protagonista di due album per la Choice: Music for People, Birds, Butterflies & Mosquitoes (1972) e The Train and the River (1975).
4) Varrà la pena di notare come la seduta di Clarinet si apra in effetti con "So Low," per chiudersi con "Down Home". In mezzo, però, la sequenza è la seguente: ""Deep Purple," "The Sheepherder," "The Side Pipers" e "Fascinatin' Rhythm" il 21 marzo; "My Funny Valentine" e "Quiet Cook" il 22. Dando un'occhiata agli avvicendamenti in organico, si noterà come il "travaso di passeggeri" sia quindi nella realtà ben più diluito di quanto non appaia seguendo l'ordine del disco, che qui si è ritenuto di rispettare.
5) L'ordine dei brani scelto per il 33 giri originale è il seguente: "Gotta Dance," "Two Kinds of Blues," "The Song Is You," "Crazy She Calls Me," "Voodoo," "My All," "That's the Way It Is," "Crawdad Suite," "The Train and the River". Due trittici baritono/clarinetto/tenore con altrettante postille clarinettistiche, quindi, ed epilogo polistrumentale (peraltro con identica sequenza: baritono, clarinetto, tenore).
6) Tre, datati 7 gennaio 1957, editi dapprima su Calliope CAL-3012 e poi, con l'eccezione di "Two Kinds of Blues," nel 1983 in Trios Live 1957-1958, Raretone 5013-FC; un quarto, "The Train and the River," con Jim Atlas per Ralph Peña, su Columbia JCL-1098. Quest'ultimo brano, datato 5 dicembre 1957, proviene dal celebre lungometraggio The Sound of Jazz.
7) Gli album contenenti il materiale citato sono rispettivamente The Modern Jazz Quartet at Musica Inn (1247) e Historic Jazz Concert at Music Inn (1298).
8) In "Musica Jazz," aprile 1993.
9) Si legga al proposito anche l'accurata analisi presente in PIRAS, Marcello, La "Western Suite": a ovest di Paperino, "Musica Jazz," marzo 1987.=
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.