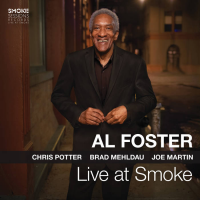Home » Articoli » Lyrics » Intervista all'Ex Novo Ensemble. Conversazione con Aldo Orvieto.
Intervista all'Ex Novo Ensemble. Conversazione con Aldo Orvieto.
Di particolare rilievo, il contributo alla promozione della musica cameristica italiana del primo '900 e contemporanea dimostrato dalla lunga e intensa collaborazione con etichette discografiche quali Arts, ASV, Black Box, Dynamic, Stradivarius, Ricordi, Naxos ed altre. Dal 2004, l'Ensemble organizza al Teatro La Fenice di Venezia il Festival Ex Novo Musica, rassegna di musica contemporanea e nuove forme di spettacolo che vedrà quest'anno la sua ottava edizione. Ne abbiamo parlato con Aldo Orvieto.
All About Jazz: Cominciamo dalla domanda più banale: cos'è per te un ensemble?
Ex Novo Ensemble: Non credo sia una domanda banale. In Italia, il progetto di "far musica insieme" non cresce in modo naturale, dunque di pari passo con la formazione musicale individuale, ma appartiene ad una scelta successiva, matura e consapevole: l'equilibrio che consente il "suonare insieme" si risolve pertanto nell'individuare il possibile progetto al quale possano convergere le personalità già fortemente delineate dei membri del futuro ensemble. L'isolamento che caratterizza la formazione degli artisti italiani, si coniuga con un'altra non meno grave forma di scissione: spesso infatti i musicisti di formazione classica avvertono di sentirsi esclusi dalla vita culturale contemporanea. Su tale tema si potrebbe aprire un dibattito interessante innervato da molte implicazioni sociologiche, in quanto il far musica d'insieme rispecchia la dialettica tra la necessità e la "sofferenza" dell'individuo per la vita sociale. Per concludere, vorrei precisare che tali mie considerazioni non desiderano connotare negativamente tali percorsi artistici di cui spesso si constata la prolificità; ma solo rilevarli come certamente singolari e direi tipici del nostro paese.
AAJ: Hai voglia di raccontare come, quando e dove si è formato il vostro Ensemble? Come e perché avete scelto il nome Ex Novo?
E.N.E.: Spesso i nomi dati ai gruppi sono dettati da circostanze occasionali. Nulla di più occasionale del nome Ex Novo Ensemble che fu scelto dal compositore veneziano Claudio Ambrosini quando nel 1979 fondò il gruppo insieme a cinque musicisti, allora giovanissimi (io ero uno di quelli!) che tuttora ne fanno parte. Verso la fine degli anni '70 Ambrosini conosceva le prime esecuzioni dei propri lavori ed era tormentato dalla difficoltà di costruire un gruppo stabile di strumentisti che recepissero il valore della sperimentazione sui nuovi linguaggi.
Gli ensemble come sappiamo si edificano affinando l'intesa tra i musicisti; tale processo necessita di una sorta di azione di filtraggio, quasi una selezione naturale delle personalità che possono venir accolte dal gruppo. Le prime esperienze concertistiche hanno dunque una funzione fortemente costruttiva. Il nome Ex Novo è lo specchio di tale fase che potremmo definire "costituente". Fu scelto, con una forte dose di estemporaneità, in quei primi periodi di attività, quando si aveva spesso l'impressione di ricominciare sempre da capo il lavoro di armonizzazione delle diverse personalità tra i componenti dell'ensemble. Un'altra non meno importante motivazione fu il tipico furore iconoclasta di quegli anni in cui si era convinti che solo una netta frattura con gli stilemi tardo romantici avrebbe consentito il formarsi di una nuova sensibilità timbrica e una autentica ri-fondazione interpretativa.
AAJ: I presupposti che vi hanno portato a unirvi sono gli stessi sui quali ancora oggi basate il vostro legame?
E.N.E.: La nostra storia musicale è iniziata come quella di un gruppo da camera di matrice classica: un quartetto d'archi, per esempio, che inizia un percorso di studio impegnativo, fin dagli anni della formazione. La nostra scelta aveva però fin dagli esordi un forte tratto di utopia, in quanto il nostro organico originario (sostanzialmente quello usato da Arnold Schoenberg nel suo "Pierrot lunaire") aveva poca letteratura e cominciava solo allora ad essere frequentato dai compositori contemporanei. Puntare su questo organico strumentale è stata una sfida: direi vinta poiché negli ultimi trent'anni il modello di ensemble misto con fiati, archi e pianoforte ha avuto un grande sviluppo ed è diventato forse l'organico strumentale più usato dai musicisti contemporanei. Un sodalizio di così lunga durata si realizza superando insieme le difficoltà, come accade in ogni relazione interpersonale. Gli elementi che connotano il nostro trentennale sodalizio sono: lo studio costante anche quando non sono programmati concerti; il riunirsi e il discutere su ogni argomento inerente la nostra attività. Il gruppo conserva da trent'anni queste abitudini per sentirsi vivamente impegnato nella costruzione dei suoi progetti futuri.
AAJ: Per quanto riguarda il repertorio, come lo scegliete e come lavorate per l'esecuzione.
AAJ: L'Ex Novo Ensemble è cresciuto artisticamente mediante le collaborazioni e i progetti che si sono attuati in trent'anni di attività concertistica; la sua odierna professionalità e dunque figlia dei rapporti vivificanti che ha avuto con i molti grandi compositori che ha avuto il privilegio di conoscere e con cui ha assiduamente lavorato. Come ben sappiamo, la musica contemporanea propone spesso un linguaggio quasi proprietario, e i compositori tengono a circoscrivere il proprio mondo sonoro a partire dall'uso di specifiche tecniche strumentali. Per un interprete diventa dunque sostanziale sviluppare una maestria strumentale che egli vede crescere di pari passo con le richieste della musica che si impegna ad eseguire. Questa caratteristica di "perenne autoformazione" ha del resto sempre caratterizzato la vita degli interpreti.
Spesso si guarda al periodo classico-romantico come ad momento "miracoloso" e irripetibile della storia della musica nel quale si attuò - per un periodo che si usa circoscrivere nella durata di circa un secolo - la forte condivisione di un linguaggio, il cosiddetto sistema tonale. Quasi per incanto tale condivisione deflagrò, nei primi anni del '900, dando luogo alla teorizzazione di molti nuovi modi di comporre musica; in particolare il sistema dodecafonico sembrò poter rappresentare un nuovo grande collante tra i molti linguaggi che si andavano sperimentando; ma come sappiamo fu solo un'utopia!
La schematizzazione che ho (forse troppo) brevemente tratteggiato non è solo antistorica ma ha creato una forte pregiudiziale: quella della necessità di una "doppia fase" per il comporre. Una fase "preliminare" in cui il compositore si attrezza costruendo un linguaggio sonoro che vorrebbe "unico e irripetibile" e che lo distingue dagli altri attori sulla scena; una seconda fase nella quale l'artista "compone" cioè crea una forma per la sua musica. In un certo senso l'interprete è dunque parso a molti autori un anello essenziale per testare il linguaggio che egli andava creando. Gli interpreti hanno in questo modo potuto entrare nel vivo del comporre musicale (anche se, potremmo dire, dalla "porta di servizio"), capirne le problematiche e appropriarsene, divenendo sempre più in grado di affrontare l'analisi delle composizioni contemporanee. In un certo senso si potrebbe dire che, se nella prima metà del Novecento l'interprete ha assunto un ruolo più specifico allontanandosi dalla figura di compositore-interprete tipica del mondo ottocentesco (da Kreisler, a Rachmaninoff, mille sono gli esempi che si potrebbero portare) nella seconda metà del Novecento se ne è riappropriato proprio in funzione delle problematiche cui prima accennavo.
AAJ: Che cosa vi interessa maggiormente mettere in luce della musica del Novecento? Quali sono gli aspetti sui quali voi come Ensemble ritenete di dover maggiormente lavorare?
E.N.E.: Il fatto di essere giunti ad una certa padronanza del mestiere ci consente oggi di porci di fronte ad una partitura appena ultimata con la medesima lucidità di indagine con la quale ci si pone di fronte ad una partitura del passato, più volte analizzata e studiata. Trovare uno schema metodologico che superi le barriere che normalmente antepongono la conoscenza di uno stile (o se si vuole di un genere) alla conoscenza intrinseca del fatto musicale permette di toccare con mano quanto sia difficile sviscerare il pensiero di un compositore (e più grande è la sua statura spesso più problematica risulta la penetrazione nel suo mondo) e quanto prolifico sia sviluppare tale capacità di analisi. Se queste indagini sono svolte in modo dialettico tra i componenti dell'Ensemble e in funzione di un attività concertistica - dunque sul campo - diventano ovviamente particolarmente affascinanti.
AAJ: Cosa significa per voi improvvisare? L'improvvisazione è una pratica del vostro fare musica insieme? Nel caso, come avviene e quanto peso ha nel vostro lavoro?
E.N.E.: Pur non facendo parte, in senso stretto, del mondo dell'improvvisazione, ci siamo trovati in molte occasioni a organizzare le esecuzioni musicali che ci venivano affidate (per esempio da autori come Sylvano Bussotti o Alvin Lucier) prendendo importanti decisioni sul come organizzare i materiali forniti dalla partitura. Questo tipo di lavoro confina ovviamente con un approccio in qualche modo improvvisativo, anche se il processo è fortemente guidato dalla regole imposte dal testo.
AAJ: ... e per quanto riguarda l'elettronica?
E.N.E.: La storia dell'Ex Novo Ensemble è stata fin dagli anni '80 legata a quella di importanti laboratori di musica elettronica e all'irripetibile rapporto di amicizia dell'ensemble con Alvise Vidolin, l'ingegnere-musicista che assistette molti grandi compositori italiani nelle realizzazioni delle loro opere elettroniche (Nono, Sciarrino, Berio, solo per citare alcuni nomi), rapporto continuativo e sempre prolifico. L'Ex Novo Ensemble è stato l'ensemble di riferimento per le produzioni da camera del CSC (Centro di Sonologia Computazionale dell'Università di Padova) e della sua filiazione odierna: il laboratorio SaMPL, del Conservatorio "Cesare Pollini" di Padova, che nasce nel 2009 per iniziativa di Nicola Bernardini, di Alvise Vidolin e mia; il laboratorio propone una concezione nuova di impegno culturale che coniuga - con legami forti - didattica, ricerca e produzione musicale a vantaggio di un florilegio di forme artistiche che cercano espansione nelle più diverse declinazioni linguistiche del fatto musicale.
AAJ: Una delle attività che vi contraddistingue sono le produzioni commissionate a compositori stranieri e italiani. Mi piacerebbe capire quali sono stati i progetti che vi hanno maggiormente coinvolto o che sono stati maggiormente formativi nel vostro percorso di ricerca.
E.N.E.: Crediamo nell'attività propulsiva che possono avere gli ensemble nel commissionare nuovi lavori. Un primo gruppo di opere che oggi sono presenti nel repertorio degli ensemble a livello internazionale sono state commissionate dall'Ex Novo Ensemble intorno al 1985: opere come "Lo spazio inverso" di Salvatore Sciarrino, "Scherzo" di Aldo Clementi, "De vulgari eloquentia" di Claudio Ambrosini. Dico "commissionate" tra virgolette in quanto più che commissioni in senso stretto si possono considerare veri e propri doni che gli autori hanno voluto fare all'Ex Novo Ensemble! Proprio per contraccambiare in qualche modo questi doni musicali è nato nel 2004 il Festival Ex Novo Musica, che vedrà quest'anno la sua VIII Edizione al Teatro La Fenice di Venezia.
AAJ: Il pubblico è importante? E in che forma, dimensione, misura...?
E.N.E.: La sua domanda mi aiuta a descrivere l'avventura di Ex Novo Musica, un progetto di impaginazione nuova di concerti che unisce la rilettura del grande repertorio, le scoperte musicologiche, la commissione di opere nuove, nel contesto di serate che si propongono più vaste direzionalità culturali, e indagini il cui interesse superi le isole specialistiche. Nel presente la creatività e l'innovazione si offrono ad un ritmo molto più veloce che nel passato. Se da un lato è dunque importante sollecitare curiosità e creare nuovi stimoli d'ascolto, è a nostro avviso altrettanto importante offrire quei codici di lettura (riscontrabili in ogni musica di ogni tempo!) che consentano all'ascoltatore di contestualizzare le proprie passioni e di tessere sinergie vivaci e creative.
Nel Festival Ex Novo Musica 2011 sono state presentate quindici opere in prima esecuzione assoluta: sono davvero molte per un piccolo organismo indipendente che gode di modeste risorse. Noi stessi nutriamo fervida riconoscenza verso gli autori, alcuni dei quali di altissimo rilievo internazionale, che hanno offerto magnifici doni a Ex Novo Musica. Mi limito a citare alcuni dei grandi artisti che hanno onorato l'edizione 2011: Fabio Nieder, Luis De Pablo, Ivan Vandor.
AAJ: Dal punto di vista economico, come avete provveduto fino ad ora a finanziare i vostri progetti? Quali margini di autonomia avete rispetto a chi/coloro che vi sovvenziona/no?
E.N.E.: L'attività dell'Ex Novo Ensemble si può dire economicamente "compensativa": se da un lato acquisisce risorse vendendo le proprie prestazioni concertistiche, dall'altro tenta di ridistribuirle con grande parsimonia tenendo conto non solo - ovviamente - di offrire un compenso ai musicisti che vi lavorano ma anche di offrire alla città di Venezia il Festival Ex Novo Musica, dieci eventi che si articolano nel periodo autunnale e che non sarebbero realizzabili con le modestissime risorse offerte dal sostegno pubblico all'iniziativa. Il Festival non vuol essere in alcun modo concorrenziale alla Biennale Musica ma si propone di sperimentare forme nuove di spettacolo che accolgano molti e diversi gusti musicali in una cornice in cui protagonista sia sempre - e direi solo - la musica con la sua fitta trama di relazioni; sfida in cui si dà predominanza assoluta al 'significante' poiché la musica - come afferma Jankélévitch - "non significa niente, se non per associazione o convenzione"; e ogni troppo esplicita referenzialità deve essere elusa per non rischiare di spezzare la suggestione creata dalla trama dei suoni.
AAJ: Portate avanti un lavoro teorico (letture, discussioni sulla metodologia, studi o ricerche, seminari) a livello di Ensemble oppure la formazione e la ricerca sono un percorso individuale da condividere solo in un secondo momento insieme?
E.N.E.: Il "far musica" è una dimensione prevalentemente non razionale al quale l'artista giunge dopo un lento processo di dialettica interiore tra autocontrollo e istintualità; la coralità del "far musica insieme" deve perciò convogliare i plurimi equilibri degli individui in un processo che suona organico ad un ascolto esterno. Solo una profonda conoscenza, discussione, rispetto delle specifiche individualità conduce all'attenuarsi di ogni radicalismo, condizione questa essenziale per raggiungere veramente un suono e un sentire comune.
AAJ: Qual è il campo di ricerca musicale imprescindibile per un ensemble che si occupa di musica contemporanea?
E.N.E.: Per l'Ex Novo Ensemble il maggior impegno è sempre stato rivolto all'ascolto di musica nuova delle più diverse estrazioni e provenienze culturali. Molti compositori infatti ci inviano partiture e documentazione audio-video dei loro lavori per far conoscere il proprio percorso artistico. La rete offre poi grandi possibilità di approfondimento di mondi e culture musicali che fino a pochi anni or sono risultavano difficilmente accessibili. La creazione di un repertorio di autentico interesse per un ensemble rimane dunque legata alla curiosità e alla sete di conoscenza che i suoi membri esprimono e condividono.
AAJ: Vi appoggiate ad una casa discografica? Ne avete fondata una vostra?
E.N.E.: L'Ex Novo Ensemble ha ad oggi pubblicato una trentina di dischi per case discografiche di rilievo internazionale (da Arts a Naxos, a ASV Records, a Black Box) che rispecchiano gli interessi musicali del gruppo, particolarmente aperti a tutte le esperienze musicali. Sono presenti sul mercato raccolte di opere recenti di autori contemporanei che hanno assiduamente collaborato con l'Ensemble (Ambrosini, Sciarrino, Bussotti, Clementi, e molti altri), monografie dedicate a grandi figure dello storia della musica italiana recente (Rota, Maderna, Berio, Togni) o dei primi decenni del Novecento (Malipiero, Casella, Respighi, Busoni, Wolf-Ferrari). L'impegno portato nell'approfondimento del linguaggio musicale contemporaneo è divenuto punto di partenza per la rilettura del repertorio classico (di rilievo una monografia schubertiana in due volumi pubblicata da Classic Voice nel 2009) e di alcune pagine affascinanti e tuttora poco note destinate ad organici rari (Rossini, Donizetti).
AAJ: Pensi che ci sia una politica in Italia attenta agli Ensemble e/o su cosa dovrebbe sostenere realtà come la vostra la politica (locale, nazionale)?
E.N.E.: Tutti sanno che i grandi ensemble europei sono stati sostenuti dai Ministeri della Cultura dei rispettivi paesi e hanno dunque possibilità ben diverse da quelle dei gruppi italiani. Struttura e capacità manageriale sono qualità imprescindibili se si vuol entrare a far parte dei protagonisti della rete culturale mondiale. L'Ex Novo Ensemble, come anche altri gruppi italiani, pur essendo ben noti all'estero per le loro performance di grande livello artistico, mancano di quel sostegno che potrebbe davvero imporli tra le entità artistiche di primo livello nel mondo.
AAJ: Un ensemble è un archivio di memoria storica musicale oppure, diversamente, lavora sul vivo della musica intervenendo nella quotidianità in tempo reale?
E.N.E.: Trovo stimolanti entrambe le definizioni, ma non le sento alternative. Afferma Italo Calvino che "classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire". Solo chi consapevolmente si colloca in questo solco riesce a superare le gabbie critiche e rivisitare costantemente la musica del passato rilanciandola nel contemporaneo. Come spiega con grande acume Mauricio Kagel (con il quale l'Ex Novo Ensemble ha lavorato nei suoi ultimi mesi di vita per una versione di Ludwig van, presentata alle Settimane Mahler di Dobbiaco nel 2008): "La nostra concezione di fedeltà al testo - soprattutto quando si tratta di musica dei secoli XVIII e XIX - deve essere rivista. Gli sforzi disperati per far ancor meglio conoscere dei pezzi già molto noti hanno per risultato, nell'interpretazione della musica classica, una tendenza alla moderazione e al bon ton. Al di là delle singole opere è la sostanza del messaggio dei Maestri che bisogna interpretare."
Proprio per questo la nostra rassegna Ex Novo Musica non propone mai percorsi univoci, monografici, storici o stilistici; neppure tentativi di codificare le tendenze artistiche in "musica d'uso," "musica di confine," "musica etnica," "musica d'avanguardia," "musica colta". La rassegna accoglie tutte le tendenze provocando tra le epoche e gli stili un salutare corto circuito che accolga tutte le informazioni acustiche dell'ieri e dell'oggi. Tutto questo non per scardinare il sistema di coordinate fondato sulle conoscenze e le esperienze del passato, ma per stimolare chi desidera confrontarsi con il nuovo.
AAJ: La frase citata di Kagel (interessante) impone un approfondimento. Fedeltà e testo sono due cardini apparentemente solidissimi e indistruttibili della musica, anche contemporanea. Come affrontare la questione? Come scardinarli?!
E.N.E.: Gliene propongo subito un'altra, dalla quale iniziare a discutere: "Nel corso della vita i grandi interpreti diventano compositori dell'interpretazione, rispecchiando alcuni processi che il compositore stesso ha esperito, nella scelta e nel modo di plasmare i mezzi (...) Se accettiamo questa prospettiva come una dimensione particolare dell'esecuzione, allora l'interpretazione può diventare estremamente stimolante, perché il pezzo può essere affrontato in modo sempre diverso. Qualsiasi brano di grande musica avrebbe potuto essere formulato anche in maniera differente. (...) La grande musica suscita sempre milioni di domande, e a queste domande si abbarbica il dubbio che si annida dove coesistono molteplici possibilità."
Queste sagge parole ci svelano che le discussioni intorno ai principi della "fedeltà al testo" hanno origine in un problema mal posto. Il testo musicale non può essere assimilato ad un "reperto archeologico" di segni scritti che abbisognano di codici specialistici per venir letti, ma deve venir visto come un testimone (sempre incompleto) che il compositore ci consegna nella speranza che la nostra ricerca ci conduca a vivificare la sua musica. Ferruccio Busoni (artista oggi senza ragione dimenticato) sosteneva che la notazione fosse "già trascrizione di un'idea astratta," e che fosse opportuno affrontare l'interpretazione come atto di ri-creazione, dunque vantaggioso ripercorrere, per quanto possibile, gli stessi tracciati mentali del compositore nell'atto creativo. Per concludere: temo che spesso non ci si renda conto che l'autentica "fedeltà al testo" consiste nella capacità di articolare domande, non in quella di dare univoche risposte!
AAJ: Lavorate anche per fare formazione ai giovani? È importante e in quale misura il coinvolgimento delle istituzioni (conservatori, scuole musicali etc.)?
E.N.E.: Nato nel contesto del Festival Ex Novo Musica il progetto "Nuova musica per nuovi musicisti" si situa nell'ambito della didattica delle prassi esecutive della musica contemporanea. Numerosi giovani musicisti diplomati presso i Conservatori veneti, sono stati invitati in questi anni a partecipare ad alcune produzioni del festival; tale progetto ha dato loro opportunità di collaborare con solisti di chiara fama e con l'Ex Novo Ensemble. Il principio è sostanzialmente quello di avviare un processo di "continuità generazionale" per la prassi esecutiva della musica contemporanea.
AAJ: Vorrei approfondire le incisioni monografiche che avete realizzato su alcuni compositori italiani, penso a quelle dedicate a Camillo Togni, Emanuele Casale, Michele dall'Ongaro. Uscendo dal seminato dei soliti noti (si fa per dire), come avete lavorato per realizzare queste monografie?
E.N.E.: Nel caso di Camillo Togni è stata autentica curiosità intellettuale. Non l'abbiamo mai incontrato (è scomparso nel 1993) ma molti ce ne hanno parlato come di un musicista riservato, quasi schivo, dalla sconfinata sapienza e cultura. Stimatissimo tra gli addetti ai lavori, la sua musica era (ed è) raramente eseguita. La sua adesione al sistema dodecafonico (che Togni abbracciò fin dai primi anni '50) lo ha relegato, nonostante l'indubbio valore della sua musica, "tra parentesi" nel contesto delle avanguardie che hanno percorso la seconda metà del Novecento. Noi abbiamo voluto andare a vedere di che si trattava e, grazie alla presenza a Venezia del "Fondo Camillo Togni" presso la Fondazione Giorgio Cini, abbiamo analizzato molta sua musica tracciando con questo disco un percorso artistico di sue opere da camera dal 1950 al 1981.
Diverso è il caso di Emanuele Casale e Michele dall'Ongaro, autori che stimiamo e che eseguiamo spesso in concerto: i dischi che abbiamo loro dedicato costituiscono al tempo stesso un nostro segno di stima e una documentazione del lavoro di ricerca condotto insieme.
AAJ: Claudio Ambrosini è evidentemente uno dei compositori a voi più vicini (per questioni geografiche, ma anche per affinità sonore, se si può dire). Che lettura date del suo repertorio?
E.N.E.: È forse questa la domanda più difficile! Bisogna considerare che, in particolare nel suo primo decennio di vita, l'Ensemble è cresciuto in parallelo alla genesi della vasta produzione cameristica di Ambrosini di quegli anni. Noi leggevamo i suoi brani dai manoscritti e ne conoscevamo si può dire tutte le fasi di lavorazione: una collaborazione artistica senz'altro privilegiata e affascinante, che ci ha insegnato molto, poiché attraverso di essa siamo giunti ad afferrare i cardini, i punti nodali, a cui tiene un compositore quando la sua musica si concretizza in suono nelle mani di un interprete. È un tema difficile da sviscerare: ma può accadere che, di fronte ad una partitura, l'autore e i suoi interpreti si trovino a pensare percorsi realizzativi molto differenziati se gli interpreti non sanno cogliere, quasi istintivamente, la "visione del suono" che sprigiona dalla partitura. Proprio perché, come diceva Kagel, questo è un tipico caso di interpreti che "diventano compositori dell'interpretazione" ci dobbiamo obbligatoriamente sollevare da un giudizio critico!
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.