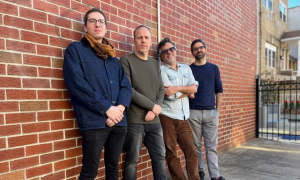Home » Articoli » Lyrics » Il jazz come Grande Altro della musica occidentale
Il jazz come Grande Altro della musica occidentale
In un certo senso, tutto inizia con Solone. Nella seconda parte del prologo drammaturgico del Timeo si racconta infatti la storia del famoso legislatore, che dopo aver redatto la costituzione per gli ateniesi si reca in Egitto per incontrare i sacerdoti dell'antica città di Sais. Curioso di carpirne i segreti, volutamente provoca la loro reticenza raccontando in modi fantasiosi dell'origine del mondo e delle genealogie degli uomini. Come previsto, uno dei sacerdoti finisce per rivolgergli un sorriso di compatimento, passando a spiegargli come l'origine del mondo non stia nelle ingenue storie da lui raccontate, ma si trovi iscritta nelle pareti e nelle colonne dei templi di Sais. Le conoscenze dei greci sarebbero dunque ben poca cosa, simili alle favole per fanciulli, se rapportate alla sapienza egizia.
La vicenda serve a Platone per introdurre la propria cosmologia e, soprattutto, per rovesciare il discorso del sacerdote, mostrando come i greci si pongano al di fuori dell'antica tradizione sapienziale, collegata all'oralità e supportata da un codice di incerta o equivoca decifrazione: le immagini dipinte e i geroglifici. Con l'invenzione della filosofia essi infatti affidano la trasmissione del sapere a un medium del tutto nuovo: la scrittura alfabetica. Ciò determina una cesura destinata a mutare il corso della storia, ancorché lo stesso Platone affermi che il primato della dialettica implica la superiorità del discorso orale sul discorso scritto, che la scrittura è solo una mnemotecnica, e che ogni testo rimane sterile finché non risuona in una voce. E nonostante egli sostenga di aver affidato la parte più importante del proprio messaggio alla voce di quelli che Aristotele avrebbe poi chiamato gli agrapha dogmata, gli insegnamenti non scritti. Poiché, di fatto, da allora in poi la filosofia verrà considerata come la manifestazione esclusiva di una ragione grafica, ovvero di un logos che progressivamente svaluta la dimensione della comunicazione orale in quanto incapace di giungere alla verità. Sicché la verità si affermerà in quanto vera conoscenza, o episteme, facendo corpo con il discorso razionale, quello che procede per idee chiare e distinte e del tutto separato dal discorso comune, dall'opinione o doxa, che veicola una conoscenza falsa o apparente.
Così la scena madre del discorso filosofico, dunque del pensiero occidentale, si inaugura screditando i valori di cui è portatrice l'oralità, o quanto meno relegandoli in secondo piano, e contrapponendovi quelli inaugurati dalla scrittura. Piano piano, proprio la pratica della scrittura, e quella correlata della lettura, produrranno l'abito mentale che noi diciamo "scientifico", cioè analitico e distaccato: distaccato prima di tutto dalla vita, la quale non ci consente alcuna separatezza, alcuna possibile a-patia. Certo non possiamo imputare a Platone di non aver colto appieno l'importanza della soglia costituita dalla pratica alfabetica, di non aver visto il problema, poiché dobbiamo ricordare che egli ancora condivide la paideia di una oralità "primaria", ineluttabilmente destinata a scomparire; dobbiamo cioè ricordare, con le parole di Carlo Sini, che "il suo è il gesto inaugurale della filosofia, della episteme filosofica, che genera da sé la sua ombra o il suo impensato. Platone è preso dalla sua passione e ne è soggetto". Dobbiamo tuttavia, almeno per quanto riguarda il nostro discorso, provare a valutarne le conseguenze.
Fra le quali, e certo non secondaria, il fatto che alla promozione della ragione grafica si accompagni la necessità di mettere sotto osservazione le pratiche che ad essa non si conformano. Ad esempio le pratiche artistiche, pericolosamente vicine alla kora o matrice primigenia, alla sfera della motilità ritmica e pulsionale che precede il linguaggio, e dunque difficili da recuperare ai fini dell'educazione del cittadino e dell'edificazione della polis. Nel decimo libro della Repubblica, infatti, Platone svaluta l'atteggiamento mimetico e immaginativo degli artisti interpretandolo come frutto di immaturità, e sostiene che per divenire adulti, dunque per filosofare, occorre "separare l'anima dal corpo", e rifiutare le sollecitazioni provenienti dal mondo sensibile perché ingannevoli. Occorre insomma far tacere i sensi, separandosi da essi e sbarazzandosi del loro supporto carnale in quanto ostacolo al procedere del logos.
Già al suo sorgere, dunque, la filosofia si trasforma in una sorta di ortopedia dell'esistenza. E il dualismo così inaugurato - fra anima e corpo, idea e materia, essenza e contingenza e, ovviamente, oralità e scrittura - affidando il discorso di verità al medium della scrittura finisce per assegnare una sorta di supremazia allo sguardo, il più 'astratto' dei sensi. E invero, se la modernità pare costituirsi sotto il segno dello sguardo è proprio perché Platone assegna alla vista un privilegio mai più messo in discussione, in grado di influenzare il cammino della filosofia al punto che esso appare leggibile come un'ininterrotta apologia della visione.
In fuga dalle sottili seduzioni della phone, intento a devocalizzare il proprio discorso riducendolo ai termini di una razionalità visiva, Platone è ovviamente indotto a compiere il passo successivo: neutralizzare la potenza emotiva della musica. Poiché quella dei suoni è senza alcun dubbio un'arte eccessiva, nell'antica Grecia, in quanto accompagna la dimensione orfica e dionisiaca delle espressioni del sacro. Proprio per questo Platone la ritiene pericolosa per il vivere civile, e la relega ai margini della polis. Proprio per questo egli abbandona l'esperienza dei sensi in favore di una conoscibilità tutta testuale, che assorbe in sé la rappresentazione stessa del suono, ovvero delle infinite trasmutazioni che lo rendono riconoscibile. Per acquisire i caratteri della stabilità e della permanenza, la conoscenza platonica deve infatti modellarsi sulla rappresentazione visiva del nome che dice la cosa, e questa sua natura tipografica, che non può prescindere da una rappresentazione visiva, proseguendo la sua strada (che è poi quella della metafisica) è giunta fino a noi quale metafora dell'atteggiamento teoretico in generale.
Dopo di che, e non a caso, la trasmissione della musica in occidente verrà codificata attraverso la notazione musicale, forma di scrittura che impone di 'leggere' i suoni per poterli eseguire. Congiungendo ritmo e armonia secondo le leggi derivate dalla numerologia pitagorica, e separandola dal suo vissuto acustico, la musica diventa così un ambito che si presta ad essere regolato da precise norme. Si tratta di un vero trionfo dell'optocentrismo platonico e della superiorità da lui assegnata alla visione: la musica, arte del tempo, si tramuta in arte dello spazio, lo spazio della partitura, che proprio per la sua natura scritturale può essere letto e riletto, studiato e misurato.
Fra le altre, è certamente questa una delle ragioni per cui in occidente, seppur fra mille distinguo, si tende a separare "musica colta" e "musica popolare", considerando la prima oggetto di un pensiero musicale evolutivo, sottoposto a una logica matematizzante e speculativa, la seconda manifestazione di emozioni e sentimenti ancora in parte non formalizzati, dunque in-formi e per ciò stesso pericolosamente vicini alla kora. Alla musica come istanza apollinea, la cui bellezza rientra negli ordinamenti controllati dal discorso raziocinante, si contrappone la musica come momento dionisiaco, liberazione degli istinti e dominio della phone. Dunque, come insegna la storia di Marsia, che con il suo flauto sfidò la cetra di Apollo rimanendone sconfitto e venendo poi scorticato per punizione: c'è musica e musica, ovvero non tutti gli strumenti si equivalgono, nell'immaginario greco e nel progetto platonico Se la cetra serve ad accompagnare il canto e a veicolare significati, sollecitando la parte poetica dell'anima, il flauto fa perdere il senno e scatena pericolose passioni: "Le melodie del flauto di Marsia - scrive Platone - producono sensazioni tali che io, come molti altri, ne sono inquietato". In quanto prolungamento della bocca, esso infatti è troppo simile alla voce, poiché chi lo suona rinuncia alla parola e sceglie di evocare un mondo in cui predominano le emozioni e il godimento della sfera acustica.
Tale distinzione - che non è difficile vedere rappresentata nel pensiero musicale europeo, soprattutto a partire dal sorgere della musicologia settecentesca - non è affatto casuale, nella sua artificialità, poiché squalificando il lato oscuro della musica, la sua capacità di esistere senza 'dire' o affermare qualcosa, altro non fa che operare una rimozione che percorre quasi per intero la sua storia. Non potendo impedire che il mondo dei suoni riveli la sua natura emotiva e pulsionale, il pensiero musicale ne ha infatti relegato la manifestazione nella dimensione popolare, escludendola dal mondo dell'arte e disprezzandone il coinvolgimento nelle pratiche della vita. Così, almeno per un lungo tratto, all'intellettualismo della tradizione colta, sdoppiata fra una scrittura che la fissa una volta per sempre e le molteplici interpretazioni che la fanno esistere, si è contrapposta l'evenemenzialità della musica popolare, che esiste solo in quanto eseguita, nel momento inafferrabile di un divenire che la produce mentre la consuma. Mentale e disincarnata la prima, inscindibilmente incorporata la seconda: in questo modo la musica popolare è diventata l'ombra (o l'inconscio) della musica colta.
D'altra parte, che l'occidente abbia concepito, e privilegiato, un rapporto disincarnato con la musica lo indica il fatto che abbia ritenuto l'atto del comporre come lo sviluppo necessario di un'idea data, e l'interprete come il portatore di una verità che l'opera possiede in se stessa: da un lato starebbe l'opera, immutabile e consegnata al suo in-sé, dall'altro l'interprete come elemento di collegamento fra l'idea musicale e la sua ricezione sonora - e questo vale anche per la contemporaneità: da Charles Ives a Pierre Boulez. "Le esecuzioni di un'opera musicale sono meno interessanti della partitura, la quale a sua volta è meno interessante dell'idea del compositore", scrive Theodor W. Adorno, e nelle sue parole troviamo l'espressione forse più compiuta di un platonismo musicale che presuppone una scena silenziosa, dove nulla turbi la quiete indispensabile al pensare. Erede di questa tradizione, nonostante intendesse criticarla, Adorno sembra dispiacersi che la musica infine risuoni, diventando una forma concreta di godimento acustico, perché l'unico ascolto che lo interessa è quello della coscienza, o dell'intelletto, quello di un pensiero devocalizzato e ridotto a puro sguardo.
Il registro vocale
E tuttavia, per quanto strano possa apparire, la presenza della voce abita (e inquieta) l'intera storia della musica occidentale, quella stessa che per venire trasmessa è stata consegnata alla dimensione grafico-visiva dello sguardo. Non intendo qui richiamarmi alla voce come funzione logica, nel senso della teoria lacaniana, ma ricordare le mille voci che popolano e vivificano la concreta esistenza dell'ambito musicale, e manifestandosi nelle forme del canto esprimono il 'femminile' in musica sollecitando, insieme ai più ineffabili godimenti, le più allarmate riflessioni: da Sant'Agostino a Papa Giovanni XXII, da François-Joseph Gossec a Theodor W. Adorno è tutto un sussulto di coscienze (maschili) inquietate dalla potenza del canto e dalla forza del vocalico, che non consentono all''idea' musicale di manifestarsi nella sua purezza.
Se ciò accade, è perché voce e sguardo, oralità e scrittura, con ogni evidenza e nonostante Platone hanno scelto di coltivare il legame con il proprio doppio, un legame che non consente alcuna dialettica e non dà luogo ad alcun superamento. Se ciò accade è forse anche perché le coppie concettuali, se sono davvero tali, vanno pensate insieme. Quando infatti pensate insieme, "oralità" e "scrittura" (ammesso che esista qualcosa di chiaramente riferibile a tali termini) non si mostrano come parti staccate di una semplice opposizione, ma piuttosto come modalità attraverso le quali avviene la trasmissione del patrimonio di saperi e comportamenti di un gruppo sociale o di un popolo. Di norma, dunque, entrambe sono presenti nei processi comunicativi, seppure in proporzioni diverse. Per questo il ricorso alla scrittura non sempre implica la rinuncia all'oralità, così come l'oralità non si presenta mai pura, cioè sganciata dai processi di codificazione. In questione è sempre la memoria collettiva, con i suoi modi di archiviazione.
E tuttavia, ma forse proprio per questo, il nostro tempo continua a interrogarsi circa la priorità da attribuirsi al fonocentrismo o piuttosto al logocentrismo. E' noto infatti come Jacques Derrida abbia ritenuto di attribuire alla voce una responsabilità prima impensata poiché, a suo parere, nella tradizione metafisica si manifesterebbe la supremazia della voce come auto-affezione, illusorio accesso alla presenza in quanto interiorità. Indice di una (presunta) purezza originaria, essa alluderebbe a una soggettività che si pensa trasparente a se stessa, che nega ogni "differenza" e si pone come radice di ogni dualismo, a partire da quello che separa l'interiorità dall'esteriorità. In altre parole ogni voce rimanderebbe a una voce originaria, alla "voce della coscienza", quando non addirittura, e più temibilmente ancora, alla "voce del Padre", colui che ab origine pone la legge e la fa osservare. La voce sarebbe insomma il simbolo dell'Autorità e l'epitome della Metafisica. Questa posizione, nella sua lodevole nettezza, priva tuttavia la voce della sua costitutiva ambiguità, mentre esiste un'intera tradizione, musicale e non solo, nella quale tale ambiguità si esprime in figurazioni straordinariamente potenti. E' la tradizione di una vocalità incontrollabile, seduttiva e mortale, è la "voix du diable" sulla quale ha riflettuto Michel Poizat e le cui tracce abbondano tanto nella storia della musica quanto in quelle della letteratura, una vocalità che si può ricondurre, per brevità di percorso, al mito omerico delle Sirene. Creature polimorfe e 'mostruose', esse uniscono alla promessa di un sapere assoluto il miele di un'ineffabile armonia, che si esprime nel loro ambiguo richiamo: "Vieni Odisseo, noi sappiamo tutto quanto avviene sulla terra. Vieni, nessuno è mai passato di qui senza udire dalla nostra bocca la voce dal dolce suono". Ma il prezzo per accedere al segreto della conoscenza e per godere del canto, come ben sa Odisseo, è la morte. Inizia così il lungo percorso del vocalico in quanto forma privilegiata dell'Unheimliche, collegata al segreto di una phone che attraendo la parola nel circuito del suono si fa luogo elettivo di un godimento sul quale la voce della coscienza non ha potere, e contro il quale si infrangono i divieti della ragione filosofica - "La voce ha le sue ragioni, che la Ragione non conosce", commenta Jean-Loup Charvet.
Ecco allora che l'ascolto della musica, pratica apparentemente innocua, nasconde forse qualcosa di indicibile, collegandosi a una forma apotropaica o comunque difensiva nei confronti della phone - e anche questo pare sapere Odisseo. Secondo quanto insegna la psicoanalisi, infatti, noi ascoltiamo la musica per esorcizzare l'orrore di incontrare la voce sotto forma di oggetto, quell'oggetto, dice Lacan, che deve restare celato affinché non vacilli la nostra identità. Poiché la voce non appartiene all'ordine della significazione, ma distinta dalla parola e dal linguaggio articola piuttosto il rapporto fra corpo e coscienza, rimandando a quello stadio aurorale e indistinto che precede il logos e sul quale esso non ha presa alcuna.
In questo senso noi parliamo di "voce della passione": per indicare un'istanza di affermazione soggettiva ma anche il bisogno di un legame, la richiesta di un'appartenenza. Ne viene che la musica, in quanto sublimazione della voce, può essere intesa come richiesta di certificazione, domanda di un riconoscimento che sta in noi accogliere o rifiutare, giacché ogni musica ci interroga, ponendoci domande mai formulate prima. E tuttavia le domande non sempre si equivalgono, e questo dipende non solo dal modo in cui vengono poste, ma anche dal luogo dal quale ci interrogano.
Entra così nel gioco, e da un accesso non secondario, la musica che costituisce l'oggetto di questo discorso, per introdurre la quale sarà opportuno affidarsi a due testimoni d'eccezione. Prima testimonianza. In un celebre passo di Età d'uomo, pubblicato nel 1939, ricorda Michel Leiris:
"Un anno, prima della fine della guerra, apparve il jazz […]. Nel periodo di grande libertà seguito alle ostilità fu un segnale di riavvicinamento, uno stendardo orgiastico, che agiva magicamente come una specie di possessione. La sua comunanza con la danza, l'erotismo, il bere, aiutava gli individui a superare i fossati che ancora li separavano. Con le violente zaffate d'aria calda tropicale, il jazz trasportava sapori di una civiltà antica e insieme moderna, capace di esprimere al meglio lo stato d'animo di molti di noi: la demoralizzazione nata dalla guerra, lo stupore naïf davanti ai conforti del progresso, l'abbandono alla gioia animale di subire l'influenza del ritmo moderno, l'aspirazione soggiacente a una vita nuova o a uno spazio più grande. Il jazz dava forma al nostro desiderio ancora inespresso."
Condivise dalla parte più sensibile della sua generazione, queste parole - così attente a rilevare la capacità del jazz di coniugare l'antico e il moderno per dare una "forma" al desiderio di rinnovamento di un'intera generazione, e a suggerire la presenza di un malessere che è quello della musica e dell'arte occidentali cui manca la forza di giocarsi il ruolo di rigenerazione richiesto dal mutare dei tempi - costituiscono un prezioso suggerimento per individuare lo spazio simbolico del jazz, dunque il modo e il luogo della sua epifania. Esse ci dicono che questa musica, "formazione di compromesso" (fra antico e moderno, erotismo e danza, ecc.) come il sintomo freudiano, presenta una doppia emergenza, costituendosi sia come metafora che allude a qualcos'altro, sia come luogo di godimento, ovvero luogo in cui piacere e interdizione si annodano inscindibilmente. Se in quanto luogo di godimento il "sintomo" jazzistico non è teorizzabile, resta un oggetto opaco e tende a porsi, come insegna Lacan, fuori di senso, in quanto metafora di un malessere segnala tuttavia uno spazio impensato, o indicibile, imponendoci di ridefinire il nostro rapporto con l'arte e la bellezza.
Come si vede, incomincia qui a definirsi il carattere perturbante della musica jazz, grazie al fatto che essa si presenta strettamente allacciata alla vita e alle sue vitali contraddizioni. Ma veniamo alla seconda testimonianza:
"Vi è una musica che incute rispetto per la virtù che possiede di non avere per fine il farsi sentire. [..] Questa musica esiste, anche senza ascoltatori. Potrebbe mettersi a suonare da sola, in certe ore del giorno o della notte, senza attese di dover fare la propria parte davanti a qualcuno. Bach.
C'è invece un'altra musica che si è preparata prima di venir fuori; si è truccata, si è assestata, ha detto a se stessa: Je vais jouer mon r�'le, speculando già sull'effetto che produrrà sull'uditorio. Wagner.
C'è infine un altro tipo di musica che vi sta a sentire. E' questa la più pericolosa e la più complessa. Essa si svolge mentre vi guarda di sottecchi giudicandovi. Bisogna essere abbastanza forti per non subire un certo disagio. […] Questo caso inverosimile è abbastanza frequente in quel genere di jazz che è detto "Chicago style". "
Queste sono parole scritte nel 1935 da Carlo Belli, il padre dell'astrattismo italiano, come lo definì Kandinskij. Anch'esse ci dicono molte cose, ma prima di tutto e inaspettatamente ci mettono in guardia, segnalano l'attitudine interlocutoria del jazz e il "pericolo" e il "disagio" connessi all'esperienza del suo ascolto. Se solo ci si riflette un momento, appare evidente come proprio questa attitudine sia stata una discriminante fondamentale per gli ascoltatori, la ragione di un pathos e di una inquietudine che li ha spinti ad amarlo o detestarlo in modo esclusivo. Stando a queste parole, l'effetto perturbante sarebbe dunque provocato dal rovesciamento dei ruoli, ovvero dall'apparire, sotto quanto vorremmo godere tranquillamente, di un movimento inatteso. Nei termini della teoria freudiana-lacaniana le cose stanno esattamente così: quando sotto il desiderabile si affaccia il desiderante, quando l'oggetto che doveva restare inerte si anima e pone la sua domanda, quando apparendo esso riempie un vuoto (di conoscenza?, quella promessa dalle Sirene?) che dovrebbe restare tale, allora si incrinano l'assetto della nostra percezione e le coordinate della nostra soggettività. Paradossalmente accade allora che noi usiamo la nostra voce - noi alziamo la nostra voce - per non sentire, o addirittura per far tacere la voce dell'Altro che si esprime nella musica.
Qualcosa del genere deve essere accaduto anche a Theodor W. Adorno, che ha riconosciuto nel jazz la voce di un'alterità insostenibile, talmente insostenibile da spingerlo a ipotizzare che essa insceni una sorta di perverso rituale di castrazione collegato a una sadomasochistica identificazione con l'aggressore. Si tratta di parole fuori misura, che dicono più cose su chi le pronuncia che sull'oggetto d'analisi. Vero è infatti che Adorno, illustre rappresentante di un'estetica musicale eurocentrica (e logocentrica), rifiuta tutto quanto appare estraneo o marginale ai procedimenti della scrittura e della composizione, compreso il jazz, così vicino alle dinamiche performative dell'oralità.
Chi si è occupato del problema ha compreso come la sua avversione non vada ricercata in ragioni di ordine psicologico o sociologico, ma costituisca una risposta coerente alla sua concezione estetica. La quale, collegata alla forma di un pensiero dialetticamente ordinato e razionale, non si avvede che il jazz parla una lingua irriducibile a quella razionalità, e cerca di ricondurlo a una forma di linguaggio scritto. Dopo di che, non riuscendo in questa operazione, lo espelle dal mondo dell'arte bollandolo come prodotto mercificato e incapace di dar vita a una vera esperienza estetica. Ma è precisamente questa oralità del jazz, l'emergere della sua umanissima ancorché denegata voce, che fa problema, poiché gli consente di rimettere in gioco i fondamenti delle categorie estetiche tradizionali. Come osserva Christian Béthune, "il jazz enuncia questa 'mostruosità': il bello, il vero, il buono - in una parola, l'assoluto - stanno tanto dalla parte dell'intelligibile quanto dalla parte del sensibile, perfino del sensuale". Ecco un'altra testimonianza sulla quale converrà soffermarsi: il jazz sarebbe in grado di tenere assieme il "sensibile" e l'"intelligibile", sarebbe comunque in grado di "tenere assieme". Ma non sono, queste, caratteristiche proprie della voce? Non è forse la voce stessa delle Sirene che ce lo dice, se è vero che essa è composta di suono ma anche portatrice di senso? E non sarebbe proprio per questo in grado di "tenere assieme" istanze che la nostra cultura, ovvero la tradizione platonico-metafisica, vorrebbe separare, a partire dalla fondamentale distinzione fra sensibile e intelligibile? Proprio così. E comincia dunque a delinearsi la qualità "vocale" del jazz, musica votata a un godimento che recupera il valore demiurgico della voce in quanto articolazione del corpo, prima che del senso e del linguaggio. Godimento in quanto tale non dicibile, e coerentemente affermato nel mondo dei suoni, in quanto tale non oppositivo, e dunque in grado di "tenere insieme" ciò che noi - a partire da Platone - vorremmo separare: Body & Soul, per l'appunto.
E d'altra parte, come altrove ho avuto modo di ricordare, la storia della cultura afroamericana è intessuta di voci e soprattutto di voci femminili, che continuamente risuonano nella memoria, e nelle pagine, dei suoi poeti e narratori: da Frederick Douglass a Zora Neale Hurston, da Paul Laurence Dumbar a Langston Hughes, da Amiri Baraka a Toni Morrison. Testimoniando un percorso comune e condiviso, queste voci scandiscono il percorso dell'infanzia, disciplinano l'apprendimento e indicano il posto che ciascuno occupa nella discendenza, divenendo luoghi significativi di produzione di senso. Chi, come Farah Jasmine Griffin, ha studiato la vocalità femminile nera nella sua concreta fenomenologia - e in quanto matrice delle musiche afroamericane e del jazz in particolare -, ne ha tratto la convinzione che nell'immaginario bianco essa mantenga una "strange otherness", un'ambigua alterità che la rende inassimilabile.
Per il pubblico americano, infatti, quella voce da un lato risuona come un'oscura minaccia, il segno di una diversità storicamente, e violentemente, imposta; dall'altro come l'essenza stessa dell'America, ciò che più di ogni altra cosa ha accompagnato la nascita di una nazione, la costruzione della sua identità e il desiderio di libertà che, nonostante tutto, l'ha originata. Sicché il fantasma dello schiavo (e della schiava), un tempo riconoscibile in quanto esteriorizzato e contestualizzato, col passare del tempo è divenuto il perturbante inquilino della coscienza bianca, la macchia oscura che inquieta l'unità della sua percezione soggettiva.
Che tutto ciò sia collegato anche al modo e al luogo della nascita del jazz, al fatto che si tratti di una musica sorta nel cuore capitalistico dell'occidente ma da una comunità, come quella afroamericana, sradicata dalle proprie origini, schiavizzata ed espropriata di tutto, da una comunità, oltre tutto, originariamente animista cui è stato imposto un ethos puritano e fondamentalista; che questa condizione lo costituisca come fondo segreto, ma soprattutto rimosso, della modernità, oltre che cono d'ombra della "luminosa" democrazia statunitense (di una democrazia che, non diversamente dalla filosofia platonica e dalla cultura greca, si vorrebbe definita da un manifest destiny, da un destino "manifesto" il quale, in quanto giusto e inevitabile, le impone di negare l'altro per affermare se stessa) non è certamente trascurabile né secondario. "La musica Nero-americana è il prodotto, e la testimonianza, di una delle più oscene avventure nella storia dell'umanità", ha scritto James Baldwin. "E' perlomeno ironico - osserva a questo proposito Christian Béthune - pensare che il cammino della filosofia verso la pretesa universalità dei suoi valori si fondi sulla scandalosa particolarità di una struttura sociale basata sullo schiavismo. Ma è dal crogiuolo di questa spietata alchimia che deriva la separazione fra il singolare e l'universale, in nome della quale la scienza rifiuta la doxa. Radicalmente altro, il jazz nasce rifiutando di accettare questa separazione. Ragione per cui non ci sarà un secondo momento: il per sé è il seguito sono già là, e a noi resta solo da distinguere la musica in quello che si suona qui e ora".
Sembra allora che questa condizione paradossale, che ha costretto l'espressione jazzistica a svilupparsi all'interno di un sistema di valori estetici e sociali che non erano i suoi, sia il tratto più significativo della sua identità. Sembra insomma che il suo affermarsi nel panorama novecentesco, la forza che l'ha sospinta, contro il parere di molti e le forze di tanti, a sostenere la sfida della propria esistenza, scrutando coraggiosamente l'immagine della propria necessità e interrogandosi senza sosta sul proprio (e sul nostro) desiderio; sembra infine che tutto ciò abbia fatto del jazz il cuore di tenebra dell'Occidente musicale, il suo compagno segreto, che come un "tamburo invisibile percosso dai suoni dell'aria" conradianamente "risuona in un vuoto buio, pieno di echi selvaggi". E se a questo punto non ne temessimo l'effetto teatrale e grandguignolesco, potremmo forse andare oltre, e proporre il seguente confronto: come l'Erode biblico, usurpatore e fratricida, l'occidente capitalistico è costretto a subire l'inquietante presenza di un Giovanni Battista afroamericano, che dal fondo della prigione in cui è stato gettato non cessa di alzare la propria voce per rammentare il peccato originale su cui si è edificato il potere del sovrano. E quante Salomé a contendersi l'onore di offrire a quel sovrano la testa di Giovanni!
Iniziamo così a comprendere quanto di irricevibile sia veicolato dal jazz, musica che riempiendo quel "vuoto" abbuiato e cruciale avrebbe lacanianamente fatto "mancare la mancanza", e contemporaneamente emergere l'angoscia, costituendosi come presenza unheimlich nell'intimo della casa: come oscura radice della nostra identità, come il "grande rimosso" ovvero il Grande Altro della musica occidentale, e dunque colui dal quale, come insegna Lacan, riceviamo il nostro messaggio nella sua forma invertita - e Carlo Belli lo aveva compreso perfettamente.
Sullo sfondo di un consumo musicale primonovecentesco equamente suddiviso fra melomani, consumatori di arie popolari e, come dirà Cocteau, estenuati ammiratori di una musica satura di vaghezze e impressionismi, l'arrivo del jazz ebbe infatti un effetto assolutamente dirompente, complice il suo trovarsi eccentricamente collocato fra un presente problematico e un passato idealizzato, costretto a vivere la propria esistenza nascondendosi fra le pieghe dell'esistenza altrui. Straordinaria testimonianza di questa difficile appartenenza, dove convivono in una sorta di doppio speculare il proprio e l'estraneo, sono le parole di W.E.B. Du Bois, uno dei grandi padri della cultura afroamericana, che all'inizio del Novecento scrive: "Nelle pieghe della civiltà occidentale sono nato e morirò, imprigionato, condizionato, depresso, esaltato e ispirato. Interamente una sua parte, e tuttavia, cosa molto più significativa, uno dei suoi scarti: uno che nella sua vita e nel suo agire […] ha dato espressione a un solo vortice di problemi sociali e paradossi psicologici".
E' questa duplicità ("twoness" scrive Du Bois), questa frammentazione dell'io, che sta alla base della cultura afroamericana: della teoria della "doppia coscienza" che ha elaborato e delle musiche che ha creato e che da sempre, e senza sosta, ne riflettono l'immagine. Blues, gospel, soul, jazz sarebbero dunque la traccia di un'eredità vocale che accompagna la vicenda dei neri dalla diaspora africana, all'approdo americano, all'emancipazione. Tutte insieme ma a partire dal blues, poiché, come scrive Amiri Baraka nella sua Autobiography: "Il blues è nostro padre e nostra madre, i nostri nonni e la nostra storia. E' l'impulso basico e la canzone […]. E il jazz, come dice Langston, è il figlio, il blue/nero prodigio della terra madre/padre".
Il jazz e la sua traccia
Se dunque c'è nel jazz qualcosa in grado di disturbarne la ricezione, se c'è in questa musica qualcosa di irricevibile, ciò riguarda la speciale natura di un oggetto che non si accontenta di essere tale, ma come insegna Carlo Belli pretende di trasformarsi in soggetto, rimescolando le carte e proponendosi nelle vesti dell'"Altro che non è del tutto Altro" di cui parla Leiris. Ma per meglio intendere cosa gli consenta questo gioco delle parti converrà tornare al tema del modo e, ancor prima, del luogo. Poiché, in verità, sembra proprio che questa musica non abbia un luogo che si possa considerare suo proprio, se è vero che nell'arco della sua esistenza ha manifestato una sorprendente disponibilità al nomadismo e all'effrazione. Una spaesante multipolarità caratterizza infatti l'origine e l'identità del jazz, che non si collega a un ambito sociale determinato né a un riconoscibile spazio simbolico, rendendo incerto il suo reperimento tanto nei luoghi fisici quanto nelle categorie concettuali. Per tutto questo risulta difficile distinguere la realtà della sua esistenza dal potere mitografico che essa sprigiona, separare il fantasma della concreta oppressione subita dalla proliferazione fantasmatica che quell'oppressione ha tuttavia generato. Un gran trafficare con i codici, un continuo lavorio sulla forma, una costante riproposizione dell'evento: sembra proprio che il jazz sia da sempre intento a seminare tracce che contemporaneamente cancella, come certi animali che confondono le piste per impegnare tutte le capacità, e tutti i sensi, degli eventuali inseguitori. Sicché per avvistarlo non basta aguzzare lo sguardo, ma occorre comprendere e accettare le regole del gioco, e cercare il luogo dove non c'è luogo, ovvero dove non ha luogo ciò che cerchiamo e dove tuttavia "avviene" un altro luogo - e forse solo oggi iniziano a delinearsi le condizioni epistemiche indispensabili ad avviare una riflessione su questo paradosso topologico.
E' precisamente da questa a-topia che nasce la sua u-topia, ovvero la capacità di inventarsi uno spazio del tutto nuovo, lo spazio cui allude Blutopia, composizione di Duke Ellington che Graham Lock ha scelto come titolo di uno studio sulla sovversione topologica e temporale messa in atto dal jazz. Nominare questa musica non è infatti riferirsi a un'etichetta o a un contenitore, ma a un universo di valori potenziali e non esclusivamente centrati sulla musica. Per questo nel corso del tempo la comunità jazzistica ha potuto metabolizzare le esperienze più varie, allargando il suo territorio fino a non possederne più uno proprio. L'unico spazio disponibile, il solo territorio abitabile, è così diventato quello di volta in volta condiviso con gli altri musicisti, definito in base alle circostanze e alla variabilità degli incontri. Da qui l'elaborazione di un sorprendente concetto di appartenenza, legato all'idea di una comunità senza territorio e senza sovranità, per la quale non è tanto questione di procedute tecniche e compositive quanto piuttosto di un diverso modello relazionale. Si tratta della creazione di un campo di forze che riattualizza il discorso di Amiri Baraka sulla musica nera come espressione di un'attitudine concernente principalmente il mondo, e solo secondariamente la tecnica musicale, come capacità di "tenere insieme" la creatività artistica e l'emancipazione culturale. Da cui discende che il "campo jazzistico" è in grado di proporsi come spazio politico inedito, poiché interviene sulle modalità di costituzione della polis praticando un altro modo di stare insieme, una diversa ipotesi di società.
Quanto al modo, valga per tutti un esempio. Sappiamo come l'improvvisazione costituisca una presenza costante e trasformatrice dell'universo jazzistico, acquistando un senso rivendicativo nei confronti dei linguaggi codificati senza tuttavia volerli abolire. In quanto apertura verso le infinite potenzialità del musicale essa diviene una soluzione di assoluto interesse, in grado di informare di sé la prassi esecutiva e di rilanciare senza sosta il processo della connotazione. E tuttavia, per quanto possa sembrare strano, l'improvvisazione non pone soltanto problemi di tipo interpretativo, ma anche di tipo legale. Essa è infatti la manifestazione più evidente della voce jazzistica in quanto collegata ai procedimenti dell'oralità performativa, mantenendosi per questo in un certo senso imprendibile. E tuttavia, chiunque sia in grado di farlo può ascoltare un solo di Charlie Parker e successivamente trascriverlo, disponendosi poi a studiarlo secondo le modalità proprie della musicologia e dunque considerandolo a tutti gli effetti un documento veridico dell'arte parkeriana.
E' quello che ha fatto Gunther Schuller, allargando il procedimento all'intera storia del jazz disponibile su supporto tecnico, cioè registrata. Ma a questo punto iniziano i problemi. E non si tratta solo di una questione di metodo, relativa all'attendibilità da attribuirsi a un documento che presume di essere autentico in quanto "pura immagine" di un'esecuzione dal vivo, ma anche di diritto, nel senso giuridico del termine. Di chi sarà infatti il copyright di quella partitura per così dire postuma?, sia che essa serva per analizzare la forma, e magari costruirci sopra un bel trattato jazzistico, sia per un'eventuale esecuzione? Per quanto mi risulta il problema è insolubile, almeno allo stato dei fatti, e nondimeno scuote alle fondamenta tutta una serie di convenzioni che riguardano le nostre modalità di rapportarci all'arte.
Poiché si tratta di una modalità, altre se ne potrebbero indicare, che caratterizza il rapporto del jazz con l'aporia stessa che lo costituisce. Poiché questa musica dell'oralità si è sempre giocata fra memoria e oblio il proprio rapporto con la scrittura, dal momento che il concetto stesso della negazione, l'istanza dialettica del "lavoro del negativo", non le appartiene. E non si tratta qui di stabilire la supremazia di Crono su Orfeo o viceversa, come discute la musicologia a proposito del Tempo musicale, si tratta piuttosto di riconoscere nella pratica jazzistica il trionfo di Kairos, il tempo debito, la contingenza propizia, in grado di afferrare il momento in cui qualcosa avviene, in cui qualcosa "ha luogo" pur non avendo "un" luogo in quanto, come scrive Sun Ra, ha a che fare con "the other side of nowhere", l'altro lato di un luogo che non c'è, l'altro lato del nulla. Poiché infine, Musa del Novecento, il jazz ha dovuto crescere in fretta, misurandosi con le innovazioni tecnologiche a lui contemporanee, ovvero con le scoperte che hanno trasformato il paesaggio sonoro mutando lo statuto della phone. Più che alla voce degli dei o del melodramma, più che alla stessa voce della coscienza, il secolo breve infatti ha dato vita a una moltitudine di voci registrate, amplificate, sintetizzate, che hanno prodotto un nuovo immaginario vocale e modificato il nostro rapporto con la scrittura e con la memoria. A partire dall'invenzione del fonografo, infatti, sono gli effetti di una moderna mitologia della voce a produrre la "colonna sonora" della modernità, in cui echeggia non sola la presenza della voce umana, ma una lunga serie di echi e suoni riprodotti che costituiscono un inquietante doppio della nostra identità. Non sarà dunque un caso se il jazz è stato accusato di appartenere a due universi apparentemente lontani e inconciliabili: musica dei selvaggi, lo si disse, cioè di coloro che non conoscono la civiltà, mentre al contempo venne percepito come musica macchinica, dai ritmi ossessivamente simili a quelli della civiltà industriale. A questa doppia e inquietante appartenenza non sono estranee la sua nascita, contemporanea all'invenzione del grammofono, e la sua diffusione, avvenuta grazie al medium dei dischi. E certamente tale doppia appartenenza lo iscrive tanto nel registro della phone quanto in quello della teche, poiché nel jazz, più che in ogni altra musica moderna, tutto si gioca nel contrasto fra la fredda autonomia della forma-disco e la calda eteronomia della forma-evento, ovvero fra l'assenza che caratterizza la riproduzione sonora e la viva presenza della performance.
Di tutto questo, e di altro ancora, testimoniano gli scritti di Alberto Savinio, il "grande dilettante" interessato ai suoni che stanno fuori dall'orchestra, in musica come in pittura e in letteratura. Affascinato dal jazz e dalla novità che per lui rappresenta, egli osserva che
"le musiche dei negri cominciano in "quel" punto, ma ugualmente potrebbero cominciare in qualsiasi altro punto. Una sonata di Brahms si annuncia. Qualcosa comincia. Diversa dalla vita che ci avvolge. Comincia la musica. La quale, nella vita che avvolge l'uomo bianco è qualcosa di diverso, profondamente diverso. Del pari, quando la musica dell'uomo bianco sta per finire, essa preannuncia la propria fine. Il qualcosa di diverso sta per finire. Preparatevi alla fine del diverso. […] La musica negra no. La musica negra non comincia, né finisce. Cessa ad un certo momento, s'interrompe. Salvo a riprendere. Con la stessa mancanza di cominciamento. Cade la musica, si spegne: nient'altro. "
Queste considerazioni, nate dall'ascolto di un disco di Jelly Roll Morton, collegano con straordinaria lucidità il problema del tempo musicale alla dimensione etica che gli è inerente. Esse segnalano che il jazz, musica intessuta di continui ritorni e riprese, organizza un percorso tendenzialmente circolare e adialettico, estraneo all'idea di una temporalità lineare e proiettiva e indifferente al principio di non contraddizione. Qui non vale la regola del terzo escluso, per cui "ciò che è" non può "non essere", dal momento che tutto può sempre avvenire e quel che conta è esattamente il possibile evento di questo avvenire. Queste considerazioni ci fanno intendere che la temporalità jazzistica si sottrae a ogni finalismo teleologico, e rifiutando di assoggettarsi alle metafore dello sviluppo e del progresso riesce a farsi carico della condizione umana, quella che sta nel mezzo - come direbbe Deleuze - e che in ogni istante, e imprevedibilmente, può iniziare e finire. Senza parere, Savinio insomma ci indica in quale modo il jazz offra il suo contributo alla critica del "tempo progressivo" e alla sua logica costruttiva-deduttiva: estendendo all'infinito il senso del presente e lo spazio dell'evento. Noi, che veniamo "dopo", sappiamo che proprio per questo i jazzmen considerano i predecessori loro contemporanei, riattualizzando senza sosta la loro eredità e ripiegando il futuro sul passato per edificare un'altra storia. E che proprio per questo, contrariamente alla logica occidentale che impone all'arte di rinunciare agli stereotipi, essi affermano la liceità di mescolare ripetizione e innovazione, rielaborando incessantemente un certo numero di formule fisse note come standard. Ciò non solo rivoluziona l'estetica, sovvertendo il nostro rapporto con le forme dell'espressione, ma sottrae i musicisti all'angoscia dell'influenza.
Giungiamo così al cuore del problema, laddove è in questione la vera natura del jazz, la sua ragione profonda, che per Savinio è terapeutica: "Il negro non canta, non suona per diletto; non pure per 'esprimere' la propria anima. Suona e canta per scaricare la propria anima. Conosceva Freud la musica negra?". Dunque la musica negra penetra il fondo della psiche e lo svuota, attivando la medesima funzione catartica della tragedia greca. Da qui la ragione di un titolo, Cantare come i negri rimedio alla nevrastenia, che allude alla possibilità che spetti all'arte di risolvere la vita, conferendo giustificazione estetica all'esistenza. Proprio ciò che a suo parere avviene nel jazz, "vera danza di Zarathustra", musica dionisiaca che echeggia nel corpo della sua stessa voce le conquiste dell'arte moderna, amplificate dagli apparati di riproduzione meccanica. Questo infatti suggerisce la lettura di un sorprendente articolo, intitolato Grammofono e pubblicato nel 1926. Savinio, che proprio alla mediazione del grammofono deve la sua conoscenza del jazz, vi sostiene che i moderni meccanismi di riproduzione non sono macchine neutre, congegni inanimati, ma forme della modernità che danno vita a un'inedita metafisica, a un nuovo demonismo. Così la voce del grammofono non è la semplice riproduzione della voce umana o di uno strumento musicale, ma qualcosa di indipendente e staccato. Dal grammofono insomma non esce la copia fedele di un suono ma qualcosa di inaudito, che ci inizia a nuovi misteri. Facile prevedere che questo suono, "intonato al carattere della vita attuale", presto dilagherà, sostituendo la voce umana e proponendosi come solo strumento di conoscenza e di godimento acustici. Dotato di una straniante bellezza e di una particolare ironia, profetizza Savinio, il dèmone del grammofono con la sua voce macchinica finirà un giorno per emanciparsi completamente: "Quel giorno i grammofoni, pieni non altro se non del loro dio sonoro, rauco, metallico, dominatore, canteranno liberamente sulle città mostruose e trionfanti".
Nonostante le apparenze, siamo qui più prossimi alle intuizioni di Duchamp che all'ingenuo trionfalismo dei futuristi. Poiché l'idea che la tecnica possa catturare la voce e restituirla oggettivata non solo segnala l'effetto perturbante della riproduzione sonora, ma apre lo spazio di un'estetica nuova, che si esprime in forme autonome e del tutto indipendenti dalla volontà umana. Anche per questo il pensiero di Savinio appare in grado di illuminare, con anticipo straordinario, il senso dell'apparizione del jazz in rapporto al tema della voce. Prima della fondamentale riflessione di Walter Benjamin sulla (ri)producibilità dell'opera d'arte, che è del 1935, ma anche prima dell'articolo di Adorno sulla voce scorporata del fonografo, che è del 1928, con mano leggera egli ci guida in un ambito di riflessione che con efficace ossimoro oggi diciamo "sublime tecnologico". Sicché dobbiamo a quest'uomo riservato e fondamentalmente scettico le prime, essenziali intuizioni sul carattere sottilmente unheimlich della riproduzione sonora in quanto staccata, dotata cioè di quell'autonomia che ne segnala la radice disumana, macchinina, ovvero l'ontologica alterità.
Epilogo: o del non-luogo in cui ha luogo l'epifania del jazz
Car il faut bien durer un peau plus que sa voix.
Roland Barthes
Di tutte le immagini che si stagliano sullo sfondo evanescente delle origini jazzistiche, ce n'è una che il passare del tempo ha contribuito a potenziare senza che nulla sia intervenuto a precisarne i contorni. E' l'immagine del mitico trombettista Charles "Buddy" Bolden, il più misterioso fra i padri che contribuirono alla gloria di New Orleans. Padri in verità appartenenti alla stirpe della gente comune, quella che si guadagna da vivere facendo mille mestieri: Johnny St. Cyr il muratore, Adolphe Picou lo stagnino, ma che ci ha lasciato un'inconfondibile traccia musicale. Non tutti divennero famosi, e per alcuni furono provvidenziali la diaspora che li portò lontani dalla città deltizia e il contemporaneo avvento del disco, supporto indispensabile del loro magistero per i posteri. Ancora oggi i loro nomi costituiscono la più antica genealogia del jazz: King Oliver, Sidney Bechet, Louis Armstrong... Vero è infatti che a partire dal 1917, dalla chiusura del quartiere di Storyville che indirizzò altrove i destini del jazz, solo pochi scelsero di restare a New Orleans, e proprio per questo furono dimenticati. Per gli altri si aprirono le porte di un viaggio pieno di speranze e di imprevisti, segnato dalla struggente malinconia immortalata dalla voce di Billie Holiday: "Do you know what it means to miss New Orleans…". Ma fra quelli che restarono, e che non incisero mai un disco, mai una sola nota, un nome brilla luminoso nel ricordo degli appassionati, quello di Bolden, il Grande Trombettista Nero.
Si sa che nacque nel 1877, o forse nel 1879, che si sposò, ebbe due figli ma non una specifica educazione musicale. Un solo disegno resta, di datazione incerta fra il 1894 e il 1895, che lo ritrae non ancora ventenne e vestito elegantemente; e una foto sbiadita, scattata da un anonimo fotografo attorno al 1905, che lo mostra insieme agli uomini della sua band: Jimmy Johnson, Willie Cornish, William Warner, Jefferson Mumford e Frank Lewis. Il grande Jelly Roll Morton, che lo conobbe, in un'intervista rilasciata ad Alan Lomax afferma che egli non aveva rivali a New Orleans, e che l'ammirazione della gente, quando suonava per le strade della città, era dovuta alle originali invenzioni melodiche ma soprattutto all'incredibile voce della sua tromba, che rifrangendosi sull'acqua dei canali si diffondeva ovunque. Così Bolden divenne la voce di New Orleans, e lo rimase anche quando la vita, fosse follia o scelta consapevole non sapremo mai, lo condusse all'isolamento e al più completo silenzio.
Il vivido ricordo dell'"inventore del jazz", come si autodefiniva Morton, contiene tutti gli elementi utili alla formazione del mito, a cominciare dal fatto che della prima grande voce del jazz manca qualsiasi testimonianza sonora. Di quella musica resta solo il ricordo, e la nostalgia di una voce che risuonava per la felicità di tutti.
Bibliografia
Adorno, Theodor W., Teoria estetica, tr. it. Einaudi, Torino 1977.
Baraka, Amiri, The Autobiography of LeRoi Jones, Freundlich, New York 1984.
Belli, Carlo, Chorus, in "Quadrante", n. 29, 1935.
Béthune, Christian, Adorno e il jazz. Intervista a Christian Béthune, a cura di Giorgio Rimondi, in "Jazzit", n. 16, 2003.
Id., Il jazz e l'Occidente, tr. it. in Aa.Vv., Amiri Baraka. Ritratto dell'artista in nero, a cura di Franco Minganti e Giorgio Rimondi, Bacchilega, Imola 2007.
Capuano, Gianluca, I segni della voce infinita. Musica e scrittura, Jaca Book, Milano 2002.
Derrida, Jacques, Della grammatologia, tr. it. Jaca Book, Milano 1989.
Du Bois, W.E.B., Dask of Dawn, in Writings, The Library of America, New York 1996.
Griffin, Farah J., When Malindy Sings. A Meditation on Black Women's Vocality, in Aa.Vv., Uptown Conversation, edited by Robert G. O'Meally, Brent H. Edwards & Farah J. Griffin, Columbia University Press, New York 2004.
Leiris, Michel, Età d'Uomo, tr. it. Mondadori, Milano 1966.
Lock, Graham, Blutopia. Visions of the Future and Revisions of the Past in the Work of Sun Ra, Duke Ellington, and Anthony Braxton, Duke University Press, Durham & London 1999.
Platone, Timeo e Repubblica.
Poizat, Michel, La Voix du diable, Métailié, Parsi 1991.
Rimondi, Giorgio, Il corpo nella voce. Per un'interpretazione psicoanalitica del jazz, in Aa.Vv., Contaminazioni. La musica e le sue metamorfosi, a cura di Carlo De Incontrera, Stella Arti Grafiche, Trieste 1997.
Id., Il suono etico, in "Nuova Prosa": Letteratura & Jazz, a cura dello stesso, n. 32, 2001.
Savinio, Alberto, Grammofono, in "Il Secolo XX", n. 10, 1926.
Id., Cantare come i negri rimedio alla nevrastenia, in "Corriere della Serra", 1 gennaio 1950.
Sini, Carlo, La virtù politica. Filosofia e antropologia, quarto libro delle Figure dell'Enciclopedia filosofica, Jaca Book, Milano 2004.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.