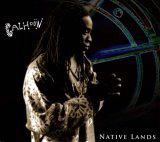Home » Articoli » Lyrics » Elmo Hope: la vita e la musica
Elmo Hope: la vita e la musica
A causa degli ostacoli nella sua vita privata pochi ebbero modo di capire quanto Hope fosse dotato ma io intuii subito. Elmo era tanto dotato come solista quanto come compositore ma la scrittura evidenziava cose che nel pianismo sfuggono. Elmo aveva davvero la scintilla del genio.
—Harold Land
Le ragioni di tale destino sono molte: alcune imputabili allo stesso Hope (la principale fu la tossicodipendenza) altre alla disattenzione di pubblico e critica.
Solo tra i pianisti analoga sorte è toccata ad Herbie Nichols, Sonny Clark, Hampton Hawes o Carl Perkins, tanto per citarne alcuni.
Bisogna riconoscere che importanti produttori discografici (Alfred Lion della Blue Note, Orrin Keepnews della Riverside, Bob Weinstock della Prestige e David Axelrod della HiFi Records) intuirono il talento di Hope, dandogli l'opportunitè di registrare. Analoga stima gli venne dai colleghi: basti pensare a Sonny Rollins, Clifford Brown, John Coltrane, Paul Chambers, Philly Joe Jones, Art Blakey, Jackie McLean e Harold Land che lavorarono nei suoi gruppi o lo vollero come sideman.
Anche alcuni critici mostrarono attenzione, anche se un pò tardiva. Il decano di essi, Leonard Feather, definì Elmo Hope nella sua "Encyclopedia of Jazz in the Seventies": A pianist and composer of rare armonic acuity and very personal interpretation. Stessa stima gli venne da Ira Gitler che gli dedicò spazio nel suo "Jazz Masters of the Forties".
Tra le altre ragioni che tennero il pianista in ombra, va notata la singolare assenza nei luoghi e nei momenti cruciali del jazz. Quando il be-bop andava affermandosi nei locali della 52ma strada di New York, Hope operava in formazioni di rhythm & blues in sale da ballo della Quattordicesima o in equivoci locali del Bronx o di Coney Island.
Restò a New York (con parentesi forzate nel carcere di Rikers Island) per tutti gli anni di "magra", quando era in auge il West Coast Jazz, e fu costretto a emigrare in California proprio quando risorgeva il bop nella East Coast.
Elmo visse solo 44 anni. Di lui ci restano quindici di album da leader e una decina realizzati in collaborazione con altri. In tutta la sua esistenza gli fu chiesta una sola intervista ("Bitter Hope" di John Tynan, pubblicata da Down Beat il 16 gennaio 1961).
St. Elmo Sylvester Hope nacque a New York il 27 giugno 1923, in una famiglia originaria delle Antille. All'età di sette anni iniziò a prendere lezioni di pianoforte dimostrando un vivo talento al punto che a quattordici già raccoglieva riconoscimenti in recital di musica classica che si svolgevano ad Harlem. Allora sognava la carriera del concertista ma presto si rese conto che la societè americana non glielo avrebbe permesso per motivi razziali. Suo amico d'infanzia, in quei primi anni quaranta, era Bud Powell e con lui condivise sia l'amore per la musica classica (molte ore passate ad ascoltare Bach, Debussy, Chopin e Schumann) che i primi approcci jazzistici al piano.
Non voglio certo equiparare le stature finali dei due pianisti, ma in quegli anni di formazione è probabilmente vero ciò che disse Bob Bunyan, un musicista loro amico: "Ciascuno imparava dall'altro. Semplicemente suonando. Bud aveva l'attacco potente, Elmo si avventurava in un intrico di armonie". Per entrambi il punto di riferimento privilegiato era Thelonious Monk, che li conosceva e li incoraggiava.
Negli anni dell'affermazione del be-bop, Elmo Hope militò in formazioni di secondo piano, lontano dall'attenzione di critica e pubblico. Nella seconda metà degli anni quaranta, dopo un periodo con l'orchestra del trombonista Snub Mosley, entrò nella Joe Morris Rhythm & Blues Band, restandovi quattro anni (non due o tre com'è stato scritto) ed incidendo anche il suo primo disco, il 19 settembre 1948.
In quel medio organico operavano, oltre al ventenne sassofonista Johnny Griffin, il bassista Percy Heath e il batterista Philly Joe Jones, che rimarranno fedeli partner di Hope a partire dal suo primo ingaggio importante: la session del 9 giugno per la Blue Note col ventitreenne Clifford Brown.
In quell'incisione troviamo uno dei suoi primi temi, "Bellarosa", una gemma di freschezza melodica e fantasia ritmica, che evidenzia al meglio le sue doti di scrittura.
In quella splendida session (poi ripubblicata nel Memorial Album del trombettista) troviamo altri due bei temi scritti da Hope, "Carvin' the Rock" (in collaborazione con Sonny Rollins) e "De-Dah". Brani di fattura bop ma dallo svolgimento tematico del tutto originale, caratterizzati da un originale movimento interno e da soluzioni impreviste. Elmo aveva ormai scelto definitivamente il jazz moderno e un'altra prova viene dalla formazione del trio con John Ore al contrabbasso e Willie Jones alla batteria che rimase unito per alcuni anni ed incise un album significativo nel 1955 per la Prestige (Meditations) poi ristampato col titolo The Elmo Hope Memorial Album.
Il 18 giugno 1953 la Blue Note incise il suo debutto da leader, in trio con Heath e Jones (vedi recensione di Trio and Quintet) evidenziando un pianismo ricco di spunti originali e nuovi esempi del suo talento compositivo. Com'ebbe a dire Hampton Hawes, "Elmo non suonava secondo gli stili di Powell o di Monk. Io l'ho sempre considerato un pianista-compositore. Come Duke Ellington egli aveva uno stile originale che emergeva dal suo modo di comporre".
Dopo una seconda significativa session per la Blue Note, il 9 maggio 1954, dove Hope guidò un quintetto comprendente anche Art Blakey e Frank Foster (sempre nel CD citato), il 18 agosto troviamo il pianista in session con Rollins per incidere Moving Out. Quattro giorni dopo si unì a Lou Donaldson per incidere quattro brani, tra cui il suo "Moès Bluff", che sospende il suo rapporto con l'etichetta di Lion.
Non ci sono notizie in merito, ma la brusca assenza dagli studi si protrasse per 11 mesi e fa supporre un'allontanamento "forzato" per questioni di droga. Prima di essere definitivamente privato della cabaret card, la tessera che permetteva di suonare nei locali di New York, Hope ebbe modo di registrare alcune cose di rilievo per la Prestige.
Il 28 luglio 1955 incise da Van Gelder con un nuovo trio (John Ore al contrabbasso e Willie Jones alla batteria) Meditations, uno dei suoi album piu' riusciti. Ancora una volta il suo stile di pianista armonicamente sofisticato si fondeva nelle personali doti compositive: il percorso musicale è un intenso svolgersi di liriche ballad e articolati originals: "Quit It", "Huh", "Lucky Strike", "Blue Mo", "Elmòs Fire".
Nell'arco di alcuni mesi Elmo Hope registrò per la Prestige due album in veste di leader e uno come sideman. Ci riferiamo a (Hope Meets Foster del 4 ottobre 1955 comprendente quattro sue nuove composizioni ("Zarou", "Fosterity", "Wail, Frank, Wail" e "Yaho"), al disco di Jackie McLean del Lights Out (27 gennaio 1956) ed ancora a Informal Jazz del 7 maggio 1956 (ripubblicato in CD come The All Star Sessions).
In quest'ultimo lavoro Elmo guidava un prestigioso settetto comprendente Donald Byrd alla tromba, John Coltrane e Hank Mobley ai tenori, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Il disco è poco più di una blowin' session ed anche i due originals di Hope non sono significativi ("Weeja", ad esempio, è basato sulle armonie di "Confirmation"). Va notato invece il suo lirico approccio pianistico in "Polka Dots and Moonbeams" dove prende un assolo particolarmente ispirato (che ben evidenzia la distanza dal "modello" Powell, in un'originale sintesi fra impronta eurocolta e concezioni monkiane).
L'accoglienza di questi lavori presso la critica e il pubblico fu modesta e le poche occasioni per Hope di lavorare nei locali di New York vennero compromesse col ritiro dalla cabaret card. Così nel 1957 accettò la proposta di Chet Baker, appena dimesso dal Lexington Federal Hospital, per un tour che lo portò in California.
Elmo andò ad aggiungersi alla piccola (e appartata) colonia di jazzmen neri che operavano a Los Angeles nel pieno del West Coast Jazz dominato dai bianchi. Il dolce clima californiano alleviò i suoi problemi respiratori e l'atmosfera generamente più rilassata apportarono dei benefici anche in ambito musicale. In California Hope restò tre anni, realizzando proficui incontri con il bassista Curtis Counce e col sassofonista tenore Harold Land, con cui registrò The Fox, uno dei capolavori dell'intera estetica hard-bop.
Ma l'affinitè tra Hope e Land s'evidenziò già il 31 ottobre 1957 con l'incisione di tre brani per la World Pacific (ripubblicati anch'essi in Trio and Quintet della Blue Note): "Vaun Ex", "St. Elmo's Fire" e "So Nice". Quel long playing in formato 12" fu uno dei due lavori incisi a suo nome in California (l'altro è (Elmo Hope Trio del 1959).
Con il misconosciuto bassista e leader Curtis Counce, Hope partecipò all'incisione di Sonority (Contemporary) ed Exploring the Future (Dooto), contribuendovi con vecchie e nuove composizioni.
Ma le cose più esaltanti vennero assieme ad Harold Land, già stretto collaboratore di Counce, con cui incise anche Harold in the Land of Jazz in veste d'arrangiatore e compositore. In quest'album, ad esempio, va segnalato "Nieta", uno dei piu' bei brani di Elmo, dalla particolarissima articolazione: quarantotto battute in forma ABBBC.
"A causa degli ostacoli nella sua vita privata - disse poi Land - pochi ebbero modo di capire quanto Hope fosse dotato ma io intuii subito, aveva una mente tra le più vive che abbia mai visto in azione. (...) Elmo era tanto dotato come solista quanto come compositore ma la scrittura evidenziava cose che nel pianismo sfuggono. Negli assoli è libero e sciolto ma quando scrive c'è senso della forma. Le linee melodiche sono involute ma non perdono mai la continuità. Elmo aveva davvero la scintilla del genio".
Il successivo The Fox, inciso nell'agosto 1959, vedeva protagonista un quintetto con il giovanissimo e brillante trombettista Dupree Bolton (altra tragica meteora del jazz), Harold Land al tenore, il bassista Herbie Lewis, il batterista Frank Butler ed ovviamente Elmo Hope al piano che contribuì con quattro temi su sei.
Il primo "Mirror-Mind Rose" viene dopo il serrato brano d'apertura di Land e introduce un clima sospeso e crepuscolare, giocato sull'alternanza tra il modo maggiore e quello minore. Il clima cambia radicalmente nei successivi "One Second Please", "Sims A-Plenty" e "One Down", tutti segnati dalle particolari concezioni ritmiche o metriche del pianista.
Soprattutto "Sims A-Plenty" lascia stupefatti per l'elaborata concezione formale: un brano di 42 battute (!), dalle innumerevoli variazioni ritmiche che mettevano a dura prova le abilitè tecniche dei solisti. Anche questo motivo determinò il difficile inserimento nel mondo musicale della West Coast.
In quegli anni la scena californiana del jazz stava spegnendosi ed ovviamente erano i musicisti bianchi ad occupare le poche scritture nei locali più importanti. Tutta la frustrazione di quella fase emerse nell'intervista concessa a Down Beat, poco prima di tornare a New York.
"Qui i musicisti campano di invidie e gelosie. Non credono nel condividere, nemmeno le loro conoscenze. Il loro motto è: "Meglio ricevere che dare" e, dannazione, quasi tutti sono sopravvalutati per quello che fanno. Tutti, o quasi tutti, si suonano addosso. Ecco perchè non riesco a far suonare la mia musica (...). Questo non è il posto per imparare alcunchè. Se vogliono imparare se ne vadano a New York... troveranno che succede molto di piu' e incontreranno giovani musicisti che fanno sembrare questi dei pagliacci. Dopo Thelonious e Bud non ho sentito succedere un bel niente...".
All'inizio del 1959 Elmo aveva inciso forse l'esempio migliore del suo pianismo: un disco in trio (con Jimmy Bond al contrabbasso e Frank Butler alla batteria) prodotto da David Axelrod per la piccolissima HiFi Records e poi ceduto alla Contemporary. Il titolo era semplicemente Elmo Hope Trio e presentava ancora sette composizioni originali più lo standard "Like Someone in Love".
In apertura troviamo "B's A Plenty" brano che, riformulato e con nuovo nome ("Sims-A-Plenty") entrerà in The Fox. Un blues dalla chiara identità boppistica che non lascia presagire l'intensità lirica e la sofisticazione armonica dei successivi "Barfly" ed "Eejah". Lo stile di Hope è ormai ampiamente personale, in magico equilibrio tra la fluidità orizzontale di Powell e la singolarità verticale di Monk. Nella riuscita della session ha un ruolo significativo il drumming spezzato del grande Frank Butler che stabilisce un emozionante dialogo col pianista. Esempio peculiare sono il latineggiante "Something for Kenny" e l'articolato "Minor Bertha" dove l'interazione dinamica tra i due si fa davvero stringente.
Quest'ultimo tema, ci ricorda che in quei mesi californiani, Elmo conobbe Berta, una pianista interessata alle sue composizioni che presto sposò e da cui avrà tre figli.
Nel 1961 Elmo tornò definitivamente a New York, alternando brevi periodi musicali (con intensa attività di scrittura: quasi tutti i brani che incise fino al 1966 furono suoi) ad altri d'internamento nel carcere di Rikers Island.
Di quest'ultima fase vanno segnalate altre interessanti incisioni. Nel mese di giugno fu invitato da Orrin Keepnews ad incidere un album che uscirà col titolo significativo di (Homecoming. Il noto produttore della Riverside l'aveva notato da tempo e quando Elmo tornò nella Big Apple gli mise a disposizione un ottimo team di partner per incidere quattro matrici in trio e tre in quintetto. Rivediamo quindi Elmo nuovamente assieme a Paul Chambers e Philly Joe Jones a cui s'aggiunsero Jimmy Heath e Frank Foster ai tenori e Blue Mitchell alla tromba.
I brani incisi in piano trio sono forse i piu' interessanti, in quanto offrono nuove opportunità per indagare le qualitè misconosciute del suo stile, alle prese con un rilassato quanto intenso blues ("One Mo' Blues"), un altro complesso tema dai tratti monkiani dedicato alla moglie ("La Berte"), la swingante rilettura di "Elmo's Fire" ribattezzata "Homecoming" e la lirica ballad "Imagination" di Van Heusen.
Altro splendido disco per la Riverside (Hope-Full) fu inciso tra il 9 e il 14 novembre in solo ed assieme alla moglie in un insolito piano duo.
In quel periodo Hope registrò altre significative matrici con Chambers e Jones per effimere etichette come la Beacon e la Celebrity (ristampate dalla Fresh Sound col titolo Elmo Hope Plays His Original Compositions) che purtroppo restano semisconosciute, quando fu di nuovo imprigionato per i soliti "problemi personali".
Tornò libero nel 1963 e il 19 agosto fu invitato dall'Audio Fidelity a registrare un album che prenderà un titolo significativo: Sounds from Rikers Island, chiara allusione al carcere dove finivano i tossicodipendenti di New York.
Il disco fu progettato e curato dal vibrafonista Walt Dickerson che sostenne e guidò il produttore dell'etichetta Sid Frey. In modo assolutamente singolare si voleva rimarcare (e le note di copertina di Nat Hentoff lo chiariscono bene) la drammatica condizione di cui erano vittime molti jazzmen di New York, vittime predestinate della tossicodipendenza per le marginali condizioni di vita. L'album, che è tornato sul mercato recentemente, dopo decenni di assenza, è tra i migliori del pianista. Mascherati sotto nuovi titoli, troviamo anche vecchie composizioni riarrangiate (ad esempio "Ecstasy", "Vaun Ex", "Trippin", "So Nice" mentre "One for Joe" cela "Take Twelve") ma ciò non toglie nulla all'originalitè del lavoro, che vede Hope assieme a due colonne dell'orchestra di Sun Ra (il sassofonista John Gilmore e il bassista Ronnie Boykins), il fedele Philly Joe Jones e qualche giovane partner.
"Non ho mai avuto una session con tanti musicisti in studio - ricordò il produttore - Ad un certo momento c'erano più di venti persone nella control room ". Tra i brani ricordiamo innanzitutto i nuovi "Three Silver Quartets" e "Monique": il primo è eseguito in trio e mostra un fantasioso uso del tempo in 3/4 mentre il secondo è un'evanescente ballad di grande coinvolgimento eseguita in quartetto con Gilmore.
Il mese successivo il pianista participò ad un'incisione di un sestetto guidato da Philly Joe Jones, mai pubblicata, e sparì di scena per ben due anni e mezzo. Di quella fase si sa poco. Forse fu nuovamente imprigionato me è certo che ebbe problemi di salute che gli impedirono di suonare. Il suo contributo al bilancio famigliare veniva dalla vendita di partiture a gruppi affermati e di occasionali commercial.
Tra il marzo e il maggio 1966 Elmo tornò in sala d'incisione per l'ultima volta, grazie all'interessamento di Herb Abramson (Last Session, Inner City) in trio con John Ore al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Quattordici titoli, tra cui undici originals, che svelano ancora una volta il talento di Hope, sempre più attratto dagli stilemi del free. Come ha scritto Roberto Cipelli nella sua puntuale analisi musicologica dedicata al pianista ("Il linguaggio di Elmo Hope", Nerosubianco, ottobre 1993): "In queste incisioni vengono quindi vanificate tutte le convenzioni degli standard; gli assolo si compenetrano con intento completamente libero da qualsiasi vincolo predeterminato. I tamburi di Philly Joe Jones si adeguano senza impaccio a questo nuovo contesto, contrappuntando felicemente gli spunti percussivi del pianoforte. Siamo di fronte ad una sorta di free bop: in esso il tipico linguaggio bop mantiene alcune sue costanti, che però subiscono un inserimento casuale e frammentario nel flusso dell'improvvisazione".
L'ultima esibizione pubblica di Elmo Hope avvenne alla fine dell'anno in un concerto alla Judson Hall. Nel maggio del 1967 fu ricoverato in ospedale per polmonite e morì il 19 di quel mese per infarto.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.