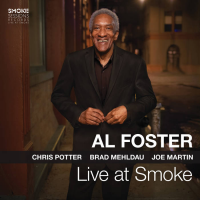Home » Articoli » Interview » Dino Betti van der Noot
Dino Betti van der Noot
Crescere in una famiglia composita come la mia ti dà stimoli particolari. Magari anche quello di fare il contrario di ciò che ci si aspetta da te
Di lui si sottolineava l'ampio (e mai scontato) respiro compositivo, l'eleganza degli impasti timbrici, la sapiente mano nel gestire le dinamiche, l'invidiabile equilibrio fra scrittura e apporto dei solisti, spesso illustri (Franco Ambrosetti, Donald Harrison, Gianluigi Trovesi, Luis Agudo, Daniel Humair, Sergio Fanni, Giancarlo Schiaffini, Bill Evans, il sassofonista, Hugo Heredia, Riccardo Luppi, Mitchel Forman, Tiziano Tononi, Sandro Cerino, Paul Bley, Steve Swallow, Paul Motian, Roberta Gambarini, fra gli altri). Si faceva, su tutti, il nome di Gil Evans.
Sia quel che sia, dopo altri due lavori, editi stavolta dalla Innowo (i precedenti erano usciti su Soul Note), A Chance for a Dance e Space Blossoms, abbastanza inaspettatamente Betti si è fatto da parte per una buona quindicina d'anni, riproponendosi solo nel 2005 con Ithaca/Ithaki (inciso in realtà nel 2003, nuovamente per la Soul Note), cui sono seguiti, a scadenze tornate regolari (due anni), The Humming Cloud e l'ultimo nato, God Save the Earth, entrambi su Sam (fra i solisti, oltre a diversi dei succitati, ci sono ora John Taylor, Vincenzo Zitello, Andrea Dulbecco, Ares Tavolazzi, Don Moye, Beppe Caruso, Daniele Cavallanti, Fabrizio Puglisi, Ginger Brew, Alberto Mandarini, Giulio Visibelli, Alberto Tacchini, ecc.), con Betti nuovamente in cima ai voti della critica (ripetutamente primo, in particolare, e con largo margine, tra i compositori/arrangiatori al referendum di "Musica Jazz"). Di tutto (o quasi) parliamo col diretto interessato.
All About Jazz: Iniziamo col mettere un po' d'ordine nelle tue origini familiari, piuttosto ramificate, a quanto pare.
Dino Betti: In effetti: ligure di nascita, ma milanese di vita; per metà italiano e per metà nord-europeo. Mia madre era pianista. Forse hai ragione a cominciare di qui: crescere in una famiglia come la mia è un po' particolare e ti dà degli stimoli precisi. Magari anche inducendoti a fare il contrario di quello che ci si aspetta da te.
AAJ: A proposito del tuo ultimo CD, God Save the Earth, c'è chi ha rilevato grandi differenze rispetto al passato e chi, in pratica, nessuna. Tu che ne pensi?
D.B.: Ci sono certamente delle differenze: mi sono lasciato andare a una maggiore spontaneità e libertà anche dal punto di vista ritmico. Tuttavia i due anni che separano questo lavoro dal precedente sono passati in un attimo: sembra non esserci stato un intervallo. Si tratta quindi fondamentalmente di un affinamento degli strumenti tecnici a mia disposizione e di una minore insicurezza sul possibile risultato di quello che scrivo. E, forse, anche di una consonanza crescente con i musicisti coinvolti, che stanno diventando una vera e propria compagnia stabile.
AAJ: A questo proposito, è stata anche evidenziata una maggiore libertà che avresti lasciato appunto ai musicisti. Personalmente non ho avuto questa impressione: mi pare che il processo sia quello consueto.
D.B.: Infatti: i percorsi che stabilisco sono sempre abbastanza precisi. Ho dato maggiori spazi dal punto di vista temporale, ma sempre avendo bene in testa, fin dall'inizio, i musicisti cui affidare gli assoli e cercando di stimolarli a trovare qualcosa di nuovo, a raccontare ogni volta una storia. Gianluca Alberti, per esempio, sostiene che gli chiedo continuamente di andare oltre i suoi limiti. Di fatto, parlando di limiti, sono convinto che i musicisti italiani, che già occupano una posizione abbastanza di primo piano sulla scena jazzistica internazionale, possano andare ancora molto oltre.
AAJ: E circa una tua (presunta) parentela con Joe Zawinul - che personalmente, anche qui, non riscontro - come ti poni?
D.B.: Non mi sembra proprio, anche se ho sempre ammirato la sua genialità nel lavorare sui timbri e le sue invenzioni tematiche. Semmai (e mettendomi in ginocchio) ho l'impressione di essermi ancor più avvicinato a Ellington, almeno come urgenza espressiva. Senza dimenticare Kenton, una mia passione iniziale che ho approfondito parecchio. Lui e Mulligan sono stati i musicisti che mi hanno fatto scoprire il jazz nel lontano 1955.
AAJ: Eri un ragazzo, quindi. E dimmi una cosa: nutrivi velleità in particolare su qualche strumento, o ti sei sempre sentito più attratto dall'aspetto "architettonico" del fare musica?
D.B.: Ho studiato violino alla Scuola Musicale di Pavia, ma, malgrado qualche saggio al Teatro Fraschini, ero assolutamente negato. Poi mi sono cimentato con parecchi strumenti, a corde e a fiato, dimostrandomi sempre molto scarso come esecutore, ma imparando come li si può utilizzare e come si deve scrivere per loro. E forse, in effetti, scrivo perché sono inadeguato come esecutore...
AAJ: Una curiosità: com'è stato approdare alla notorietà, o quanto meno al riconoscimento del proprio valore, alla boa dei cinquant'anni?
D.B.: È stata una sorpresa assoluta. Quando da "Musica Jazz" mi hanno telefonato dicendomi che Here Comes Springtime era, secondo "USA Today," il terzo miglior disco dell'anno pensavo fosse uno scherzo. Forse tutto quello che è successo poi mi sembra un po' irreale. Una conseguenza, in ogni caso, c'è stata: la paura di non essere all'altezza delle aspettative. Ma anche la tensione a voler imparare di continuo, cosa che avviene regolarmente attraverso i contatti con i musicisti con cui ho lavorato e con cui lavoro. E che devo ringraziare veramente, sia per la loro disponibilità a battere strade diverse da quelle che percorrono normalmente, sia per quello che mi hanno insegnato.
AAJ: Posso chiederti come è stato attendere così a lungo? Anche perché il tuo primo album, Basement Big Band, era di quasi dieci anni prima. Al secondo, forse, ha invece nuociuto una copertina che definirei un po' troppo "papettiana"...
D.B.: La copertina riportava un'opera fotografica di Dennis Manarchy, "Black Greased Nude," coerente con il titolo dell'album, A Midwinter Night's Dream. I problemi erano altri: non avevo ancora trovato (ammesso che l'abbia trovato davvero successivamente) il modo di esprimere compiutamente il mio pensiero musicale; l'esecuzione lasciava, a mio avviso, un po' a desiderare, certamente per una mia difficoltà a trasmettere le mie idee, ma anche per una selezione non corretta di qualche esecutore. Soltanto con l'album successivo ho cominciato a mettere insieme in maniera coerente i vari pezzi del puzzle che costituiscono il mio linguaggio e a dare degli input più precisi ai musicisti coinvolti; dai quali (non mi stancherò mai di ripeterlo) ho continuato a imparare continuamente.
AAJ: Prima citavi Stan Kenton, col quale mi pare proprio che un ceppo comune esista, anche se quello ellingtoniano, e soprattutto quello gilevansiano, appaiono più marcati.
D.B.: In realtà io non mi sento particolarmente vicino a Gil Evans, soprattutto quello dell'ultimo periodo, pur avendo amato molto tutto ciò che ha fatto nel corso degli anni con Miles Davis.
AAJ: Solo con Davis? E tutto il resto?
D.B.: Credo fermamente che nel jazz i capolavori nascano soltanto quando si mettono insieme elementi di eccellenza, sia come compositori (o arrangiatori: ci tengo a questa distinzione), sia come esecutori, sia come solisti creativi (improvvisatori è una definizione che mi sembra vada stretta, in questo caso). Ci sono momenti in cui tutto è fantastico, come un'esplosione, e altri in cui tutto è semplicemente molto bello. Negli ultimi anni Gil, dopo aver organizzato tutto, stava appollaiato dietro la sua tastiera, aspettando che questo botto arrivasse: l'ho ascoltato molte volte, e si percepiva distintamente questa situazione, che, d'altra parte, mi è stata confermata dai suoi musicisti.
AAJ: In ogni caso il fatto che tu non ti senta troppo vicino a Gil Evans ha del sorprendente: più o meno tutti evidenziano, in pratica da sempre, questa sorta di imprinting.
D.B.: Certamente ci saranno dei punti in comune: non credo esista la possibilità di creare qualcosa completamente avulso dal contesto in cui si opera. Tuttavia mi sembra che sia il concetto della struttura che la scelta delle emozioni da trasmettere siano decisamente differenti. C'è un solo brano - composto nel 1986 - in cui ho voluto omaggiare questo grande arrangiatore. Si tratta di "Don't You Feel This Way Too - Sometimes" , concepito come showcase per Gianluigi Trovesi e David Friedman.
AAJ: Altrettanto sorprendente che tu non conosca - come mi dicevi una volta - Maria Schneider, perché anche in questo caso una sensibilità comune appare evidente.
D.B.: Purtroppo non sono mai riuscito a sentire niente di lei. Però, se ci sono punti in comune forse è meglio così, in modo che non mi venga la tentazione di adeguarmi...
AAJ: Al di là del fatto che - detto a scanso di equivoci - nessun elemento specifico riveli in questo caso parentele di sorta, conosci il linguaggio delle orchestre free? Cosa ne pensi?
D.B.: Malgrado alcuni esempi affascinanti, l'estetica free mi pare più adatta all'interazione spontanea di gruppi non molto ampi. D'altro canto, a mio avviso, la big band nella sua accezione tradizionale è finita in un vicolo cieco: bisogna ritrovare quell'apparente libertà che ha portato a certi capolavori assoluti di Ellington, a quella capacità di innovare continuamente senza farlo notare, senza proclami. Vedi: è estremamente difficile mettere insieme una grossa orchestra capace di questo, e ovviamente è molto più comodo prendere delle scorciatoie e rifugiarsi nel manierismo, che in fondo porta sempre al consenso del pubblico. Perché il pubblico preferisce le cose ben codificate e certificate, che non gli creano problemi.
AAJ: Spesso, in effetti, è così. Il problema è che quasi altrettanto spesso anche la critica, o buona parte di essa, asseconda tale andazzo. Ormai da troppi anni sembra che la professionalità (la tecnica, la padronanza di un dato linguaggio, ovviamente largamente storicizzato) basti da sola a giustificare il plauso di chi di musica disquisisce. Personalmente ho una certa nostalgia per certe buone vecchie stroncature, quando esprimere dubbi - anche pesanti - sulla validità di un dato prodotto era considerato (magari non da tutti, ma da molti) un dovere del critico. Tu come la vedi?
D.B.: Non mi sento di fare la critica ai critici. Forse ci vorrebbe un approccio un po' più musicologico. Ma questa è probabilmente una mia fissazione. Io credo comunque che uno dei punti fondamentali per giudicare un musicista jazz stia non tanto nell'abilità tecnica o nella fedeltà a determinati modelli, quanto piuttosto nella capacità di dire qualcosa che non è ancora stato detto, almeno in parte, e di trasmettere un'emozione destinata a rimanere (che non si esaurisca nel momento dell'ascolto, cioè). Il jazz è sempre stato una musica sincretica, con una fortissima pulsione verso il cambiamento continuo, ma anche con la capacità di comunicare con immediatezza agli ascoltatori emozioni e concetti importanti, in ciò distinguendosi marcatamente dalla musica accademica contemporanea. È per questo, a conti fatti, che il jazz mi affascina.
AAJ: Un'ultima domanda: come mai quel lungo black-out nella tua attività (o quanto meno nella tua discografia) tra la fine degli anni Ottanta e i Duemila inoltrati?
D.B.: Semplicemente mi sembrava di non avere più niente di nuovo da dire. C'è talmente tanta musica bella, che è inutile metterne in circolazione di nuova, se non è in grado di aggiungere qual-cosa di interessante, di emozionante. I sedici anni che separano Space Blossoms e Ithaca/Ithaki mi sono serviti per pensare, ascoltare (poco jazz, molta classica e contemporanea), cercar di capire dove fosse possibile aprire un capitolo nuovo, che cosa volessi davvero comunicare attraverso la musica, e come. Ho fatto molte ipotesi diverse, che tuttavia non riuscivano a soddisfarmi, ma alla fine il bisogno di comporre è stato più forte e ho ripreso scrivendo il tema di "My Constant Thought". Ricominciare è stato faticoso, perché avevo perso molti automatismi tecnici, ma forse proprio per questo ancor più affascinante.
AAJ: Programmi più o meno immediati?
D.B.: Fra un anno festeggerò (spero) un anniversario importante, e mi piacerebbe incidere un nuovo album. Ho cominciato a scrivere, in mezzo ai soliti dubbi sul fatto di riuscire non solo a non ripetermi pur rimanendo coerente, ma di esser capace di trasmettere agli altri le emozioni che provo io nel vivere, nel rapportarmi con gli altri, con il mondo, con il trascendente (che potremmo anche chiamare "la poesia del tutto"). Certo, sarebbe fantastico non limitarsi allo studio di registrazione (dove si fissa un momento preciso, immodificabile), ma portare la musica in mezzo alla gente, modificandola di volta in volta a seconda della situazione e dell'intercomunicazione con il pubblico. Le rare volte in cui ho questo privilegio è sempre un'esperienza esaltante.
AAJ: Quindi dobbiamo aspettarci un album live?
D.B.: Sarebbe un mio sogno, ma un grande desiderio anche di tutti i musicisti che fanno parte di quella che ho definito la "compagnia stabile". Però tutto dipende da fattori esterni alla nostra volontà. Meglio una produzione in studio piuttosto che niente del tutto, oppure con riprese sonore non all'altezza.
Foto di Allegra Betti Van Der Noot (Betti Van Der Noot) e Dave Land (Kenton)
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.