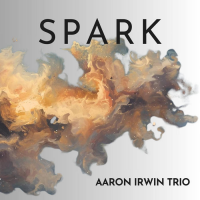Home » Articoli » Lyrics » Borah Bergman, il pianista che incrociava le mani
Borah Bergman, il pianista che incrociava le mani
Di lui, in Europa, si era cominciato a parlare verso il 1980, quando avevano iniziato a circolare, destando un certo scalpore, i suoi due primi album di piano solo, Discovery e Burst of Joy, incisi per la Chiaroscuro fra il 1975 e il '77. Quel pianismo informale, intricato, con quelle continue gragnuole di note, aveva fatto immediatamente venir fuori il nome di Cecil Taylor, senza accorgersi della diversità fra i due approcci: decisamente più percussivo, per certi versi scultoreo, Taylor, più trasparente, netto, appuntito, Bergman. Qualcuno, più attento, aveva aggiunto così anche il nome di Lennie Tristano, in particolare il Tristano di Descent into the Maelstrom. E Borah aveva gradito. Dichiarando per esempio: "La mia vicinanza con l'universo tristaniano è antica e ininterrotta. Senza presunzione, penso di aver ulteriormente sviluppato certe sue intuizioni. Ho sempre colto, fra l'altro, una stretta relazione fra la sua musica e quella di Ornette Coleman. Tristano sarebbe stato un ottimo pianista per Ornette. Del resto il suo stile ha sempre avuto una matrice forse più sassofonistica che pianistica. Anche in questo lo sento molto vicino, per quanto la nostra sia un'affinità soprattutto concettuale, perché il mio pianismo è più spigoloso, frammentato, mentre il suo era più lineare" [Nota 1].
Mettendo da parte quanto affermato a proposito di Ornette Coleman, su cui torneremo, annotiamo ancora come, di Borah Bergman, avesse colpito in particolare un brano presente in Discovery, "The Third Hand," per mano sinistra sola. Una cosa piuttosto inaudita, che aveva fatto pensare immediatamente a un mancino. Particolare che il diretto interessato aveva prontamente negato: non era mancino, né gli risultava di appartenere alla schiera dei cosiddetti "mancini corretti" (il mancinismo, così come l'omosessualità, per una certa società, erano anomalie inaccettabili, storture, che andavano appunto "corrette"). "È stata unicamente la grande applicazione posta sulla mano sinistra - aveva rivelato - a consentirmi certi exploit. Proprio grazie all'indipendenza fra le due mani che ho ottenuto attraverso lunghi studi, posso sviluppare più linee che s'intersecano".
Un'altra peculiarità tutta bergmaniana era suonare in effetti a braccia incrociate, invertite: la destra sui bassi, la sinistra sugli acuti, pratica a sua volta frutto degli studi di cui sopra, tesi, non ultimo, a determinare dinamiche diverse per le due mani. E non solo: la stessa disposizione delle dita ne traeva differenze sostanziali rispetto alla consuetudine, visto che i due mignoli venivano a trovarsi dove di solito stanno i pollici, e viceversa. Senza sottovalutare, ancora, il peso e le dinamiche diverse che la muscolatura degli avambracci veniva a generare.
Tutto ciò consentiva a Borah Bergman anche di dare voce a un particolarissimo percorso espressivo che una volta ci aveva descritto passeggiando per Bolzano, città che lo amava, ne accarezzava il talento e l'indole così particolare come probabilmente nessun'altra al mondo e al cui festival si è ripetutamente esibito (anche di questo riparleremo): "La mia mente è come scissa in due. Per metà sono rettilineo, seguo un'idea nel suo progredire, giustapponendo i vari stadi nella loro concatenazione logica. Nell'altra metà, invece, gli input mi arrivano tutti insieme, e io non posso far altro che sovrapporli, senza ordinarli né svilupparli fino in fondo". Aveva a quel punto adibito una piccola spianata di sabbia a lavagna, tracciandovi con l'indice una linea con tante intersezioni consecutive, e a fianco un cerchio in cui faceva mulinare vorticosamente le dita, schizzando una miriade di piccoli e nervosi segni sovrapposti. Qualche passante lo osservava interdetto.
Eliminiamo uno dei due sospesi per spendere ora qualche parola sull'evocato Ornette Coleman. Nella circostanza di cui sopra, Borah ci aveva detto in proposito: "Per come lo vedo io, Ornette è un musicista squisitamente americano, e se proprio vogliamo più asiatico, elettivamente (soprattutto indiano), che africano. Pur non amando chi fa troppi distinguo tra i jazzmen in base al colore della pelle, credo proprio che Ornette, se fosse stato bianco, si sarebbe dedicato alla composizione "colta". Pur non essendo un vero e proprio teorico, ne ha tutte le potenzialità, perché il suo è un talento essenzialmente compositivo".
Possiamo essere d'accordo o meno su questa interpretazione del genio di Fort Worth, ma così la pensava Borah Bergman. Che un'altra volta, molti anni più tardi, sarebbe andato anche più in là, tendendo un filo diretto tra sé e Ornette, senza mancare di tirare in ballo Cecil Taylor e, implicitamente, ancora Tristano. Quella volta era seduto al pianoforte, e poteva quindi esprimere de facto quanto andava affermando con le parole. Che erano state più o meno queste: "Chi mi accosta a Taylor, dovrebbe capire quale distanza esiste fra il suo approccio, così spiccatamente percussivo, con le due mani che si muovono a blocchi [e scimmiotta lo stile tayloriano], e il mio, in cui la melodia è sempre presente, anche quando nessuno se ne accorge, per la velocità con cui le note si concatenano, e più ancora si sovrappongono, grazie all'indipendenza delle due mani. Se suono con una mano per volta [lo fa], tu cogli la singola melodia, ma se le due linee melodiche di sovrappongono, una per mano [fa anche questo], fai un po' più fatica". Andrà rivelato che le due melodie in oggetto sono entrambe di Ornette Coleman, ciò che consente a Borah di affermare, alla fine di tutto: "Ornette può suonare solo una melodia per volta, perché usa il sassofono. Io posso suonarne due: ognuna delle mie due mani è un sassofono di Ornette Coleman!".
La tesi secondo cui l'approccio pianistico di Borah Bergman - come già quello di Tristano - è marcatamente sassofonistico (o comunque da strumento ad ancia) poggia su svariati elementi. Il primo è strettamente biografico e riguarda l'evolversi della sua pratica strumentale. In età formativa, infatti, Borah interseca - o meglio: giustappone - lo studio del piano con quello del clarinetto. Al primo si avvicina a sette/otto anni, per abbandonarlo a tredici, appunto in favore del clarinetto, a sua volta abbandonato con la mira di diventare scrittore di racconti, per tornare infine al pianoforte verso i ventiquattro/venticinque. Rispetto alla narrativa, in effetti, la musica lo attrae maggiormente perché offre la possibilità di dire le cose in tempo reale.
Sono i primissimi anni Cinquanta: gli capita di prendere qualche lezione da Teddy Wilson, che automaticamente diviene - con Art Tatum - una delle sue principali influenze, almeno in una fase iniziale. In realtà ascolta soprattutto i sassofonisti (per esempio Lester Young, e naturalmente Charlie Parker) e su di loro costruisce il suo stile pianistico. "Mi ha sempre interessato specialmente l'aspetto ritmico - dichiarerà - e se tu ascolti un sassofono, il suo suono più netto, robusto, te ne fa avvertire tutta la forza appunto ritmica. È stato grazie a Tristano che ho capito che era possibile far convivere nel mio pianismo le mie due anime: quella, appunto, del pianista in quanto tale, e quella del sassofonista. E in fondo l'aver successivamente sviluppato con tanta determinazione l'uso della mano sinistra è un'ulteriore risposta a questa esigenza di esprimere contemporaneamente due diversi impulsi".
Degli anni che vanno dall'inizio dei Cinquanta alle sue prime incisioni, sappiamo poco o nulla. Sappiamo che, oltre a Tristano, ama e segue Monk e Bud Powell, Bill Evans e Paul Bley, Ornette e la rivoluzione free, concettualmente così vicina alle sue coordinate espressive. Né è certo insensibile all'epopea coltraniana. "Coltrane - affermerà - era molto vicino alla morte, ma proprio per questo la sua musica è così vitale, energica, aggressiva. Un altro musicista con un grande senso della morte, della tragedia, è Steve Lacy, straordinario soprattutto sui tempi medio-lenti (non a caso è un ottimo interprete di Monk). La differenza, rispetto a Coltrane, è che il dolore che aleggia nella sua musica è sempre espresso con estrema souplesse, senza aggressività".
Per molti anni, quindi, Borah Bergman è soprattutto un ascoltatore, uno studioso, un "fiancheggiatore" del jazz. Si dedica anche all'insegnamento, mentre cresce la voglia di incidere qualcosa di proprio. Lo frena a lungo il timore di non riuscire a esprimere compiutamente quanto è andato maturando negli anni. La cosa arriva a rasentare l'ossessione (lo confesserà lui stesso, anni dopo). Sembra essere molto vicino alla meta nel 1972, quando è Orrin Keepnews a insistere per farlo incidere. In realtà i provini realizzati non convincono fino in fondo il pianista, per cui il debutto discografico rimbalza al 1975, col citato Discovery (note di copertina di Nat Hentoff), cui segue due anni dopo Burst of Joy. Sono, come detto, due album per piano solo, formula cui Bergman sembra legato inestricabilmente anche nel momento in cui il suo nome inizia a circolare in Europa, giungendo - in particolare - al suo primo tour italiano nell'estate '81 (Genova, Milano...), grazie ad Arrigo Polillo, che lo mette anche in contatto con Giovanni Bonandrini, il quale produrrà - su Soul Note - i suoi primi album europei, a loro volta solitari: A New Frontier, registrato a New York nel gennaio '83, e soprattutto Upside Down Vision, il più completo, sfaccettato ritratto discografico del pianista fino a quel momento, inciso a Milano, Studio Barigozzi, fra il luglio e l'ottobre 1984.
Il disco, in cui compare anche un nuovo episodio per mano sinistra sola, "Prelude to an Apex," esplicita una volta per tutte quanto i relitti di un lirismo pur ipercerebralizzato già coglibili nei lavori precedenti pesino nella sua poetica. Quell'estenuante rimuginare sui tasti, quasi schiaffeggiandoli, quello scarnificare i brandelli di melodie già di per sé scheletriche, infatti, convivono qui con una cantabilità che brani come "Ballad of a Child Alone," "Poignant Dream," attraversato da un intimismo scuro, pudico fin quasi all'alienazione, con frammenti sospesi e iridescenze riflesse (per difetto di quantità), e "Spirit Song" (in memoria di Polillo, appena scomparso) lasciano ora libera di espandersi senza più remore o pudori. C'è, inoltre, subito in apertura, la title-track, brano paradigmatico se ce n'è uno, in cui le due mani del pianista, indipendenti come da copione, incanalano (e quindi uniscono, miscelano) ciascuna un rivolo del flusso creativo bergmaniano, quel grumo proteiforme, quel gorgo ribelle, al cui interno il disco - e questo brano in particolare - ci aiuta non poco a districarci: cristallina, quasi timida, impaurita, la destra sul registro acuto; turbinosa, magmatica, instancabile la sinistra su quello medio-grave. O il contrario, se si è verificato il fatidico incrocio delle braccia...
Il 1985, oltre a vedere l'uscita di Upside Down Vision, fa registrare il primo abboccamento fra Borah Bergman, che per tutti gli anni Ottanta rimarrà pur sempre uomo assolutamente da solo performance, e un musicista altro da lui, nello specifico Evan Parker. Sarà lo stesso pianista a rievocare la cosa nel 1990, allorché la partnership col sassofonista inglese salirà ufficialmente agli onori della cronaca: "Suonavo in Belgio a un festival in cui era presente anche Evan Parker. Qualcuno suggerì che eravamo tagliati per suonare insieme, e così abbiamo provato, in seguito anche in Inghilterra. Da quel momento ha iniziato ad attrarmi molto l'idea di dialogare con altri musicisti, anche in organici più ampi del duo. Gente come John Zorn, il vostro Trovesi, o Gerry Hemingway, Andrew Cyrille, Joey Baron, tutti batteristi, ma anche trombonisti, tipo Paul Rutherford, Albert Mangelsdorff, Radu Malfatti, Connie Bauer, Giancarlo Schiaffini, tutti europei, perché il trombone è strumento senz'altro più europeo che americano. D'altronde mica ho suonato sempre da solo: a casa ho parecchi nastri, anteriori al mio primo album, con altri musicisti, soprattutto batteristi. È stato ascoltando una volta Sonny Rollins che mi è venuta la voglia del solo. In realtà Rollins era in trio, ma era come se suonasse da solo".
Con alcuni dei musicisti citati, come vedremo, Borah Bergman avrà effettivamente modo di suonare negli anni a venire. Resta il fatto che, da questo momento, il duo diventa il suo terreno d'espressione prediletto. Nell'estate 1990 approda per esempio in Italia, al Jazz Summer di Bolzano (dove già si è esibito, in solo, nell'84 e nell'86), il duo con Evan Parker, che in marzo ha inciso The Fire Tale, album di grande respiro e spessore, sia individuale che globale, nella somma di due personalità tanto marcate quanto complementari, che peraltro la Soul Note pubblica solo nel '94 [Nota 2]. Esattamente due anni dopo, nel luglio '92 è ancora il festival bolzanino (e non solo) a ospitare il duo con Andrew Cyrille - storico batterista di Cecil Taylor, ricordiamolo [Nota 3] - fresco reduce (29 e 30 giugno) dall'incisione, al Barigozzi di Milano, di The Human Factor, sempre su Soul Note. E ancora del '92 è Inversions (MuWorks), in cui Bergman dialoga con sassofoni e flauti di Thomas Chapin, esperienza che si ripete di lì a cinque anni nel vivacissimo Toronto 1997 (Boxholder), di pochi mesi anteriore alla prematura scomparsa, a quarant'anni, del talentuoso polistrumentista del Connecticut (febbraio '98).
La sequenza dei duetti prosegue feconda negli anni a venire, accanto a Roscoe Mitchell, abbinamento disadorno e anticonsolatorio quanto altri mai, in First Meeting (Knitting Factory Works) e The Italian Concert (Soul Note), realizzati tra il dicembre '94 e il luglio '95 fra New York (in un brano, il tripartito "One Mind," con l'aggiunta di Thomas Buckner alla voce) e ancora Bolzano, Hamid Drake, in Reflections on Ornette Coleman and the Stone House (Soul Note, marzo '95), in cui compaiono icone ornettiane quali "Focus of Sanity," in duplice versione, "Lonely Woman," "Congeniality" e "Peace," Ivo Perelman (Geometry, Leo, giugno '96), e Oliver Lake (A New Organization, Soul Note, luglio '97). Non solo: poggiando su un'analoga filosofia estetica (e gerarchica, ammesso che il termine sia concepibile in quest'ambito), il duo - come formula - si amplia non di rado a trio. È, in particolare, Peter Brötzmann che, fra '95 e '97, incontra il pianista in contesti del genere, in due casi (Ride into the Blue e Blue Zoo, entrambi su Konnex) con l'altro sassofonista Thomas Borgmann a completare l'organico, altrove aggiungendosi al duo con Andrew Cyrille (in Exhilaration, Soul Note) o, ancora, in compagnia di Anthony Braxton, specificatamente in Eight by Three (Mixtery), album non di rado al calor bianco, fra turbolenze brötzmanniane e angolosità braxtoniane.
Sempre fra il '95 e il '97, con Jim Staley, trombone e didjeridoo, e Phoebe Legere, fisarmonica e voce, Borah Bergman realizza, ancora, Blind Pursuits (Einstein), con Connie Bauer e Mat Maneri, nel 2000, The River of Sound (Boxholder), col batterista Paul Hession e, rispettivamente, il sax soprano di Lol Coxhill e le ance di George Haslam, entrambi nel 2003, Act of Love (Mutable Music), fra le sue incisioni più significative del nuovo millennio [Nota 4], e The Mahout (Slam). Addirittura un quartetto è infine quello che fin dal 1994 (ottobre) aveva inciso, dal vivo a New York, The October Revolution (Evidence), nello specifico una suite bipartita di oltre un'ora dedicata a Bill Dixon, con Joe McPhee al sax tenore e al flicorno, secondo suo costume, Wilber Morris al basso e Rashied Ali alla batteria [Nota 5].
Approssimandosi all'ultima fase della sua parabola creativa, Borah Bergman non dimentica peraltro la germinale frequentazione del piano solo. Ce lo dice, per metà, Rivers in Time (FMR, 2002), altrove in duo col clarinettista e sassofonista norvegese Frode Gjerstad, e ce lo dice, soprattutto, Meditations for Piano (Tzadik, febbraio 2003), excursus in sette episodi che, tenendo del tutto fede all'assunto del titolo, perlustrano i fondali più intimi, distillati, spesso quasi minimali, attoniti, dell'universo bergmaniano, tratteggiando nell'insieme un'opera di totale, rara coerenza intestina. In altre parole una gemma di assoluta unicità.
E arriviamo così all'ultimo scorcio della vita artistica di Borah Bergman. Che, ancora una volta, si consuma in buona parte in Italia, fra Genova e Tortona. Da Genova arriva il violinista Stefano Pastor, che a Tortona, il 1° luglio 2007, suona per la prima volta in duo con Borah. La registrazione del concerto uscirà poi su Mutable Music col titolo Live at Tortona. Vi trova posto, fra l'altro, un nuovo struggente episodio, in piano solo, in memoria di Arrigo Polillo, "When Autumn Comes" [Nota 6]. Sempre a Genova, l'ormai ottantenne pianista incide quattro giorni dopo, stavolta in studio, One More Time (Silta), in duo col contrabbassista Giorgio Dini. Il 30 settembre 2008 entra infine per l'ultima volta (almeno a quanto ne sappiamo a tutt'oggi) in sala d'incisione, esattamente all'EastSide Sound di New York, per incidere Luminescence, pubblicato nel 2009 dalla Tzadik di John Zorn, che compare anche, all'alto, in uno dei sei brani, "Luma," unendosi al trio con Greg Cohen al contrabbasso e Ken Wollesen alla batteria protagonista del disco, giocato per lo più nel segno di una leggibilità magari inusuale per il Borah Bergman sedimentato, come immagine, nella memoria dei più, ma certo tutt'altro che estraneo al processo di progressivo spogliamento che il pianista andava maturando da tempo, e che quanto abbiamo cercato di descrivere dovrebbe aver eloquentemente documentato.
Dopo la serata tortonese, la lavorazione e l'uscita del relativo CD, per quanto ci riguarda di Borah Bergman abbiamo un po' perso le tracce. Ed è triste, perché capita poi di sentir riparlare di un grande musicista che è stato anche un amico solo nel momento in cui si diffonde la notizia della sua scomparsa. Abbiamo saputo poi, da Stefano Pastor, dei primi problemi di salute insorti all'inizio del 2010, del conseguente trasferimento a Boston, vicino alla sorella e alla nipote, di un miglioramento, con nuove opportunità concertistiche, grazie all'interessamento di John Blum e altri amici, al Vision Festival 2010 e anche altrove, più di recente. Poi la crisi finale che ce l'ha portato via definitivamente.
Desideriamo quindi chiudere questo excursus-tributo al grande pianista sottolineando quanto Borah Bergman fosse artista a tutto tondo, curiosissimo e attentissimo verso qualunque cosa fosse espressione della creatività umana. Figlio di un poeta ("a modo suo," come recita la dedica posta sull'album in duo con Evan Parker), storyteller mancato, Borah è sempre stato sensibile, in particolare, alla pittura. Notevole era la sua adesione - anche proprio concettuale - al cosiddetto espressionismo astratto, specialmente a Willem de Koonig, per la sua compenetrazione fra lirismo e matericità, e più ancora a Jackson Pollock, al cui stile pittorico amava avvicinare la sua musica. Un punto, in particolare, sentiva che lo legava a Pollock: "Non riusciva mai a considerare finite le sue tele, cosicché gli amici dovevano entrargli in casa e staccargliele letteralmente dalle pareti. Anch'io, con la mia musica, ho sempre l'ansia di non sapermi fermare in tempo. Il segreto, oggi, mi sembra lasciar correre la melodia senza affastellarla di troppo altro. Preservarne l'essenza, la cantabilità. Come faccio quando recupero melodie assolutamente piane, lineari, che ho scritto tanti anni fa. Sì, perché quasi nessuno lo sa, ma io, da giovane, volevo diventare un songwriter...".
NOTE:
1. Tutte le dichiarazioni di Borah Bergman riportate nel testo provengono dalle svariate conversazioni avute con lui fra il 1990 e il 2007.
2. Purtroppo non sarà questo l'unico album di Borah Bergman a venir pubblicato anche diversi anni dopo la sua registrazione, intricando - e compromettendo - non poco la comprensione di un talento in rapida evoluzione/espansione, in anni di incisioni anche molto ravvicinate, quasi accavallate. Per chiarezza, le date da noi indicate di volta in volta si riferiscono sempre all'incisione del disco.
3. Proprio al termine del concerto bolzanino, il batterista così sintetizzava le differenze fra Bergman e Taylor: "Borah rimane nonostante tutto un pianista che parte dalla melodia, pur assoggettata a trasfigurazioni e sovrapposizioni continue e vorticose di altre cellule esterne. Cecil, invece, è un pianista essenzialmente ritmico. Per lui si può parlare al massimo di microtematismo, comunque a posteriori, frutto dell'atto improvvisativo. Lavorandoci insieme, Borah chiede effetti precisi (dinamiche, colori, ecc.), sia pure in un contesto di grande libertà, mentre Cecil quasi mai mi ha suggerito come entrare nella sua musica, diciamo nell'ordine dell'uno o due per cento. Lavorare con lui, a partire dal 1964, mi ha permesso di liberare tutto ciò che avevo dentro di me. Essendo - come dicevo - la sua una rivoluzione soprattutto ritmica, metrica, si potrà capire cosa potesse significare essere il suo batterista".
4. Con questo trio, nel 2005 Borah Bergman si esibisce un'ultima volta a Bolzano, sua sesta presenza al festival, che nel frattempo è diventato Jazz & Other. Ci sarebbe peraltro da aggiungere un'ulteriore presenza, nel 1985, per una registrazione (in solo) presso la sede RAI cittadina. Nell'occasione, si verifica fra l'altro un episodio tanto curioso quanto emblematico della personalità del pianista. Ce lo rievoca Nicola Ciardi, storico patron del Jazz Summer e grande amico-sostenitore di Borah: "Quella sera, dopo cena, siamo andati a casa di un'insegnante di pianoforte. Ho tentato di fargli suonare qualcosa, ma sembrava non esserci niente da fare. Dopo un po,' però, Borah si è alzato ed è andato al piano, dove c'era uno spartito di Chopin appoggiato sul leggio. Ha iniziato a suonare. Dopo qualche nota, la padrona di casa esclama: «Mio Dio, non è possibile! È mostruoso!». Borah stava suonando lo spartito al contrario, dal basso verso l'alto, e con la mano destra dalla parte della sinistra e viceversa! Naturalmente nessun'altro, eccetto la padrona di casa, si era accorto di nulla."
5. Completa il CD un ben più breve brano del trio di Myra Melford, mentre, fra i quartetti non documentati su disco, varrà la pena di ricordare almeno quello con Louie Belogenis al sax soprano, William Parker al basso e Michael Wimberly alla batteria esibitosi nel 2009 a The Stone di John Zorn.
6. La registrazione del concerto di Tortona include peraltro una buona mezz'ora di ottima musica che per scelta di Borah Bergman è rimasta fuori dal CD. Il duo, del resto, negli stessi giorni della serata tortonese ha realizzato anche un master in studio per la Soul Note a tutt'oggi inedito.
Foto di Scott Friedlander (la prima), Christof Wagner (la seconda), Alberto Bazzurro (la terza e la sesta), Roberto Polillo (la quarta), Juan Carlos Hernandez (la quinta), John Sharpe (la settima), Martha Holmes (l'ultima).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.