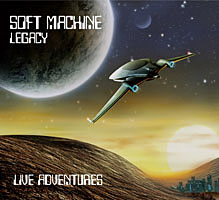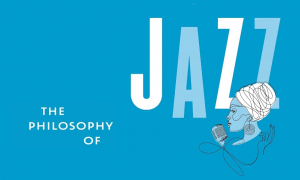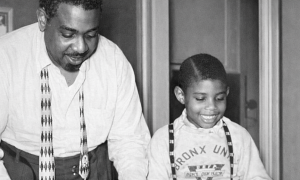Home » Articoli » Lyrics » Bach-Caine. La variazione infinita (Die Endlos-Variation)
Bach-Caine. La variazione infinita (Die Endlos-Variation)
Sono convinto che in questo dopoguerra stia costituendosi una cultura nuova, e che in America essa si manifesterà nella forma di un rinascimento musicale.
Edgar Varèse, 1922
Una volta, ad Amsterdam, un musicista olandese mi disse: "Dev'essere ben difficile per voi americani scrivere musica, distanti come siete dai centri della tradizione". Dovetti rispondere: "Dev'essere ben più difficile per voi europei, vicini come siete ai centri della tradizione".
John Cage, 1958
Ci piaccia o no, l'era del compositore inteso come autonoma intelligenza musicale è praticamente conclusa. A questo punto della storia musicale, la questione cruciale è: "Cosa fa, esattamente, un compositore?".
John Zorn, 1987
Datemi qualcosa, qualsiasi cosa e io ve la organizzerò: questo è il mio lavoro.
Frank Zappa, 1989
Lo si giudichi profanazione o rivelazione, il fatto che quest'Aria mit verschiedenen Veränderungen di Johann Sebastian Bach, così antica e illustre, finisca tra le mani di un musicista americano ha in sé qualcosa di ineluttabile. L'ineluttabilità non ha a che fare con Bach e neppure con quest'opera in particolare. Al loro posto - è già accaduto - avrebbero potuto esserci altri, Lasso o Mozart, il Vespro di Monteverdi o il Tristano di Wagner. E neppure ha a che fare necessariamente con Uri Caine. Al posto di questo pianista e compositore cresciuto a Philadelphia e approdato al Lower East Side newyorkese, avrebbe forse potuto esserci qualcun altro dei non pochi artisti musicalmente poliglotti che in questi anni si sono messi d'impegno nel trattare la sclerosi del nostro immaginario musicale a suon di elettroshock. Ma forse non poteva essere che lui, Caine, 44 anni, la cui fedina musicale annovera già una cospicua serie di precedenti che rispondono al nome di Mahler, Wagner, Schumann.
In effetti, la biografia di Caine offre qualche appiglio. Gli studi musicali con Bernard Peiffer, ad esempio, pianista francese eterodosso che richiedeva all'allievo di comporre dei brani originali, mostrandogli poi come rielaborarli in una vasta gamma di stili diversi. Fino al singolare binomio del giovane jazzista già in carriera che, intanto, studiava composizione con George Rochberg e George Crumb. Questo senso di ineluttabilità non ha nulla a che spartire - per fortuna - neppure con quella visione storicistica che faceva dire al buon vecchio Schönberg: "qualcuno doveva esserlo, nessuno voleva esserlo, così mi sono prestato io". L'alone di fatalità che si irradia dall'incontro di questa comitiva variopinta con la musica di Bach, deriva piuttosto dal fatto che questo meeting sembra fungere da bacino collettore di una rete di innumerevoli affluenti, fattori tutti ugualmente decisivi che hanno rivoluzionato così in profondità lo scibile uditivo del nostro tempo.
Questi fattori hanno un nome. Ve ne sono di molto concreti: riproduzione audio, telecomunicazioni, Cage, prassi esecutiva della musica antica, mediamorfosi (Blaukopf), oralità di secondo grado (Ong), arte plagiaria, multiculturalismo. Altri, non meno decisivi, hanno operato e operano sul piano della teoria: l'idea della Nachleben (la "vita postuma" di cui parla Benjamin), opera aperta, situazionismo, Rezeptionstheorie, postmodernità, teoria della cooperazione testuale ("Mes vers ont le sens qu'on leur prête" diceva Valéry), semiosi infinita. Nel momento in cui viene meno un sistema gerarchico fondato su un solo sapere autocentrico e legittimante, la percezione di un'alterità che sovrasta e disgrega la comunità linguistica e civile, assume un rilievo fortissimo. Questo venir meno per gli uni è fonte di angoscia, per altri di eccitazione: esattamente i due estremi del ventaglio di reazioni che, di norma, provoca Uri Caine quando manipola e fa sue musiche altrui, violandone l'aura sacrale in cui sono avvolte. O segregate.
Come sempre è accaduto in casi del genere, queste "Caine Variations" vengono alla luce in un crocevia quantomai affollato. Dal luogo in cui siamo, vediamo la tradizione musicale dotta, incardinatasi sempre più, secolo dopo secolo, al culto del testo scritto, entrare in collisione con l'universo multiforme dell'improvvisazione, la deejay culture, l'estetica del collage sonoro per cui al "comporre la musica" si affianca o subentra il "comporre con la musica". Inoltre, almeno in parte, queste "Variazioni sulle Variazioni Goldberg" entrano nella sfera della fonografia di cui parla Evan Eisenberg; ossia musica figlia della radiofonia, della tecnologia elettroacustica e del mixaggio, concepita per il supporto audio e per le suggestioni dell'ascolto domestico; un ascolto soggetto alla scelta individuale, che può essere ripetuto, frazionato, sfogliando il disco a piacere, come un libro.
Il semiologo direbbe che il livello neutro di quest'opera, più ancora che dalla partitura, è rappresentato dalla registrazione discografica che offre all'ascolto una schiera di interpreti, una varietà di stilemi, una così perfetta miscelazione di ingredienti sonori, una così calibrata regia e concatenazione degli eventi che ben difficilmente potrebbero essere restituiti integralmente in una sala da concerto.
Ma c'è dell'altro. Alle fondamenta di questa creazione musicale c'è una diversa pronuncia etica dell'operare artistico che è tipicamente statunitense, un'etica così profondamente impregnata di pragmatismo da risultare quasi inconciliabile con l'estetica del vecchio continente. E ancor più quando questo pragmatismo di fondo si sposa - come in questo caso - con un'idea libertaria che discende da Ives e da Cage, vale a dire con uno sperimentalismo felice di passeggiare in un paesaggio sonoro che ignora gerarchie, recinti stilistici o di genere, facendosi gioco di ogni precettistica e raccogliendo lungo il cammino tutto ciò che stimola la fantasia creatrice.
È accaduto ogni qual volta Uri Caine si è accostato a un compositore del passato riscrivendone la musica a modo suo, e accadrà anche con questa musica di Bach, sottoposta a un procedimento di variazione al quadrato che la rende irriconoscibile, geneticamente mutante. Per chi ascolta, questo binomio Bach-Caine è un terremoto che porta in superficie gli a priori, le idées reçues in materia di estetica quotidiana.
Prima ancora di formarsi un'opinione sul valore musicale intrinseco della realizzazione musicale, il pubblico si divide in sostenitori e inquisitori. Da una parte c'è chi non trova nulla di blasfemo nello sposare Bach ai più diversi generi e stili musicali di oggi o di ieri; nel trattare il basso ostinato su cui si reggono l'Aria e le 30 variazioni originali alla stregua di uno standard jazzistico; o nel fatto che questa materia musicale venga trattata da un gruppo di deejay. Dall'altra parte stanno invece i fedeli del tradizionalismo in musica i quali, turandosi le orecchie, scagliano la loro condanna - a priori e inappellabile - in forma di anatema contro le nefandezze della contaminazione.
Tenuto conto che l'esecuzione concertistica può variare a seconda delle circostanze, il lavoro si presenta come una sorta di componibile formato da decine di tasselli, circa la cui architettura complessiva la versione discografica fornisce una possibile, per quanto relativa, traccia di riferimento. La versione su disco dura complessivamente 2 ore e 34 minuti e comprende 72 brani. Come nell'originale bachiano, l'Aria è collocata in apertura e in chiusura. La prima volta la si sente risuonare in una grande sala, eseguita su un fortepiano Silbermann.
La conclusione è invece molto più intima, ravvicinata. Uri Caine suona il pianoforte, ma a un certo punto, con discrezione - quasi volesse non dare nell'occhio - cambia, ancora una volta, le note dell'Aria. È l'ennesima variazione, lieve, quasi dissimulata, la cui ultima nota si prolunga in un alone metafisico. The Eternal Variation - così si chiama questa appendice conclusiva realizzata da Danny Blume - è poesia elettroacustica e fors'anche un pensiero a La Monte Young: un sol, immobile, lentamente cangiante, i cui armonici sbocciano delicatamente e nei quali la memoria dell'Aria permane come un'ombra leggera ma indelebile.
La scelta degli strumenti è di per sé una dichiarazione d'intenti circa la natura virtuale e utopica di questa rilettura. Le Variazioni Goldberg furono scritte da Bach nel 1740 per un clavicembalo a due tastiere: l'unico strumento a tastiera che Caine non utilizza. A dire il vero, il cembalo lo si ascolta spesso, impiegato però come basso continuo nelle arie trascritte per ensemble barocco. C'è la copia di un fortepiano di Gottfried Silbermann, simile allo strumento che Bach conobbe e forse possedette; c'è l'organo Hammond, in versione soul e in versione chiesastica; c'è il pianoforte, indebitato con Glenn Gould; e c'è l'elettronica, il sintetizzatore di Wendy Carlos e le tastiere Midi, cui sono affidate le variazioni più fortemente denaturate, sovrastate dal rumore, accelerate, percosse da uno scatenato drum & bass di marca techno o jungle, e dai remix corrosivi curati a turno da Dj Olive, Boomish e Dj Logic.
Sono vicissitudini che, una volta giunti alla fine, accentuano ancor di più la suggestione della sonorità contemplante e immota della Eternal Variation, transito verso il luogo dove il tempo è abolito. Questa idea che esista un "al di là" rispetto alla variazione fissata sulla carta, la convinzione che questo processo di variazione sia un work in progress senza fine e alluda all'eternità, può essere considerata la chiave - o almeno una delle chiavi - con le quali Uri Caine ha aperto lo scrigno delle Variazioni Goldberg. C'è un tramite, ed è costituito dall'interpretazione e dall'analisi che Glenn Gould ha offerto del capolavoro bachiano.
"Si tratta insomma di una piccola aria curiosamente autonoma, che si direbbe cerchi di evitare qualsiasi atteggiamento genitoriale, di ostentare una placida indifferenza per la sua progenie, di non manifestare alcuna curiosità per la propria ragion d'essere. [...] Il ritorno dell'aria non è un semplice gesto di benevolo commiato, ma adombra un'idea di perpetuità che rivela la natura essenzialmente incorporea delle Variazioni Goldberg e simboleggia il loro rifiuto di quell'impulso generativo. Ed è proprio il riconoscere la loro sdegnosa indifferenza per il rapporto organico fra la parte e il tutto a farci sospettare per la prima volta la vera natura del particolarissimo vincolo che le unisce. La nostra analisi ci ha rivelato che non c'è compatibilità fra l'aria e la sua progenie, [...] che in ogni variazione l'elaborazione della melodia obbedisce a regole proprie e che non vi sono quindi piattaforme di variazioni successive basate su principi strutturali simili, quali sono quelli che danno una coerenza architettonica alle variazioni di Beethoven e di Brahms. E tuttavia, senza ricorrere all'analisi, abbiamo sentito la presenza, alla base di tutto, di un'intelligenza coordinatrice, che abbiamo definita "io". [...] Penso infatti che la fondamentale ambizione di quest'opera per ciò che riguarda la variazione non vada cercata in una costruzione organica ma in una comunità di sentimento. [...] È una musica, in breve, che non conosce né inizio né fine, una musica senza un vero punto culminante e senza una vera risoluzione: una musica che è come gli amanti di Baudelaire, "mollement balancés sur l'aile / du tourbillon intelligent". Essa ha quindi un'unità che le viene dalla percezione intuitiva."
In queste parole c'è la possibile risposta all'interrogativo insormontabile che Uri Caine solleva: se la clamorosa eterogeneità del suo lessico si ricolleghi alla musica di Bach in modo posticcio, le si appiccichi, per così dire, senza ragioni plausibili. O se, viceversa, questa eterogeneità possa dirsi effettivamente derivabile da essa. Nell'enciclopedismo bachiano che tende costantemente a inglobare l'intero orizzonte musicale del suo tempo; nella vagabonda, persino ostentata eterogeneità stilistica delle 30 variazioni rispetto a quella piccola Aria che sembra contemplarne i capricci con sereno distacco (difformità che gli analisti tamponano affannosamente, premurandosi di indicare gli svariati puntelli architettonici su cui si regge la grande arcata), Glenn Gould sente l'affermarsi perentorio di un "io" individuale, una sovrana maestria libera di abbandonarsi al turbine dell'intuizione, a un sentire che è garanzia sufficiente di unità.
Se Bach sfogliava senza alcuna remora l'enciclopedia musicale del proprio tempo, l'omaggio di Uri Caine si traduce allora nel riavviare quella variazione senza fine, nel proiettare la forza unificante di quell'intuizione portentosa entro un orizzonte contemporaneo che dell'eterogeneità ha fatto la propria cifra e anche la propria ossessione. Uri Caine mette a disposizione la propria enciclopedia, anch'essa vastissima, e diviene strumento, innesco. Quanto a Bach egli è la bussola, la soluzione, la terraferma. Ed è anche, riguardo all'ossessione, la possibile cura. Fra le due sponde dell'Aria - una delle quali aperta su un indefinibile altrove - si raccolgono le variazioni.
Senza contare l'ultima, il disco ne presenta 69. Di queste, 24 variazioni sono direttamente riconducibili ad altrettanti originali. Può trattarsi di semplici esecuzioni pianistiche (variazioni 13, 25); oppure di trascrizioni per ensemble strumentale barocco o per coro (variazioni 1, 2, 3, 6, 7, 12, 15, 21). A volte in esse si insinuano una linea improvvisata, o i borborigmi vocali di David Moss (9, 10, 16, 18, 30). Altre volte le sentiamo risuonare in veste cyber, immerse in un sound elettronico, (5, 11, 14, 17, 23, 26). Ma incontriamo anche esecuzioni sottilmente modificate (19), o ancora, radicalmente decostruite, come accade alla variazione 29 resa con raffiche di clusters memori di Cecil Taylor. In mezzo a tutto ciò si svolgono le altre 45 variazioni, il grosso del lavoro.
Dopo l'Aria di apertura l'avvio è relativamente blando. Nella prima variazione, al fortepiano si aggiunge solo una viola da gamba che, in virtù dell'andirivieni dei cursori del mixer, rivela una inopinata vocazione stürmisch. La seconda variazione è ancora una trascrizione, questa volta per quartetto, comprendente violino, tromba, viola da gamba e cembalo. The Introitus Variation segnala invece l'ingresso improvviso di un'entità eteroclita: il coro e il violino intonano una musica che nelle Variazioni Goldberg non c'è e alla quale si aggiungono le scorribande vocali di David Moss. Il varco è aperto ed ecco irrompere altre tre variazioni aliene in cui risuonano l'accento della soul music, la consolle del dj, la lingua del new jazz.
Il quartetto barocco, con la terza variazione, rientra negli argini stilistici di partenza, ma è solo un momento. Da ora in poi il percorso si svolge in un incessante contrapporsi di contiguità e distanze stilistiche, virtuosisticamente ricalcate su modelli espliciti: il jazz di New Orleans, il sintetizzatore di Wendy Carlos, la nuova elettronica e il deejaying, Rachmaninoff, un valzer Biedermeier, un carol polifonico, uno stomp pianistico, il gospel, il klezmer, il corale luterano, la bossa nova, il tango, il mambo. E ancora: Mozart, Verdi, Händel, Vivaldi, stilemi simbolisti, spasmi espressionisti, una variazione su B-A-C-H per quintetto con pianoforte, un remake del Preludio della prima Suite per violoncello solo, un preludio fugato a quattro voci per organo su un tema ricavato dall'aria, e molto altro ancora.
Non è affatto vero che c'è di tutto. Scorrendo l'orizzonte del proprio immaginario musicale, Uri Caine, come Bach e Gould gli hanno insegnato, compie delle scelte, effettuate non in base a codici o gerarchie estetiche preordinate, ma in base alle proprie attitudini, al proprio "io". Quasi a indicare che questo abbraccio non è affatto indiscriminato, mancano in effetti un sacco di cose. Non c'è traccia ad esempio del rock, né del pop, cui Uri Caine, lavorando allo Schumann autore di canzoni, aveva assegnato la parte del leone. E neppure troviamo l'ombra (un'assenza forse ancor più clamorosa) di quello stereotipo cui il binomio Bach-jazz rimanda al solo pronunciarlo: intendo quel Bach swingante che tutti abbiamo nella memoria, quello di Jacques Loussier o degli Swingle Singers che, anni addietro, ha rappresentato uno dei più pittoreschi antecedenti del cross-over postmoderno.
Qui invece è l'improvvisazione che campeggia in primo piano e con essa il jazz, ma in una accezione più profonda e autorevole. Riarmonizzate variamente con la tecnica delle sostituzioni - salvaguardandone la struttura binaria e i principali snodi armonici - le 32 fatidiche misure del basso ostinato bachiano diventano di fatto uno standard sul quale costruire temi e improvvisazioni, muovendosi entro un ampio ventaglio stilistico (New Orleans, hard bop, funky, latin jazz, acid, free).
È precisamente sul terreno dell'improvvisazione che sembra compiersi la triangolazione magica su cui si regge questa nuova sfida di Uri Caine. Traccia sublime di un pensiero ineguagliato, ma assolutamente impotente a restituirci de visu l'altra virtù per la quale Johann Sebastian Bach fu venerato quand'era in vita (le sue stupefacenti doti di improvvisatore), la scrittura bachiana è testimone qui di un incontro felice tra epoche diverse ma elettivamente affini.
C'è una generazione nuova di musicisti che esplorando l'arte musicale del passato, sforzandosi di riportarne in vita la prassi esecutiva, ha preso coscienza di quanto sostanziale fosse l'arte dell'improvvisazione in un'epoca in cui la scrittura era ancora al servizio dell'interprete e non viceversa.
E c'è un'altra generazione nuova di musicisti, che parlano la lingua del jazz, musica anch'essa ormai coi capelli bianchi, ma che lascia ai posteri un'eredità importantissima. Quel jazz che, nato in Occidente agli albori del XX secolo, da lingua subalterna che era, ha insegnato daccapo alla musica occidentale l'arte che essa aveva dimenticato, preparandola così a ulteriori appuntamenti decisivi. L'incontro, per esempio, con la fragrante, nuova immagine musicale del proprio passato, ma anche - e non ultimo - con tutte quelle musiche dotte e popolari che, ai quattro angoli del pianeta, si sono sempre conservate fedeli a un magistero improvvisativo vecchio di millenni.
Quanto ci sia di ineluttabile in tutto ciò, in realtà è difficile dire. Ma che a coinvolgere Bach in questo turbine dell'invenzione sia un jazzista e compositore americano, formato alla severa disciplina dell'eclettismo, discepolo ideale di Glenn Gould come di Gustav Mahler, appassionato di prassi esecutiva barocca, interprete abituale di musica klezmer e avvezzo a lavorare con i dj, non stupisce affatto. Anzi, fa tornare molti conti.
Foto di Claudio Casanova
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.