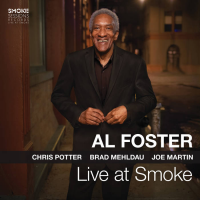Home » Articoli » Lyrics » Appunti per un’Iconografia (Seriale) Pancageana
Appunti per un’Iconografia (Seriale) Pancageana
Bb) Frutto dell'unione fra un inventore (fra l'altro di un sottomarino a benzina: buon sangue non mente...) e una giornalista, John Cage ha nove mesi quando, il 2 giugno 1913, tra futurismo e proto-dadaismo (del resto le espletazioni delle due congreghe, nella comune logica dell'épatement, non mancano di chiari punti di contatto), il Teatro Storchio di Modena ospita il debutto in società del celeberrimo intonarumori, infernale marchingegno, eloquentemente proto-cageano, partorito dalla mente di Luigi Russolo il cui nome esplicita già in sé una chiara dichiarazione d'intenti, teatrale e concreta nel contempo. Al di là di ogni altra loro funzione, gli intonarumori (se ne contano infatti di diversa foggia: crepitatori, gorgogliatori, rombatori, ronzatori, scoppiatori, sibilatori, stropicciatori, ululatori, e poi, per altezza, soprano, contralto, tenore, basso) rappresentano il primo palpabile punto di contatto fra suono (o rumore intonato...) e forma (cioè scultura, senza mezzi termini). [↓, oppure ↓ Eb,↓ G]
B) John Cage ha cinque anni, Marcel Duchamp trenta: siamo nel 1917, dunque in pieno periodo (nonché stile) dada, quando l'americana Society of Independent Artists, di cui Duchamp è socio-fondatore, si vede recapitare dal succitato, celato dallo pseudonimo R. Mutt, il famigerato orinatoio intitolato Fontana. Tra le molteplici pelli duchampiane, almeno un altro paio attengono direttamente all'universo-cageano: quella di musicista, marginale ma fino a un certo punto, e quella di scacchista. Sul primo terreno, toccato in particolare da Varèse e Satie (di cui considera il giovane Cage il logico erede), a parte una piccolissima serie di "partiture" (pare appena tre) più o meno definibili come tali, Duchamp può vantare fin dal 1916 di aver partorito Con rumore segreto (A bruit secret), che è poi un rocchetto di spago ingabbiato fra due lastre in rame unite da quattro viti, che il collezionista Walter Arensberg svitò, collocando nell'incavo del rocchetto un oggetto ignoto, sulla scorta del cui rumore—appunto - segreto, Duchamp ebbe a dire: "non saprò mai se è un diamante o una semplice monetina". Come scacchista—attività che per circa un decennio, a partire dal '23, ne soppiantò qualunque altra, portandolo addirittura a capitanare niente meno che la nazionale olimpica francese—Duchamp ha modo di incrociare spesso le armi con lo stesso Cage. Memorabile, in particolare, una partita del '68, nell'ambito di Sight Sound Systems, in quel di Toronto, di fatto un concerto in cui la scacchiera, in base alle mosse dei due contendenti, determina i suoni emessi da quattro esecutori: David Tudor, Gordon Mumma, David Behrman e Lowell Cross. [↓, oppure ↓ C, ↓ G]
E) Gli scacchi stanno al centro della vita anche di Yoko Ono, artista vorace (per qualcuno anche lievemente velleitaria) che nel 1966 concepì una scacchiera tutta bianca a veicolare un'immagine di uguaglianza con evidenti implicazioni razziali (non più bianchi e neri contrapposti, metafora squisitamente scacchistica, come si può facilmente notare) intitolandola Play in by Trust (giocaci con fiducia). Né i Beatles tutti—monade entro cui Miss Ono si è insinuata proprio a partire da quello stesso 1966 (novembre) a seguito di un incontro col suo futuro marito John Lennon a una sua mostra, favorendone per più versi la scissione—erano meno presi dagli scacchi. Ringo Starr, in particolare, arrivò a farsi costruire nel 1973 da Klaus Voormann una scacchiera con i pezzi in oro e argento che altro non erano che la riproduzione delle mani dello stesso batterista. [↓, oppure ↓ D, ↓ G]
Eb) Yoko Ono e John Cage figurano entrambi sull'elenco degli aderenti a Fluxus, movimento nel cui spirito va per esempio allocata una performance del tipo di Music Walk, concerto-happening tenutosi nel 1962 al Sougetsu Art Center di Tokyo con protagonisti Cage, David Tudor, Mayuzumi Toshiro e la stessa Yoko Ono, di fatto impiegata come "preparazione" del pianoforte che campeggia al centro del proscenio. Di Fluxus (nato l'anno prima, nel 1961) fanno parte anche George Maciunas, che ne è la principale mente germogliatrice, Joseph Beuys, La Monte Young, Philip Corner, Ben Vautier e una lunga lista di altri artisti di varia estrazione, orientati verso quel comune sentire esplicitamente neo-dada che informa, statutariamente, la filosofia del gruppo. Young in particolare, musicista tra gli iconoclasti per eccellenza, è legato sia a Cage, da cui è certamente influenzato (li separano del resto più di vent'anni), che a Yoko Ono, da un'amicizia—quasi un sodalizio—di lunga data (sono separati, loro, da due soli anni). Da non sottovalutare neppure la figura di Philip Corner, musicista e artista visivo-gestuale, il quale, fra l'altro, è legato a Cage per il fatto di averne ereditato, nel 1967, la cattedra presso la New School for Social Research, cattedra tenuta fino al 1970. Ormai da tempo, Corner vive in Italia, a Reggio Emilia. [↓, oppure ↓ F#, ↓ G]
C) A quarant'anni dalla Fontana duchampiana e dopo quella sorta di antefatto che è "Williams Mix" (1952), nel 1957/58 John Cage compone "Fontana Mix," la sua più celebre "partitura grafica," consistente in dieci fogli di carta, ciascuno con sopra sei linee curve, e dodici trasparenti, dieci dei quali con punti dispersi casualmente e in numero diverso (da sette a trenta), gli ultimi due rispettivamente con su una griglia e una linea retta. Sovrapponendo i dieci fogli trasparenti con i punti a quelli cartacei con le curve, e interpretando il tutto con l'aiuto della linea retta e della griglia, si ottengono tante diverse partiture, ovviamente prive di notazione tradizionale e quindi utili come pura suggestione per gli esecutori. È questo il metodo impiegato dallo stesso Cage per realizzare, presso lo studio di fonologia della RAI di Milano (assistente Marino Zuccheri), i nastri che documentano la singolare prassi compositiva, adottata anche per "Theatre Piece" (1957), "Water Walk / Sounds of Venice" (1959) e "WBAI" (1960). [↓, oppure ↓ G#]
C#) Immediatamente successiva (fine 1958) a "Fontana Mix" è una pagina per voce sola, "Aria," che Cage dedica a Cathy Berberian. Più di quello meramente musicale, ciò che c'interessa, della composizione (?), è proprio l'aspetto iconico (che del resto, come sempre, determina la "lettura" da parte dell'interprete): una sequenza di segni, stavolta colorati, tesi a suggerire (mai a indicare, o peggio a imporre, ci mancherebbe!) all'esecutore diversi timbri, ovviamente a sua discrezione. Cathy Berberian, per la cronaca, optò per la seguente successione: giallo = coloritura; arancione = orientale; rosso = contralto; viola = Marlene Dietrich; azzurro = bambino; verde = folk; marrone = nasale; blu scuro = jazz; nero pieno—drammatico; nero con linea tratteggiata parallela = sprechstimme (parlato, recitativo). C'è anche un testo, composto da singole lettere, parole e frasi in cinque lingue: inglese, francese, italiano, russo e armeno. Con "Aria"—come del resto con "Fontana Mix"—si è misurata, fra le altre, anche Karin Krog. [↓, oppure ↓ A, ↓ D]
F#) Il maggior esponente italiano di Fluxus è senz'altro Giuseppe Chiari: a Firenze—dov'è nato nel 1926 e morto nel 2007—studia pianoforte, composizione, matematica e ingegneria. Quest'ultima, nel '47, gli vale anche una laurea, peraltro mai granché onorata, visto che all'indomani della stessa il Nostro si butta a capofitto nella pratica musicale, prima come compositore (collabora fra gli altri con Pietro Grossi e Sylvano Bussotti), quindi, a partire dal 1970, come esecutore e performer in senso lato, dedicandosi sempre più massicciamente, col passar degli anni, a un singolare mélange tra musica e visualità di cui sono espressione particolarmente emblematica le partiture (nel senso di spartiti, di regola non suoi) "gestualizzate," scarabocchiate, arricchite di colori e materiali vari, pratica che del resto Chiari applica anche a strumenti (per lo più chitarre), incarnando in qualche modo il pendant genuino, a volte persino brado, brutale, dell'oggettistica seriale, molto spesso di maniera, sfornata con fin troppa disinvoltura da Arman, a sua volta impelagato in qualche misura nell'esperienza Fluxus. Che poi oggi i lavori di Chiari godano di quotazioni largamente inferiori a quelli del collega nizzardo non attiene granché al campo dell'arte e della creatività. E non è detto del resto che sarà sempre così. [↓, oppure ↓ G, ↑Eb]
G#) In ambito jazzistico, il più incline alla "scrittura visiva" è senza dubbio Anthony Braxton (che del resto, per i puristi, jazzista non è neppure un granché, proprio in quanto troppo spinto verso la sponda contemporaneo-colta). Si potrebbe scrivere un libro, su quella sorta di ideogrammi iconico-matematici (con processi certo non estranei all'estetica cageana) che illustrano le partiture del vorace polistrumentista chicagoano: ci limiteremo qui a lanciare qualche input. Dicendo per esempio che già il solitario For Alto, album di rottura come pochi datato 1968, segue tale procedura. Senza contare che il secondo degli otto brani del disco è dedicato esplicitamente a John Cage. Verso la cui estetica è ancor più debitore, l'anno seguente, Silence, lavoro in trio con Leroy Jenkins e Leo Smith che al "4'33"" cageano deve evidentemente più di qualcosa. Da allora, la discografia braxtoniana è costellata di opere in possesso di una precisa valenza grafico-iconica, da For Trio, nodale opera del '77, ai lavori più recenti (in particolare la serie siglata GTM), che portano alle estreme conseguenze quella che Braxton definisce diamond curtain wall music (si legga al proposito la bella intervista di Olindo Fortino). Per valenza squisitamente pittorica, segnaleremmo la "Composition 366c," peraltro alquanto anomala entro il songbook visuale braxtoniano, trattandosi di fatto una gouache, datata 2008. [↓, oppure ↓D, ↑,C, ↑,C#]
F) Voracità polistrumentale e sferzante spirito neo-dada contraddistinguono con tutta evidenza il percorso creativo di Raahsan Roland Kirk, accanto al quale—senza peraltro mai incontrarlo—nel 1966 John Cage divide il proscenio nel film Sound??, mezz'oretta scarsa girata a Londra da Dick Fontaine. L'abbinamento può apparire bizzarro, ma i vari segmenti—montati a ritmo spesso incalzante, mettendo a decantare insieme impeto kirkiano e aplomb cageano—rivelano quale stretta connessione esista invece fra i due: Kirk che dà il via alla tenzone, procedendo con incedere vagamente messianico in uno spazio in apparenza sconfinato (come quello, nello specifico sonoro, della camera anecoica in cui si muove poco dopo John Cage), poi lo stesso multistrumentista ripreso per frammenti al Ronnie Scott's (c'è anche il fondamentale "Three for the Festival"), in alternanza a parlati cageani variamente ubicati (in auto, al parco, in teatro, anche con accompagnamento di bici "a mano"). Cosa c'è, oltre tutto, di più à la Cage di un'orchestra di flautini e fischietti vari composta di bambini e adulti—fra la curiosità divertita dei primi e l'ingessata quasi-ritrosia dei secondi—come quella messa insieme e guidata da Kirk? O della jam session ingaggiata dallo stesso allo zoo, con flauto e bimbo sulle spalle, con coioti, scimmie e pennuti vari? E gli strani esperimenti magnetofonico-elettronici di entrambi, poi? Imperdibile. [↓, oppure ↓ D, ↑B, ↑Eb]
A) Il Cage "dicitore" si è rivolto spesso alla poesia, a cominciare dal Joyce di Finnegan's Wake. Ma anche la poesia, ben prima di quello che è l'estremo testo joyciano, pubblicato meno di due anni prima della sua morte (quindi nel 1939), e prima anche dei ben noti Calligrammes di Apollinaire (1918, anno, qui, esattamente coincidente con la dipartita dell'autore), ha ritenuto di trascendere i propri confini canonici. Facendosi a sua volta—come più tardi la musica—immagine. In tal senso, un po' tutto è iniziato con un'altra opera estrema (temporalmente), "Un coup de dés jamais n'abolira le hasard," scritta da Stéphane Mallarmé—l'Azur, per dirla con Verlaine—nel 1897, vale a dire un anno prima di morire. Senza addentrarci in un'analisi testuale che ci porterebbe troppo lontano, aggiungiamo solo la traduzione del verso-titolo di Mallarmé: "un tiro di dadi non eliminerà mai il caso". Quale monito più cageano di questo? [↓, oppure ↑B, ↑C,]
D) I legami di Cage con artisti esterni all'universo musicale furono sempre, anche sul piano personale, decisamente ampi, in particolare, fin dai tardi anni Trenta, col coreografo Merce Cunningham e più tardi col pittore (e non solo) Robert Rauschenberg, il quale nel 1951—quindi più o meno all'epoca in cui si cementa il sodalizio con Cage—concepisce e produce una serie di tele bianche mutanti a seconda delle condizioni di luce a cui vengono esposte. Il 1951 è anche l'anno in cui Cage visita la camera anecoica dell'università di Harvard, una stanza insonorizzata votata all'ascolto del silenzio. Che in realtà non esiste, non è mai totale, assoluto, sentenzia Cage. Il quale, nel 1952, sull'insieme di queste suggestioni, partorisce guarda caso la musica-zero di "4'33"". La multidirezionalità dell'attività creativa propria di Rauschenberg—espletata attraverso la polimatericità ma non solo—è indiscutibilmente uno degli elementi che più avvicinano i due artisti, entrambi voraci e iconoclasti come pochi. Né manca un lavoro specificatamente dedicato dal pittore (in questo caso scultore-assemblatore) al musicista: Trophy IV, scultura in metallo, legno e oggettistica varia datata 1961. [↓, oppure ↑B]
G) Oggetti apparentemente umili, o comunque di uso comune, elevati a opera d'arte: questa la lezione che parte da Duchamp e Man Ray (e del resto dallo stesso Picasso) e arriva fino a Rauschenberg e innumerevoli altri, prima e dopo di lui. Lo stesso Cage non si priva di quest'esperienza creativa, abbinandola a un concetto squisitamente performativo che abbraccia visualità, gestualità e teatralità (la quale ultima non è poi che l'unione delle prime due). Lo spirito pan-dadaista più volte evidenziato non manca da nessuna di queste espressioni. Un pianoforte capovolto e collocato sopra una fitta coltre di tappeti può cadere a fagiolo: è quanto accade appunto in Please Play or The Mother, the Father or the Family, mise en œuvre partorita da John Cage nel 1989, alla veneranda età di anni settantasette. Non più di tre anni dopo, appena prima di varcare la soglia degli ottanta, il più grande iconoclasta del ventesimo secolo deciderà di abbandonarci al nostro grigio destino terreno. [fine, ma si può sempre ricominciare da capo]
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.