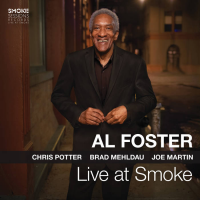Home » Articoli » Lyrics » A proposito del “Concert for Piano and Orchestra” di John Cage
A proposito del “Concert for Piano and Orchestra” di John Cage
Vitali (violoncellista) intervistò Lugo (compositore, sassofonista, direttore d'ensemble, performer) facendo emergere appieno il senso di questa nota composizione cageana.
Marco Vitali: Caro Claudio: sono venuto qui, a casa tua, nella canicola genovese del cinque agosto, per parlare un po' del Concert for Piano and Orchestra di Cage. Sei reduce dalla recente esperienza con l'Orchestra Laboratorio del Conservatorio di Alessandria, dove hai diretto questo pezzo per la terza volta nel giro di tre anni, dopo le esecuzioni di Genazzano e di Napoli (ora probabilmente sei al primo posto in Italia!). Quello che trovo particolarmente interessante, è rilevare le differenze e le affinità fra le tre situazioni...
Claudio Lugo: Innanzitutto è bene descriverle, queste tre situazioni veramente assai differenti fra loro. La prima fu provocata proprio dalla scomparsa, allora recentissima, di John Cage. Erano i primi di settembre del 1992 (quindi era passato meno di un mese) e in quelle settimane era in fase di preparazione il festival di Genazzano, nel quale per quell'anno non erano previsti in cartellone lavori di Cage. Apprendendo la notizia decidemmo, insieme a Sylvano Bussotti e agli altri artisti del festival, di eseguire in ogni serata un lavoro del compositore americano. Nonostante i programmi fossero già molto impegnativi e corposi per i musicisti della Piccola Orchestra Meridiana, all'epoca da me diretta, pensammo subito a una realizzazione del Concert, che fu preparata a tempo di record! Ci parve interessante presentare un'opera cageana che, almeno nel titolo, si presenta con l'impianto tradizionale di un concerto per pianoforte ed orchestra (e di fatto, dopo tre esecuzioni, posso dire che il rapporto con la tradizione vive in questo lavoro intensamente e con sottilissima intelligenza eversiva). Questa esecuzione del settembre '92 avvenne in tre fasi: la prima sera fu suonata solo la parte orchestrale, possibilità peraltro contemplata dalla stessa partitura che nelle note introduttive offre l'opportunità di costruire qualsiasi insieme delle varie parti, dal solo al tutti, in qualsiasi combinazione possibile anche, se è il caso, in assenza del pianoforte; la sera successiva Mauro Castellano eseguì il Solo for piano e in effetti soltanto la terza sera il pubblico poté ascoltare il concerto nella sua completezza. Questa prima esperienza fu un vero e proprio 'tuffo' nella partitura dal quale emersi con più interrogativi che certezze, a causa anche del brevissimo tempo che ci fu concesso per provare. Fu un'esecuzione più 'istintiva' che ponderata, un modo per manifestare un segno importante e irrinunciabile in quel momento di emozione commemorativa.
M.V: Ma da un punto di vista, diciamo, esteriore, il tuo lavoro e stato più o meno uguale a quello che hai fatto poi a Napoli e ad Alessandria? Hai sempre lavorato singolarmente con ogni musicista, riservando l'incontro delle varie parti al momento dell'esecuzione?
C.L.: Sì, è un'idea che ho avuto da subito: la cosa non è esplicitamene prescritta da Cage ma, per come è strutturato il Concert, mi è parso importante non provare l'insieme fino al momento dell'esecuzione pubblica...
M.V.: Provando tutti insieme si potrebbero instaurare dei meccanismi di attesa, le combinazioni casuali non sarebbero più tali, verrebbero in qualche misura previste o disattese...
C.L.: ... si correrebbe il rischio di 'concertare,' di predeterminare gli accadimenti durante il corso dell'esecuzione, di cercare al tale minuto un particolare incontro di suoni che in prova ci ha convinto, o in un altro minuto di 'correggere' certe combinazioni indesiderate...
M.V.: Questa storia del "minuto" introduce nel discorso la parte del direttore del Concert: forse sarebbe il caso di spiegarla un po..'.
C.L.: Sì, conviene partire dall'inizio. Il pezzo è costruito in modo relativamente semplice: la partitura non esiste; l'editore fornisce un certo numero di spartiti dedicati a diversi strumenti dell'orchestra e intitolati Solo for... contrabbasso, violoncello, flauto, eccetera; un panorama che in effetti non esaurisce l'organico orchestrale e nel quale compare anche qualche 'anomalia,' come la parte del fagotto, nella quale è prevista un'alternanza con il sax baritono (forse il primo esecutore dell'orchestra newyorkese era un fagottista-saxofonista, cosa abbastanza comune in America). Negli spartiti ogni pagina contiene cinque pentagrammi senza segni di battuta; vi si trovano 'costellazioni' di note in numero variabile da una ventina, per le pagine più dense, sino a facciate completamente prive di segni; le note (punti neri senza segni di durata) sono distribuite in modo molto articolato, lasciando pensare che questa spazializzazione abbia il senso di sostituire le indicazioni di pausa. Le note sono scritte in tre formati: piccolo, medio e grande, formati che l'esecutore può indifferentemente attribuire al carattere dinamico o alla durata, o a una combinazione di questi due parametri; cosa che offre all'esecutore un ventaglio molto ampio di scelte possibili: un suono scritto 'grande,' per esempio, non è detto che sia forte e lungo, può essere anche piano e lungo, o forte e breve: il segno esclude soltanto che sia piano e breve.
M.V.: Scelte, queste, che secondo te devono essere estemporanee o meditate?
C.L.: Ho sempre pensato (non vi è nulla di prescritto in tal senso) che questa debba essere materia di decisione del singolo strumentista, più che del direttore: sono scelte che definirei squisitamente 'strumentali.' A titolo di esempio, se l'esecutore incontra una nota 'grande' scritta in un registro del suo strumento nel quale sono particolarmente efficaci i suoni forti, brevi e molto accentati, opererà di conseguenza una scelta legata proprio a quell''artigianato' del produrre il suono tipico del virtuoso, più che fare riferimento a una astrazione estetica (o di comodo). La mia idea è che si debbano studiare queste pagine esattamente come se si dovessero eseguire 'a solo,' tenendo ben presente l'efficacia di ogni intervento e anche la precisione del carattere, che, una volta fissato, deve rimanere tale.
M.V.: Per quanto riguarda le scelte dinamiche e strumentali il tuo discorso è chiaro; però, al momento dell'esecuzione, è il direttore che dà, con il suo gesto, la cornice temporale all'interno della quale ogni esecutore deve collocare i suoi interventi, in modo assolutamente estemporaneo: ricordo che durante la nostra esecuzione napoletana la mia concentrazione era completamente assorbita da questo compito, per niente facile...
C.L.: ...sì, ora ci arrivo. Ogni strumentista dunque studia isolato dagli altri la sua parte, costituita da una sequenza di suoni ognuno dei quali è precisamente caratterizzato da segni di attacco, da un particolare sviluppo nel tempo della dinamica, dell'intonazione e quant'altro: come se Cage, dopo aver operato una scelta astratta di note, avesse lavorato sulle qualità attitudinali dei singoli orchestrali presenti alla prima esecuzione esplorando con loro le possibilità timbriche offerte dalla prassi (sia tradizionale che 'innovativa') di ogni singolo strumento. Per esempio: una parte assai articolata e vivace come quella del trombone, che chiede di smontare progressivamente e rimontare tutte le minime parti fisiche dello strumento e di usare tutti i tipi di sordine e di oggetti possibili per cavarne il maggior numero di timbri differenti, non può essere stata costruita se non a diretto contatto con un trombonista particolarmente versatile e disponibile alle sperimentazioni. Così il direttore... ma preferirei chiamarlo in un altro modo, non saprei... che ne dici di 'guida,' per esempio?
M.V.: Meglio 'regista,' forse...
C.L.: ...mmh, preferisco 'guida,' nel senso delle guide alpine. Insomma, comunque lo si chiami, credo gli sia chiesto di ripercorrere assieme agli strumentisti l'escursione attraverso le singole parti incoraggiando questo continuo 'indaffararsi' sugli strumenti, in modo spesso non convenzionale, per scopi eminentemente fonici, e non già meta-teatrali o peggio gratuitamente provocatori.
M.V.: Qui potrebbe essere interessante rilevare che la dimensione di studio con gli allievi del Conservatorio è forse il 'luogo deputato' per un lavoro del genere: c'è una disponibilità da parte dei ragazzi che forse non si trova nei musicisti di professione...
C.L.: Credo che questo pezzo non sia mai stato provato cosi a lungo! Sette mesi di lavoro; mesi nei quali, come ti dicevo, non abbiamo mai suonato il Concert tutti assieme; ci siamo limitati ad ascoltare i vari 'soli,' discutendone assieme e cercando di entrare nel laboratorio della ricostruzione dei caratteri dei suoni in modo condiviso. Laddove, per esempio, s'incontrano quelle note 'appese' al pentagramma che vanno tradotte con interventi 'extra' rispetto all'uso tradizionale dello strumento, non è data - ovviamente - un'interpretazione univoca del segno che quindi è lasciata alla libera scelta del musicista. Proprio su questo aspetto, a mio parere, si è molto equivocato in alcune esecuzioni 'storiche,' deviando verso la mera 'teatralità' il senso squisitamente musicale di tali indicazioni. Non è escluso che un orchestrale, imbattendosi in una di queste indicazioni 'extra,' possa scegliere di fare una 'camminata' in giro per il palcoscenico; tale gesto, però, ricalcando l'esatta traduzione sonora del segno, deve quindi essere preciso e puntuale nei minimi dettagli sonori...
M.V.: Questa precisione, questa definizione sonora è proprio quello che più mi colpisce nella registrazione dell'esecuzione di Alessandria, che stiamo ascoltando come sottofondo alia nostra chiacchierata. Cage chiama "Solo" ogni singola parte strumentale; ma si potrebbe addirittura dire che in realtà ogni singolo intervento sonoro sia un 'solo,' definito in sé stesso.
C.L.: Sì è vero! Mi sono infatti figurato che ogni suono del componimento possa somigliare all'avvento di uno specifico carattere teatrale e che, come nel teatro di parola, ogni intervento debba rappresentare la sintesi di questo carattere, espresso più dalla energia particolare con la quale una battuta viene detta che non dal significato del testo. Con i ragazzi dell'Orchestra Laboratorio del Conservatorio di Alessandria abbiamo lavorato molto per cercare di non ripetere caratteri timbrici simili, differenziando il più possibile i segni analoghi per non dare l'impressione del ricorrere di certi suoni (cosa che avrebbe potuto dare a essi un ruolo 'tematico'), privilegiando invece la necessità di produrre una continua variazione del dettato musicale.
M.V.: Scusa, però a questo punto mi viene in mente un'obbiezione provocatoria: in questo modo non c'è il pericolo di conferire troppo senso agli eventi sonori, un eccesso di senso, non previsto né voluto da Cage?
C.L.: No, non credo; non in questo senso comunque, non nel senso del 'senso'! La novità del discorso di Cage è proprio il suo aderire perfettamente alla materia del suono. Voglio dire: la cosa che mi sembra importante, affascinante, è come Cage pretenda dagli esecutori un lavoro su se stessi, non tanto sul piano dell'emozionalità 'espressiva,' quanto invece nella ricerca di un rapporto direi 'esclusivo' con la fisicità dell'atto di produzione strumentale del suono. Se mai è nell'ascoltatore (nell'ascolto) che può scattare la scintilla del moto emozionale di fronte al paesaggio sonoro che si dispiega. E proprio il fatto che per arrivare a una buona esecuzione sia necessario percorrere questo itinerario impone 'pedagogicamente' la più stretta relazione possibile con il proprio strumento. Molti allievi, dopo l'esperienza, mi hanno confessato di avere molto accresciuto la loro capacità di affrontare pagine del presente come del passato. Direi quindi che ci troviamo di fronte ad un'opera preziosa, eminentemente 'didattica,' nell'accezione migliore del termine.
M.V.: E tornando ancora per un momento alla parola 'senso,' di cui abbiamo ormai abusato, vorrei aggiungere qui una considerazione: se tutta la produzione di Cage non è in fondo che un tentativo globale, durato un'intera vita, di spostare e di ridefinire i confini del senso in musica, si può dire che il Concert è un po' il centro del suo itinerario; e in questo senso (ora basta!) e anche il suo pezzo più importante: sia gli esecutori che gli ascoltatori sono chiamati a un lavoro attivo, non alla scoperta di chissà quali astratte relazioni (come nella musica seriale) ma appunto a una radicale revisione del significato dei termini tradizionali della musica (per elencare solo quelli apparsi finora: concerto, orchestra, solo, tutti, direttore, studiare, provare, buona esecuzione, ecc.). Ma ora sarà meglio continuare con la descrizione del pezzo.
C.L.: Il nostro itinerario, che partendo dalle singole pagine ci conduce a vedere come si costruisce tutto l'impianto del Concert, rispecchia anche il modo in cui si costituisce il 'messaggio' (per usare un termine oggi forse un po' logoro ma che in questo caso mi sembra importante usare). Il messaggio artistico di John Cage è secondo me orientato a un grande umanesimo; anzitutto nel rivolgere un'attenzione così forte e intensa a chi produce i suoni, lo strumentista, di contro a tanta musica che lo pone un po' astrattamente come un numero, un 'mattoncino' dell'edificio musicale disegnato dalla partitura (e così, beninteso, sono state costruite anche tante opere formidabili!). Questo sarebbe già un risultato importante ma Cage invece oltrepassa anche un altro confine, punta il dito emozionale e intellettuale sull'ascoltatore e gli dice: "Guarda che è l'esperienza dell'ascolto quella che 'fa' la musica!". Intendo dire che possiamo ascoltare quasi ogni giorno musichette (volutamente le chiamo cosi) di Mozart usate nella pubblicità o nelle segreterie telefoniche senza avere alcuna relazione con il pensiero musicale di Mozart; allo stesso tempo, ascoltando con un'intenzione musicale i suoni, i rumori casuali della realtà quotidiana cosi come accadono intorno a noi, possiamo scoprire relazioni e potenzialità musicali inaspettate.
M.V.: Questo discorso era emerso a Dissonanzen l'anno prima, in relazione al famoso pezzo 'silenzioso' di Cage: pezzo creato dai suoni dell'ambiente, del pubblico, dal gioco dell'attenzione e della distrazione degli esecutori e degli ascoltatori.
C.L.: Certo: è proprio la disposizione dell'ascoltatore al centro del discorso: è molto importante, e forse lo si dice troppo poco, sottolineare come anche l'ascolto possa essere emancipato seguendo un itinerario di crescita progressiva simile, per certi aspetti, a quello di chi la musica la produce (attività che sarebbe vana in assenza di orecchie sensibili e 'intelligenti'); insomma, ci vuole talento e applicazione anche per ascoltare!
M.V.: Ecco una buona risposta al solito, trito argomento contro la musica contemporanea, che cioè l'ascoltatore non la possa seguire perché non trova gli appigli (tematici e ritmici, armonici e melodici) che possano guidarlo: in realtà è la definizione stessa di ascolto musicale che contiene in sé lo sforzo di riconoscere somiglianze e differenze, di mettere a fuoco, nel mirino dell'intenzionalità, un frammento del continuo sonoro in cui siamo immersi continuamente e spesso inconsapevolmente. Cercare le relazioni pensate dal compositore ma poi da lui stesso accuratamente nascoste o creare ex novo delle relazioni là dove tutto è perfettamente casuale dovrebbe essere per l'ascoltatore esattamente la stessa cosa: come per ammirare la bellezza del ghiacciaio del Monte Rosa non è rilevante che lo si consideri parte di un universo perfetto o casuale aggregato di atomi.
C.L.: Conoscere le strategie messe in atto dal compositore, l'epoca, il contesto sociale, le tecniche usate e le loro relazioni con quelle di quel periodo e con quelle di altre storie e di altre geografie: certamente tutto questo arricchisce il gioco, fa crescere la consapevolezza dell'ascolto. Ma la cosa più importante, la condizione sine qua non è, oserei dire, l'assiduità nell'ascoltare, un continuo esercizio a organizzare i suoni uditi - e le esperienze emotive che provocano - in forme; questo significa certo conoscere e riconoscere le forme storicizzate, ma anche abituarsi a comporre e ricomporre propri personali sistemi di ascolto: non è detto che ascoltando una forma-sonata classica, haydniana, la cosa più interessante sia seguire pedestremente un dettato formale così bello, lineare e prevedibile: il gioco può anche essere quello di trovare associazioni diverse, impreviste; perciò la musica di Haydn può essere ancora così viva, attuale. Si chiede un esercizio di sensibilità, dunque, al dettato formale; e questo esercizio può essere, ci dice Cage, applicato anche a eventi del tutto casuali: camminando in un bosco, ascoltando i suoni e mettendoli in relazione fra loro, cercando un 'messaggio' musicale: insomma, al di là del fatto che si voglia credere o no a una volontà trascendente, la capacità di organizzare quello che ascoltiamo in linguaggio emozionale è attitudine specifica degli umani.
M.V.: Esagerando nel generalizzare, si potrebbe dire che questa nostra capacità di organizzare i suoni in musica è un caso particolare del continuo lavoro che trasforma il 'flusso' delle nostre esperienze in una autobiografia. Ma ora sarà meglio continuare il nostro percorso, arrivando finalmente al ruolo del direttore ('regista' o 'guida,' come preferisci)...
C.L.: Ma guarda che finora non è stato affatto ininfluente, il lavoro della 'guida': anzi, ha svolto un ruolo propedeutico importante incontrando individualmente i singoli strumentisti; effettivamente un po' come un regista quando si occupa di studiare nel dettaglio le battute dei singoli attori. In questa fase il conductor deve continuamente richiamare lo strumentista a prestare la maggiore attenzione possibile a tutti i suoni, anche quelli che sembrano più astrusi...
M.V.: Ti faccio un'altra domanda: tu hai lavorato, nelle tre esperienze di cui stiamo parlando, con strumentisti di estrazione alquanto diversa: affermati solisti, partecipanti a un festival di musica contemporanea, a Genazzano; orchestrali del San Carlo a Napoli; allievi del Conservatorio ad Alessandria. Gli ultimi due gruppi, del tutto inesperti di musica sperimentale, pur con tutte le differenze...
C.L.: E che differenze! Con tutto il rispetto, gli orchestrali del San Carlo sono proprio, nel bene e nel male, il prototipo dell'orchestrale italiano...
M.V.: Quello di Prova d'orchestra, per intenderci...
C.L.: ...o di Totò! Ma devo dire che sono stato molto contento del lavoro che abbiamo fatto assieme a loro! Comunque, in sostanza l'avventura si è ripetuta con forti analogie, anche se con modalità differenti per via dei diversi tempi di produzione e per il diverso rapporto tra me e gli esecutori nelle tre occasioni. Nondimeno il sapore del ricordo musicale che le tre esecuzioni mi hanno lasciato è sostanzialmente lo stesso; e questo dipende, a parer mio, dal fatto che il Concert è un pezzo molto 'forte.' Quando avviene che i mutamenti esteriori, anche se molto significativi, non riescano a scalfire il senso di una partitura, il suo 'nocciolo,' siamo al cospetto di un vero capolavoro.
M.V.: Volendo farti un complimento, qualcosa si potrebbe imputare anche alla qualità del tuo lavoro: ascoltando ora la registrazione di Alessandria e paragonandola con quella di Napoli sento effettivamente 'la stessa musica,' pur con tutte le differenze...
C.L.: Beh, penso che il lavoro individuale con gli strumentisti abbia soprattutto lo scopo di ottenere, come risultato, una grande attenzione al segno cageano. Voglio dire: quello che senti, e che riconosci, è proprio quello che ha scritto Cage!
M.V.: Forse la qualità più straordinaria di questa composizione è proprio quella di riuscire a sedurre tanto un orchestrate del San Carlo quanto un allievo del Conservatorio; e forse allora i solisti abituati alla musica contemporanea non sono necessariamente gli interpreti migliori...
C.L.: ...anzi, spesso sono i peggiori! Arrivano con il loro bagaglio di suoni 'precotti...'
M.V.: Hanno un repertorio di 'effetti precostituiti' dai quali è difficile allontanarli, e manca loro quella voglia di scoperta, quel piacere un po' infantile di trovare suoni nuovi...
C.L.: ...e d'altro canto sono più refrattari a mettere in gioco i suoni convenzionalmente 'belli,' che pure in questa composizione non mancano. Se nella parte del violoncello c'è un bel 'mi' basso, forte e vibrato, bisogna suonarlo come si farebbe in una sinfonia di Mahler! E qui lo specialista di musica contemporanea, ahimè, spesso segna il passo... Invece per me, lo ripeto, il dialogo interno tra i suoni 'nuovi' e quelli usati nella prassi tradizionale è una componente fondamentale del Concert. Lo strumentista che suona bene la sua parte viaggia con il suo strumento nel tempo e nello spazio, s'immerge e nuota nelle categorie musicali, passeggia attraverso i generi...
M.V.: E per un misteriosa proprietà della casualità cageana, che fa scaturire sempre nuove correlazioni, proprio nel momento in cui hai evocato la tradizione sento qui nel nastro un passaggio del pianoforte così spudoratamente brahmsiano... E si ripete varie volte, anche, come volesse dire: no, non è stata un'allucinazione...
C.L.: ...ecco, questa è una delle pagine pianistiche che preferisco e poco suonata...
M.V.: Vuoi spiegare prima come è fatta la parte del solista?
C.L.: Dunque, il Solo for piano si costruisce operando una scelta tra un grande numero di pagine - più di sessanta - che presentano aspetti musicali assai variegati e differenti, un'autentica esplosione di invenzioni, operate più sulle forme grafiche della scrittura che non sulla tecnica pianistica in senso stretto.
M.V.: Vale la pena di vederle, queste pagine: a Napoli avevamo organizzato un'esposizione, e spero di riuscire a inserirne qualcuna anche qui nel libro.
C.L.: Mi sembra che d'abitudine i solisti preferiscano concentrarsi sulle pagine più aleatorie, cioè su quelle in cui prevale l'elemento extramusicale o extra-pianistico; ho l'impressione che pagine come questa che abbiamo appena ascoltato e in cui emergono passaggi dal suono così 'classico' (qui, per esempio, è prevista una specie di 'ostinato,' una ripetizione di accordi carichi di memoria storica) non siano state utilizzate spesso. Non so se questa combinazione di note che formano una sorta di cadenza armonica sia stata creata dalla volontà di Cage o da un suo procedimento casuale; e non mi sembra nemmeno così importante saperlo. Tornando al discorso di prima, credo sia importante per l'interprete non 'mascherare' la presenza di elementi che a prima vista potrebbero sembrare in contraddizione con altri. Da questo punto di vista le invenzioni grafiche del Solo for piano costituiscono senz'altro la parte più affascinante del Concert; ci sono pagine in cui Cage indica dei tragitti possibili attraverso gruppi di note, lasciando aperta la scelta stilistica, di 'genere.' Guarda questa, per esempio...
M.V.: Ma è quella che ho usato per la locandina di Dissonanzen!
C.L.: ...qui le forme geometriche funzionano come generatori per la creazione di abbellimenti, sulla base delle note indicate ai vertici. In fondo Cage propone qui uno 'studio' sull'abbellimento, un invito a approfondire il valore di questa figura musicale in senso storico e/o culturale, consentendo (e attendendosi) gli esiti più sorprendentemente diversi! Penso davvero che il Concert sia una grande opera di riflessione sulla musica, sul senso culturale e antropologico dell'articolare i suoni in forma di linguaggio.
M.V.: Al momento dell'esecuzione, c'è una grande differenza tra il solista e l'orchestra...
C.L.: La differenza più evidente è che durante l'esecuzione tutti i soli strumentali, a eccezione del Solo for Piano, devono essere preventivamente organizzati nel tempo. Mi spiego: conclusa la fase di lavoro sulla parte, a ogni esecutore è richiesto di preparare una 'tabella oraria' di 'partenza' e 'arrivo' dei suoni, sulla base del programma di durata complessiva dell'esecuzione deciso dal direttore (30' nel caso di Genazzano e Napoli, 20' - la misura consigliata da Cage per l'esecuzione di Alessandria). Ogni esecutore può decidere quali pagine suonare e in che ordine...
M.V.: Può anche non suonarne nessuna, cioè non suonare affatto?
C.L.: Sì, un esecutore potrebbe anche decidere di salire sul palco e non suonare nemmeno una nota...
M.V.: E allora potrebbero anche decidere di farlo tutti!
C.L.: Certamente! Questo però finora non mi è mai successo. Chissà, forse se arriverò al guinness della trecentesima esecuzione mi capiterà una volta qualcosa di così straordinario: per venti minuti tutti mi guarderanno fissamente e nessuno suonerà!... Comunque, ogni esecutore decide quali pagine vuole suonare, e sceglie per ogni singolo intervento l''orario' preciso. Se, per semplificare, decidiamo che ogni rigo duri un minuto, e in un rigo specifico compaiono per esempio tre note, queste potrebbero essere ripartite - sulla base della stesura grafica della parte e delle scelte strumentali di cui si diceva - così: a 15'' (nota molto lunga fino a 30''), a 45'' (nota breve, staccata), a 49'' (nota di media durata fino a 55''). A questo punto, dopo che ogni strumentista ha formulato il suo 'orario' personale, per far 'funzionare' il pezzo basterebbe mettere davanti all'orchestra un bel cronometro. Ma ecco l'idea di Cage: è il direttore che fa il cronometro, ruotando alternativamente le braccia come fossero lancette dei secondi; ma il suo tempo è un po' particolare... II direttore tiene d'occhio un cronometro vero, posto sul leggio e basandosi sul tempo effettivo e avvalendosi di una tabella di conversione, che costituisce la parte del conductor, produce la sua scansione gestuale dei minuti e dei secondi. In sostanza nessuno dei suoi 'giri d'orologio' dura come un minuto effettivo. Per esempio il primo quarto di minuto 'gestuale' dura un minuto, i successivi 30'' durano 30'' e il successivo quarto di minuto dura 30'' poi il minuto successivo dura un minuto e mezzo, e così via...
M.V.: Un bel lavoraccio! Anche per gli esecutori, che non sanno mai in anticipo quanto veloce scorrerà il tempo in cui si inserisce il prossimo intervento... Mi fa pensare a Einstein, alla relatività.
C.L.: Sì, è vero! Ma è anche un nuovo spunto di riflessione critica sulla tradizione gerarchica vigente nel lavoro delle compagini orchestrali: non è proprio questo il ruolo canonico del grande direttore, 'tenere sui filo' gli orchestrali con il suo gesto a volte imprevedibile, estenuare l'indicazione agogica (cioè l'elasticità del tempo) tipica delle partiture ottocentesche e tardo-romantiche? L'orchestrale anche nel caso del Concert cageano deve 'seguire il gesto,' collocare cioè i suoi interventi sonori in relazione spazio-temporale con il gesto del direttore. Tu e io abbiamo suonato in orchestra, sappiamo che, al contrario di ciò che avviene nella musica da camera, in quel contesto bisogna concentrarsi assai più sui gesti del direttore che non sull'ascolto musicale; perciò quando mi avevi chiesto se a Napoli volevo lavorare con strumentisti di estrazione extra-classica o con i tuoi colleghi ho preferito gli orchestrali del San Carlo; per i musicisti che affrontano il Concert è essenziale essere abituati ad 'andare col gesto.' Anche in questo caso Cage gioca (e ogni gioco interessante è sempre un po' eversivo) con una prassi già istituita e consolidata dalle convenzioni.
M.V.: E la rovescia anche: tradizionalmente, un accelerando è legato a un aumento della massa sonora, un rallentando a una sua rarefazione; qui ci sono minuti velocissimi di quasi silenzio e lenti minuti ricchissimi di interventi: soltanto il caso decide, non c'è nessuna convenzione espressiva...
C.L.: Dirigendo resto ogni volta sorpreso da questi addensamenti improvvisi, dalle rarefazioni inattese e dai silenzi. Ad Alessandria, per esempio, abbiamo avuto trenta 'secondi' (virtuali) di silenzio totale: non mi era mai capitato! È stato un momento molto intenso per tutti, anche perché ovviamente nessuno se lo aspettava.
M.V.: Ma torniamo al ruolo del solista...
C.L.: Il solista interviene quando tutte le scelte del direttore e degli orchestrali, per quanto riguarda i materiali da usare e le varie relazioni con il tempo, convergono a fissare una ipotesi di esecuzione del pezzo. Il pianista infatti è escluso da questo meccanismo preordinato e può ignorarlo completamente; è l'unico performer libero di agire estemporaneamente. Lo 'scontro' dialettico tra l'individuo e la massa messo in scena da solista e orchestra nella tradizione dei concerti classico-romantici qui assume una forma inedita: in sostanza il solista, unico abilitato al libero arbitrio estemporaneo, assume in questo caso il ruolo prometeico dell''ascoltatore privilegiato'; e più ancora del direttore, il quale è indaffaratissimo con le sue tabelle orarie, proprio come un capostazione nell'ora di traffico ferroviario...
M.V.: Beh, in effetti anch'io, come strumentista, avevo il mio bel daffare a seguirti! E non riuscivo né a vedere né a sentire quello che facevano gli altri!
C.L.: Ecco: il pianista invece sceglie e ordina estemporaneamente le sue pagine, entra e esce dalla conversazione come e quando vuole. Ascolta, soprattutto. Si pone come 'primo' uditore; si predispone a percepire quello che accade nella maniera più sensibile e attenta e a 'rispondere' inserendo gli interventi che ha studiato in precedenza quando 'sente' (in un senso se vuoi un po' 'zen') la reale necessità di 'fare qualcosa.' Ho notato che i tre pianisti con cui ho collaborato (Mauro Castellano, Giancarlo Cardini e Giovanna Vescovo), pur con differenti gradazioni, passavano molto del loro tempo sul palcoscenico ad ascoltare in silenzio, più che a suonare. Credo che questo pezzo chieda al pianista per lo più di lasciar che suonino gli altri; un esercizio davvero inconsueto per chi appare in cartellone come solista di un 'concerto per pianoforte e orchestra.'
M.V.: Ecco un ulteriore tassello di quella ridefinizione dei termini musicali di cui parlavamo: la relazione tra 'solista' e 'orchestra' è qui del tutto inedita...
C.L.: Di fatto il solista del Concert for piano and orchestra esprime la condizione utopica dell'ascolto ideale e si pone come esempio all'uditorio nell'esercizio della concentrazione auditiva. Quello che in teatro è chiamato 'plot' della rappresentazione qui (come del resto in tutta l'opera di John Cage) si può dire che sia individuabile nell'esperienza dell'ascolto: cosa preziosissima in uno scorcio storico nel quale la musica deve urlare (e non mi riferisco solo ai 'watt'), per farsi sentire da orecchie sempre più condizionate e assordate.
M.V.: Bene, per me qui ci possiamo anche fermare. Studiando, ascoltando, suonando e chiacchierando, mi hai accompagnato, proprio come una guida alpina, in una bella 'traversata del Monte Cage'!
Foto di Roberto Masotti (la prima), Sabrina Cirillo (la seconda).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.