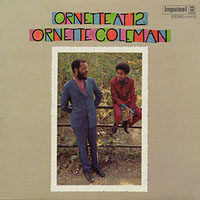Home » Articoli » Lyrics » L'ombra e la melodia. Rita Marcotulli e le immagini da ascoltare
L'ombra e la melodia. Rita Marcotulli e le immagini da ascoltare
trovato finalmente la sua voce."
(S. M. Ejzenštein, La forma cinematografica)
"Anche le parole sono musica..."
(F. Truffaut, L'Enfant Sauvage)
1. Le mani e la melodia
In qualche modo, diceva De Andrè, la melodia comincia dove finiscono le mani. Bellissima immagine per spiegare il "passaggio," il movimento (anche in senso musicale) che decide la melodia e ne esprime il contenuto. "La mano che obbedisce all'intelletto," diceva Michelangelo. Solo che qui con "intelletto," dobbiamo cogliere una più profonda e complessa maniera del sentire, e se in entrambe le occasioni abbiamo fatto ricorso a due artisti così diversi e lontani, la complementarità delle immagini espresse coincide in questa dimensione del sentire che diventa espressione. Rita Marcotulli è una poetessa che invece delle pagine bianche e dell'inchiostro ha scelto il bianco e il nero dei tasti. "Suonare" come "scrivere," metafora impropria ma necessaria; e lo scrittoio di questa poetessa è la tastiera del pianoforte, il luogo dove i pensieri diventano musica e le mani toccano nello specchio dell'armonia la loro immagine riflessa. La storia raccontata da un pianoforte si confonde e si ridesta ogni volta che una mano sfiora la tastiera e tutte le sue possibili combinazioni. Le ombre partono quando le mani cominciano a tracciare loro la strada.
2. "Póntos oinopórphyros": suoni e viaggi mediterranei
Nessuno può dimenticare il mare dopo averlo visto, il "mare colore del vino" come lo chiama Omero. Il ricordo e l'occasione sono legati all'estate appena trascorsa, quando, in occasione del Roccella Jazz Festival, stavamo preparando "Sui prati, ora in cenere, di Omero," testo da me tratto e adattato per l'occasione da un romanzo del siciliano Stefano D'Arrigo, per celebrare il 150° dell'Unità d'Italia. Si tratta del racconto di un ritorno, un'odissea tragica, quella del "nocchiero semplice della fu regia marina" 'Ndrja Cambria, marinaio di Cariddi e protagonista del capolavoro di Stefano D'Arrigo, Horcynus Orca, che torna a casa dopo l'otto settembre 1943 e il conseguente sbandamento dell'esercito italiano, attraversando l'Italia meridionale devastata dai combattimenti. Romanzo di grande bellezza narrativa e linguistica, concepito e realizzato fra il 1960 e il 1975, Horcynus Orca è un racconto epico suggestivo e sospeso fra mito e storia la cui trama sembra essere l'approdo delle grandi narrazioni della letteratura occidentale. In particolare, la lettura che viene proposta si basa sulla scelta dei primi e fondamentali episodi del romanzo che rendono evidente il legame con l'Odissea, (una delle fonti di D'Arrigo insieme a Dante, Shakespeare, Hölderlin, Melville, Joyce, Mann).
Tra la Calabria e la Sicilia si crea una "terra di nessuno" (o di "Nessuno"?), ferita dalla guerra e dalla morte, prigioniera dell'incantesimo della storia, segnata dal coraggio di donne sole che ad ogni costo vogliono "buscarsi la vita," lavorando come e più degli uomini, vedove, orfane, ma decise a ristabilire il confine certo fra vita e morte. Raccontiamo la prima parte del viaggio, quella che narra dell'arrivo di 'Ndrja sulle coste di Scilla e il passaggio notturno dello Stretto per approdare a Cariddi sulla barca di una di quelle "deisse," Ciccina Circé.
Rita è stata la "maestra concertante" di un ensemble d'eccezione con un grande Luciano Biondini alla fisarmonica, la forza evocativa della recitazione di Chiara Caselli (davvero brava nell'armonizzare la complessa partitura darrighiana) e la voce, splendida, di Elena Ledda che ha portato in scena in perfetta plausibilità il Mediterraneo profondo e poetico della sua Sardegna. Quello che volevamo proporre era un omaggio alla storia del nostro Paese e a quell'eredità di bellezza che la geografia e la cultura ci consegnano come patrimonio inestimabile frutto dell'intelligenza e della fatica di tante generazioni. Ma era anche, in fondo, un omaggio al nostro mare e alla bellezza di quel ritmo immenso la cui regolarità non sta nelle nostre disponibilità ma nel suo arbitrio melodico. Questo una poetessa può capirlo e percepirlo immediatamente, e credo che questo sia stato il metronomo segreto che ha guidato la performance, gradita ed applaudita come è giusto fare per un dono. In questa occasione le immagini sono direttamente legate all'immaginazione narrativa e linguistica del romanzo. A volte ci appare così difficile la semplice equazione "immaginazione = vedere per immagini". Eppure, si tratta di questo. Solo che al posto dei tratti e dei colori abbiamo la materia della scrittura, una partitura precisa che occorre tradurre in suono, come pensava Valéry a proposito della poesia: un suono alla ricerca di un senso. E poi, il fattore tempo: poco più di un'ora per sviluppare una trama complessa e ricchissima di colori, di parole precise come possono esserlo gli elementi di un paesaggio che si osserva in una luce meridiana, a perpendicolo. Il senso della fine e della "bella morte" così cara agli eroi omerici presentita ad ogni volgere di frase, ad ogni intonazione di canto, ad ogni accordo. La bellezza è fragile e dura come un diamante, lo si impara col tempo.
Ed è in questi termini, credo, che vada intesa la stesura della partitura musicale di un film come Basilicata coast to coast (2010) che ha fruttato una serie di meritati riconoscimenti (Ciak d'oro, Nastro d'argento, David di Donatello), oltre a quello di pubblico, impreziosita da contributi dello stesso regista, Rocco Papaleo, e di Max Gazzè, personaggio lunare del film ed autore della canzone di chiusura ricca della sensibilità di questo musicista. Qui abbiamo modo di verificare ed apprezzare il versante mediterraneo, la inesauribile molteplicità del jazz perfettamente acclimatato a queste latitudini, ed anzi in sintonia tanto col progetto della sceneggiatura così come nei confronti della realizzazione ambientale e narrativa della vicenda. Centrale è il legame fra tema e paesaggio, opportuno al tratteggio del disegno dei personaggi e della loro psicologia, quasi venendo a creare una corrispondenza segreta fra anima e paesaggio che grazie alla musica può essere resa visibile alla percezione e all'emotività dello spettatore, con una coerenza ed attenzione alla fisionomia del paesaggio che sembra davvero memore di quello che Murray R. Schafer ha chiamato "the tuning of the world".
3. Nel labirinto della luce
Una delle grandi rivoluzioni narrative del cinema è il cosiddetto "effetto Kulešov," ossia la produzione di una narrazione sulla base fondamentale del montaggio, per cui da questa sorta di condensazione onirica, o la cui logica è molto simile al processo descritto nella Traumdeutung freudiana, si ottiene un incremento della forza evocativa dell'immagine più che dal mero svolgimento della fabula. Il che implica anche un congedo dal naturalismo, lasciando spazio ad una scrittura emotiva e, appunto, perfino onirica. A qualcosa di simile pensava Ejzenštein quando ne Il futuro del sonoro (1928), parla di contrappunto fra suono e immagine: "Soltanto l'impiego contrappuntistico del suono rispetto all'immagine offre possibilità nuove e più perfette forme di montaggio. Pertanto le prime esperienze di fonofilm debbono essere dirette verso una non coincidenza tra immagine visiva e immagine sonora: questo sistema porterà alla creazione d'un nuovo contrappunto orchestrale". Se questo effetto di condensazione diviene il nesso portante del processo filmico, nella stessa misura il contrappunto musicale, al di là della rigidità del paragone, dovrà operare con la stessa capacità di operare per blocchi analogici e non secondo la logica della stretta corrispondenza fra suono e immagine. La musica deve perciò farsi attenta al ritmo interiore della narrazione, divenire esperta nel tracciare le segrete pulsazioni che battono sotto la sottile pelle dell'immagine. Il respiro delle immagini, la vibrazione della pellicola, la vibrazione del diaframma. Ascoltare le immagini, in un certo modo, significa mostrare la musica com'è, come una conseguenza del respiro, la stessa naturalezza, la stessa irrinunciabile necessità.
Al cinema siamo inconsapevolmente vittime di una scissione, nel senso che si "audio- vede". O meglio, forse scomponiamo e ricomponiamo quella che è la nostra unitaria percezione del mondo circostante in due ipotesi o finzioni narrative ben distinte: immagine e suono. La musica irrompe dove prima non c'era, riceve dal suo rapporto con l'immagine la carica emotiva di cui sembra responsabile. È vero che alcuni stili rinviano a un'atmosfera molto precisa, ma molta musica è piuttosto generica, indeterminata. In tal caso è l'immagine o piuttosto la situazione drammatica che decide. Si verifica una proiezione sulla musica di ciò che si sa, oppure, in modo più interattivo, la situazione proietta un sentimento sulla musica che lo riproietta sull'immagine in una sorta di specularità che è anche una modalità del pensiero. In un paradosso: ciò che l'immagine pensa.
Il paradosso dell'immagine è semplice e sconvolgente al tempo stesso: testimonia la presenza di un'assenza (vale la pena leggere in questa chiave i Frammenti di un discorso amoroso di Barthes come una propedeutica al discorso con l'assente: "All'assente, io faccio continuamente il discorso della sua assenza; situazione che è tutto sommato strana; l'altro è assente come referente e presente come allocutore. Da tale singolare distorsione, nasce una sorta di presente insostenibile; mi trovo incastrato fra due tempi: il tempo della referenza e il tempo dell'allocuzione: tu te ne sei andato (della qual cosa io soffro), tu sei qui (giacché mi rivolgo a te). Io so allora cos'è il presente, questo tempo difficile: un pezzo di angoscia pura". Per tale ragione, l'assenza deve essere manipolata: "trasformare la distorsione del tempo in un movimento di va e vieni, produrre del ritmo, aprire la scena del linguaggio (il linguaggio nasce dall'assenza: il bambino si è fabbricato un rocchetto, lo lancia e lo riacchiappa, mimando la partenza e il ritorno della madre: un paradigma è stato creato). [...] Questa messa in scena di linguaggio allontana la morte dell'altro: un brevissimo momento, si dice, separa il tempo in cui il bambino crede sua madre ancora assente da quello in cui la crede già morta. Manipolare l'assenza significa far durare questo momento, ritardare il più a lungo possibile l'istante in cui l'altro potrebbe, dall'assenza, piombare bruscamente nella morte". Come non pensare che anche il movimento delle mani sul pianoforte sia così simile a quel gesto infantile di lanciare e riprendere, mimare partenza e ritorno, assenza e presenza. Queste intense osservazioni possono trovare un correlato nell'antropologia dell'immagine, come scrive Hans Belting: "La relazione tra l'assenza e intesa come invisibilità e la presenza, intesa come visibilità, è fondamentalmente un'esperienza corporea. La memoria è un'esperienza del corpo quando genera eventi assenti o persone ricordate in un altro tempo e in un altro luogo. Tendiamo infatti a immaginare come presente ciò che è assente da molto tempo e attribuiamo la stessa facoltà alle raffigurazioni che realizziamo [...]". In questo senso, si può dire che la musica diviene una "storia dello sguardo". La musica si pone perciò come "stile di pensiero," come possibilità di rappresentazione della modalità del visibile.
4. Fuga verso strani paesi (Pink Floyd)
Musica scritta, ascoltata, suonata: tre cose diverse. Questo è tanto più vero quanto più sono complessi i punti di riferimento che si scelgono per sperimentare questa che altrimenti potrebbe essere una semplice constatazione più che una intrigante trama di un discorso che si addentra verso il cuore stesso della musica. Nel 2006 Rita pubblica un cd dal titolo privo di ambiguità, ma anche giocosamente divertito: The Light Side of the Moon (Le Chant du Monde - distr. Ducale) il primo passo nell'approccio della pianista al mondo ricco e ispirato della musica dei Pink Floyd.
Per un ulteriore e divertente paradosso, Rita ha ascoltato il suo brano alla radio: "Mi sono resa conto che era venuta particolarmente bene, aveva un bel suono e qualcosa di intrigante. Così ho cominciato a pensare ad un mio progetto completamente dedicato alla musica dei Pink Floyd. Più ci pensavo e più mi sembrava una missione impossibile o comunque una bella sfida, però a poco a poco tutto è diventato più definito e meno rischioso. [...] Ovviamente sono cresciuta anche con i Pink Floyd, ero una loro fan e sono sempre rimasta colpita dalla loro capacità di unire linguaggi diversi, la musica, un rock visionario e proiettato in avanti, ma anche il cinema e tutta quella serie di segnali e di suggestioni creative che hanno pervaso la loro vicenda. In un certo senso, la loro è stata arte totale e la mia generazione è stata davvero fortunata a crescere, a formarsi con artisti così importanti e ricchi di talento".
La scrittura musicale di questo gruppo può essere apprezzata ascoltandola nella interpretazione che offre la registrazione del concerto alla Casa del Jazz di Roma nella stagione 2008, tappa di un progetto che continua ancora ad andare in scena con grande fortuna e seguito -come ad esempio nel giugno scorso nell'ambito del Ravenna Festival con Rosso Floyd. Il racconto dei Pink Floyd con Michele Mari voce narrante (lettore di alcune pagine del suo Rosso Floyd, romanzo pubblicato da Einaudi nel 2010, con Andy Sheppard (sax), Matt Garrison (basso), Michele Rabbia (percussioni ed electronics sound devices), Mark Mondesir (batteria).
Dall'evasione nell'iperuranio psichedelico fino alle tormentate visioni intime e laceranti di The Wall, il cammino artistico dei Pink Floyd si è sempre più definito attraverso una strettissima correlazione fra progetto musicale e progetto visivo. La scelta di Pompei per un loro memorabile concerto, o Venezia, le fantasmagorie nell'animazione di Gerald Scarfe che ha firmato le animazioni e le scenografie di The Wall (film e tournee) è sempre più evidente che il lato oscuro della luna poteva solo risuonare dello spettro multicolore del fascio di luce neutra che attraversa il prisma triangolare nell'art work di quell'opera capitale del rock. Questa suprema sovraeccitazione del reale, questo surrealismo prima psichedelico e poi psicologico ha sempre più richiesto che il "momentary lapse of reason" venisse ad occupare il suo ruolo oppositivo di principio di ragione compositiva.
A questo punto, addentrarsi nella trama compositiva dei brani significa prepararsi ad una distillazione per via di sinestesia verso la ricerca di un "suono da vedere," un'impresa nella quale ciascuno dei musicisti chiamati a collaborare a questa operazione collettiva imprime il proprio segno; un principio dal quale Rita, da raffinata jazzista, non ha mai derogato, ma anzi talmente centrale da essere decisivo nella scelta dei compagni d'avventura: Andy Sheppard (sax tenore e soprano), Fausto Mesolella (chitarra elettrica), Giovanni Tommaso (contrabbasso), Matthew Garrison (basso elettrico), Michele Rabbia (percussioni ed elettronica), Alfredo Golino (batteria), Raiz (voce). Un ensemble emozionante capace di esprimere con straordinaria profondità la bellezza di questi brani -non mancando di segnalare la capacità interpretativa e "strumentale" della voce di Raiz che si ricava uno spazio niente affatto complementare all'insieme, ma anzi esaltando le doti sciamaniche della scrittura dei testi floydiani che meritano un piccolo supplemento d'indagine per quanto concerne la funzionalità perfettamente consimile negli elementi fonici e narrativi allo spirito della musica.
La "track list" è connessa da alcuni interfacing della stessa Marcotulli (Melodico) e di Michele Rabbia (Intromoney), piccole ma essenziali tappe di un viaggio che contempla "Astronomy Domine" (Syd Barrett), "Cirrus Minor" (Waters), "Money" (Waters), "Goodbye Blue Sky" (Waters), "Burning Bridges" (Waters - Wright), "Saint Tropez" (Waters), "Crying Song" (Waters), "Set the Controls for the Heart of the Sun" (Waters), "Us and Them" (Waters - Wright). Si tratta per la maggior parte di brani che offrono uno sviluppo melodico adeguato alle intenzioni dei musicisti e al tempo stesso proiettano una luce interessante su alcune composizioni che spesso vengono trascurate a vantaggio di altre più famose e celebrate.
Come in ogni "composizione circolare" che si rispetti, principio e fine hanno un valore ulteriore rispetto a ciò che viene posto fra questi due estremi. Nel libretto allegato alla registrazione (firmato da Alberto Castelli) viene richiamata l'occasione nella quale Richard Wright nel 1970 scrive un tema particolarmente ispirato pensando di inserirlo nella soundtrack di Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni. "Us and Them," questo è il titolo del brano, non entrò a far parte del film ma andò ad impreziosire di un bagliore ulteriore The Dark Side of The Moon, il capolavoro del 1973.
Qui appunto lo stile del "vedere" diventa "visione," e direi in pratica con quel "dérèglement" (lo chiamerei "un'oscillazione desiderante," perfettamente aderente anche a "momentary lapse of reason") professato da Rimbaud come unica soluzione per la poesia dell'avvenire, che sarebbe stata sempre e comunque "en avant". In effetti, sulle orme del maestro francese, seppure inconsapevolmente -magari-, i Pink Floyd hanno percorso un tratto ben ampio della loro straordinaria storia musicale. Ed è forse per questa ragione che il brano d'apertura della registrazione del 2008 sia tratto dal disco d'esordio del gruppo, da The Piper at the Gates of Dawn (1967) che proprio nel titolo conferma il nesso fra il poeta e il musicista. Alle porte dell'alba, la musica svela il paesaggio altrimenti invisibile delle nostre contraddizioni e del germe oscuro che cova nel cuore del diamante pazzo.
Come si può intuire, qui la qualità del suono d'insieme è la prova regina del segno raggiunto dal progetto: la ricerca sulla materia sonora, la capacità di dare spessore materico alla musica, in parte come fa un pittore amalgamando i colori sulla tela/spartito, allestendo una tavolozza dove i colori dominanti si intridono reciprocamente per esperienze e sensibilità diverse in un crossing-over che è uno dei temi fondamentali della ricerca musicale della Marcotulli, che fa di questo slancio rabdomantico e conoscitivo un suo carattere essenziale: "Il jazz continua ad essere un riferimento essenziale, ma per un musicista è importante trovare nuovi orizzonti. Ad esempio, non posso dimenticare tutto quello che ho imparato da maestri come Dewey Redman, ma la possibilità di rinnovare la tradizione del jazz è legata soprattutto al dialogo creativo con altri stili e con altri generi. O almeno, credo che questa sia un'opportunità da non perdere".
Dunque sperimentazione del molteplice, passione provata in modo profondo per una musica particolare come quella dei Pink Floyd, e una forma di affinità elettiva verso un gruppo che nella medesima misura si è cimentato con diversi stili e diversi linguaggi per ottenere infine il proprio straordinario e talentuoso modo di dire il visibile nel visionario.
5. "Et leurs souvenirs éveillés, ce furent des details interminables...": Renoir, Truffaut...
La frase, tratta da Nanà di Zola, è un indice perfetto per indicare i temi e le modalità della ricerca musicale di Rita nei confronti del cinema. La sua opera di pone esattamente in questi termini: risvegliando i ricordi, essi appaiono composti di dettagli interminabili. La musica opera perciò una scansione interminabile, una vera e propria analisi puntuale e del tutto essenziale degli elementi visibili e invisibili della narrazione filmica. Potremmo dire una lettura "fra le righe," particolarmente adatta ad un cineasta come Truffaut, così sensibile alle impercettibili sfumature esistenziali quanto più invece gli eventi sembrano porre dinanzi ai personaggi dei conflitti irrisolvibili e consueti. A un suo film Rita dedica The Woman Next Door (1998) e inoltre Omaggio a Truffaut. Come lei stessa sottolinea: ""Anche le parole sono musica," spiega l'educatore all'Enfant Sauvage. Sia François Truffaut che i personaggi dei suoi film, non possono fare a meno né dell'una né dell'altra: l'articolazione delle lettere in suoni, e dei suoni in ritmo, è il nucleo intimo e nascosto delle sue sceneggiature. Questo progetto ispirato all'opera di Truffaut cerca di trovare qualche nesso di comunicazione tra immagini, parole e musica".
Anche in questo caso l'ensemble è di grande livello (performance registrata alla Casa del Jazz di Roma nella stagione 2009): Javier Girotto (sax e flauti), Luciano Biondini (fisarmonica), Clara Graziano, Roberta Bartoletti (organetto), Aurora Barbatelli (arpa celtica), Michel Benita (contrabbasso), Alfredo Golino (batteria), Noah, Aldo Romano, Raiz, Rocco Papaleo, Gianni Iacobacci, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso (special guests). La scelta degli episodi varia da Farenheit 451 a l'Enfant Sauvage, da Le 400 coups a Effet nuit, da Jules et Jim a La nuit américaine, dalla saga di Antoine Doinel a Tirez sur le pianiste (absit iniuria verbis!): Le cinéma est le cinéma; Les 400 coups; Hoping; Songs of Experience; Escape; Musique en jeu; Les enfants s'ennuient le dimanche; Masse di memoria; Il richiamo; Antoine Doinel; Que reste-t'il de nos amours?; Fragment (on the third kind) .Quest'ultimo frammento è dedicato al personaggio di Claude Lacombe interpretato dal regista francese in Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg (Close Encounters of the Third Kind, 1977).
Il confronto, portato a diversi livelli ed epoche, diventa significativo del bisogno di nuovi confronti che Rita ha sempre dimostrato tanto nelle sue collaborazioni quanto nelle sue stesse composizioni o, in questo, caso "sonorizzazioni," espressione solo apparentemente grossolana, e invece estremamente precisa sul tipo di rapporto che il suono costruisce con l'immagine. Il progetto cui appartiene Nanà è stato lanciato dall'Espresso con la collana Sounds for Silence che comprende 12 classici del cinema muto commentati da musicisti contemporanei (Moroder, Avion Travel, Bollani, Nocenzi, Rea, Tamburini, Di Battista). Ma è su questa espressione, "cinema muto," che conviene spendere qualche riflessione. Il cinema degli esordi, osserva Marcel Chion, non era muto. Piuttosto, era la tecnica ad essere sorda, fino all'avvento del "fonofilm," come lo chiama Ejzenštein, pionieristici ma già presaghi di alcune conseguenze che magari non si sono definite secondo il pensiero del maestro russo, il quale tuttavia ne aveva intuito il valore rivoluzionario e, per certi versi, ne aveva stabilito il loro carattere di irreparabilità. D'altronde è possibile constatare che gli attori durante le sequenze pronunciano delle battute, spesso sostituite dalle didascalie che riportano alcune frasi dei dialoghi o contestualizzano una scena. Per il resto, toccava alla musica mettere quello che ancora non era possibile ascoltare. Il suono era un corpo assente che veniva sostituito, anche simbolicamente, da un corpo virtuale che era quello della musica: come nella "kenosis," lo svuotamento del divino permette il riempirsi dell'umano, in modo da permettere l'incarnazione del Verbo.
Ecco, la musica doveva compiere questo miracolo: incarnare dialoghi, sguardi, paesaggi, sentimenti. Da allora il dominio dell'immagine ha dovuto sempre più confinare, e sconfinare, nello spazio del linguaggio, come a sancire che la simulazione della realtà poteva essere finalmente vera a partire dal momento in cui insieme alle immagini ci sarebbe potuto essere il fantasma della voce.
6. Diafano, adiafano: Variazioni su tema
"Ineluttabile modalità del visibile: almeno questo, se non altro, il pensiero attraverso i miei occhi. Sono qui per leggere le segnature di tutte le cose, uova di pesce e marame, la marea avanzante, quella scarpa rugginosa. Verdemoccio, azzurrargento, ruggine: segni colorati. Limiti del diafano. Ma lui aggiunge: nei corpi. Dunque ne era conscio in quanto corpi prima che in quanto colorati. Come? Battendoci sopra il cranio, si capisce. Vacci piano. Calvo egli era e milionario, maestro di color che sanno. Limite del diafano in. Perché in? Diafano, adiafano. Se puoi farci passare attraverso le cinque dita della mano è un cancello, altrimenti è una porta. Chiudi gli occhi e vedrai."
Questo mirabile inizio del capitolo La spiaggia nell'Ulisse di Joyce ci riporta ad un punto di convergenza con l'inizio di queste note e con la più recente avventura musicale di Rita, vissuta insieme a due collaudati amici come Javier Girotto (Sax soprano e baritono) e Luciano Biondini (fisarmonica), con i quali incide Variazioni su tema (S'ard Music / Jazz in Sardegna - distr. Egea, 2011). L'esperienza del cinema non è trascorsa invano e nemmeno appare lontana, nonostante il soggetto possa apparire diverso. C'è un residuo memoriale che, come il vagare di Stephen sulla spiaggia di Sandymount, diviene un presagio del visibile, sospeso tra il diafano e l'adiafano, tra il suono e il silenzio; o, se si vuole, sospeso su quella ricerca del rapporto giusto fra suono e silenzio che occupa la mente di una musicista quanto mai sensibile come Rita alla costruzione di una melodia che, fedele alla matrice jazz della propria ispirazione, possa costituirsi in una sorta di "audiofania". Vocale e orale in musica diventano gli elementi primari di questa occasione. Suoni narranti, la voce delle figure, il canto del paesaggio che si apre su una strada da percorrere. La strada, come avrebbe amato raccontare Truffaut, è inesorabilmente connessa con l'infanzia, con la percezione che nasciamo, viviamo e ricordiamo tra i suoni e con i suoni; che l'esperienza sonora del mondo, quanto quella visibile, è l'eccezionale quotidianità di questi eventi, e che le condizioni dell'ascolto, in un preciso momento, dipendono dalla nostra capacità di condensare (in senso visivo e psicologico) tempo emozioni immagini in musica. Con la stessa precisa meraviglia dell'infanzia, la sinestesia diventa il procedimento conoscitivo prelibato: l'immagine ascoltata, il suono visibile sono meravigliose apparizioni dalle quali non esulano mai la coscienza storica e sintesi tecnico-stilistica dei musicisti.
La musica in questo caso diviene il personaggio principale e la "voce narrante" del viaggio. L'immagine è qualcosa che c'è e non c'è nella figura, ma è qualcosa di pienamente visibile nella performance. Anzi, è quello il suo vero luogo. Esiste nelle cose ed esiste nella mente, ma solo in un luogo è data la contemporaneità delle due forme di esistenza, ed è proprio nella performance. La performance è perciò la più schietta forma di audiofania possibile all'immaginazione. Di questa intenzione vogliono rendere conto le seguenti note (a cura di chi scrive), accluse nel libretto del CD: "Comporre le immagini, radunare ombra e luce, canone e fuga in un racconto legato armonicamente, è il segreto di una partitura paziente, è conoscere la corrispondenza (musicale e cromatica) fra tono e tono, fotogramma dopo fotogramma, fino alla formula che, improvvisa, spalanca il mondo: musica da vedere, ogni tasto del pianoforte come un fotogramma. Qui le voci s'intrecciano con precisa passione. La fisarmonica è come il respiro del mare, lontananza che si contrae e poi ritorna, si versa come acqua sulla terra, rende fertile la spiaggia inaridita. E con un'illuminazione rimbaudiana, il sassofono si finge pietra e gemma, vento predatore e ala di preda, un volo unico la cui parabola splendida e distante conclude un tramonto estivo. Il racconto si fa autobiografia sonora, suite che queste mani rabdomanti di suoni fissano sullo schermo, sulla tastiera, sulla gloria effimera ed eterna di un suono che si fa senso e trova, come la luce che attraversa l'acqua senza ferirla per donare l'incanto della bellezza, stringere la trama senza più legami di frammenti che variano in fuga il tema eterno della vita, questo inseguirsi d'ombre sullo schermo -qui, da nessuna parte- che chiamiamo memoria, in cerca di quella parola, che risuonando, ci ha fatti nascere."
Occorre perciò ripetere sull'inganno dello schermo il gesto di Stephen: "Se puoi farci passare attraverso le cinque dita della mano è un cancello, altrimenti è una porta. Chiudi gli occhi e vedrai.". Come le mani di Rita sulla tastiera.
Bibliografia e sitografia:
R. BARTHES, L'assente, in Frammenti di un discorso amoroso, traduzione di R. Guidieri, Einaudi, Torino, 1979, p. 35
H. BELTING, Antropologia delle immagini, edizione italiana a cura di S. Incardona, Carocci Editore, Roma, 2011, p. 16
S. M. EJZENŠTEIN, Il futuro del sonoro. Dichiarazione, in La forma cinematografica, introduzione di M. Vallora, traduzione di P. Gobetti, Einaudi, Torino, 2003, pp. 269-270
J. JOYCE, Ulisse, traduzione di G. De Angelis, prefazione di R. Ellmann, nota al testo di H. W. Gabler, Mondadori, Milano, 2000, p. 38.
R. PAVIGLIANITI, Nuovo Cinema Marcotulli, conversazione pubblicata il 30 agosto 2010 su AAJ ()
Nota dell'autore
Questo articolo nasce da una conversazione pubblica fra Rita Marcotulli e chi scrive: Ombra e melodia. Conversazione su cinema e musica (Auditorium Cariromagna, Forlì, 14 gennaio 2012), incontro organizzato e curato da Elisabetta Righini col contributo di CRAL Cassa dei Risparmi di Forlì e Cultura progetto (Forlì). A Elisabetta i nostri più sinceri ringraziamenti per la cura, la generosità e l'ospitalità dimostrate.
Foto di Dario Villa (la prima), Antonio Baiano (la seconda), Mirko Macari (la terza), Paolo Mura (la quinta), Roberto Cifarelli (la settima).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.