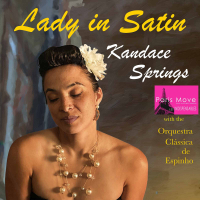Home » Articoli » Lyrics » I Soft Machine dell’età dell’oro in versione rimasterizzata
I Soft Machine dell’età dell’oro in versione rimasterizzata
...con Third le cose cambiano radicalmente e maturano di colpo, sia sul versante della follia creativa indipendente dai generi musicali consolidati, sia su quello della ri-appropriazione di un territorio con confini più delineati, anche se gli stessi vengono continuamente calpestati e modificati.
I Soft Machine dei primi due album (non compresi in questo blocco di riedizioni) erano piuttosto diversi dai Soft Machine dell’età dell’oro che certamente partì con Third, il doppio album che fece grande scalpore nel giugno del 1970, all’epoca della pubblicazione. Questo non significa che i primi due album fossero da considerare opere minori. Anzi, si potrebbe dire che erano due gioiellini che sapevano risplendere di ben definita luce propria. Erano i capolavori della patafisica applicata alla musica, le propaggini benedette di quei movimenti artistici anti-conformisti che si erano manifestati per tutta la prima parte del ventesimo secolo in Europa e della deriva beat che invece aveva preso corpo negli anni cinquanta negli States. Erano il trionfo della volontà e della passione, componenti strutturali che nel progetto complessivo risultavano decisamente più forti anche della non perfetta padronanza dei linguaggi da un punto di vista tecnico.
Ma con Third le cose cambiano radicalmente e maturano di colpo, sia sul versante della follia creativa indipendente dai generi musicali consolidati, sia su quello della ri-appropriazione di un territorio con confini più delineati, anche se gli stessi vengono continuamente calpestati e modificati. La summa della follia creativa è ben rappresentata dalla lunghissima versione di “Moon in June”, l’assoluto capolavoro di Robert Wyatt, la pazzia che si fa beffe della discontinuità e si solidifica come per magia di fronte a noi. Gli altri tre brani (tutti molti lunghi e contenuti molto semplicemente uno per lato) segnano invece l’esplosione della forma collettiva allargata del gruppo nato a Canterbury e trasferitosi nel frattempo a Londra. Una esplosione caratterizzata da una eccellente padronanza tecnica che nel frattempo si è consolidata sia per il miglioramento costante dei membri storici della band, sia per l’ingresso di musicisti di caratura superiore provenienti dalle migliori esperienze del giovane jazz inglese dell’epoca.
Nei primi due album il gruppo era stato dapprima un quartetto per diventare poi un trio. Invece nei tre lati più innovativi (da un punto di vista strutturale) di Third il gruppo si allarga per diventare un quartetto con ospiti che testimoniano l’idea di allargamento che era stata tentata verso la fine del 1969 con il coinvolgimento di Elton Dean (l‘unico che rimarrà stabilmente per un paio d’anni) e di altri tre fiati (Lyn Dobson, Marc Charig, Nick Evans). Nella meravigliosa “Facelift” che apre Third questo settetto si è già ristretto ed è diventato un quintetto e il solo saxofonista/flautista Lyn Dobson rimane al fianco di Elton Dean e del trio di base che era formato dal tastierista Mike Ratledge, dal bassista Hugh Hopper e dal batterista/cantante Robert Wyatt. Il brano dura quasi venti minuti ed è costituito da una miscela sulfurea imprevedibile ottenuta manipolando in studio il materiale registrato in concerto il 4 gennaio del 1970 a Croydon e l’11 gennaio a Birmingham.
Dopo un paio di mesi anche Dobson lascia il gruppo e la formazione si consolida in quella che è considerata la formazione classica dei Soft Machine: un quartetto con sax, tastiere, basso e batteria. Una formula apparentemente classica che sin dalle prime battute della straordinaria “Slightly All The Time”, che copre il secondo lato dell’album originale, mette in luce le proprie peculiarità. Il riff implacabile del basso elettrico di Hopper apre le danze e scopre una energia superba che si trascina dietro gli schizzi melodici del sax di Elton Dean, le lame di luce dell’organo e del piano elettrico di Ratledge, i colpi di tosse della batteria stralunata di Wyatt.
E’ in assoluto uno dei momenti più alti toccati dalla musica di quegli anni, un brano che non ci si stanca mai di ascoltare, con i suoi cambi di passo, i profumi esotici, le arabescate evoluzioni, i salti in avanti, in precario equilibrio ma sempre a cavallo del destriero magico che ci accompagna in questo volo verso le stelle.
Allo stesso modo, ma in maniera completamente diversa, il brano successivo apre altri scenari indimenticabili che fanno da perfetto contraltare a quanto ascoltato sino a quel momento. E’ la celebre versione allargata del brano “Moon in June” di cui già parlavamo sopra. Il brano era già noto nel repertorio dei Soft Machine nella formazione in trio del 1969 ma qui trova la sua consacrazione definitiva con Robert Wyatt che si occupa praticamente di tutto attraverso la magia delle sovraincisioni e mette su nastro il perfetto trait-d’union con la patafisica della incarnazione precedente del gruppo. Le sue vocine accelerate sono un segno chiaro delle sue intenzioni: espandere con ogni mezzo possibile l’area dell’esperienza e dello stupore di occhi spalancati su mondi sconosciuti. Senza fermarsi di fronte a nulla. Impavidamente, con la faccia sempre al vento, col sorriso dell’innocenza sempre pronto a scintillare beffardo e leggiadro.
In tutta la produzione musicale rappresentata in queste cinque ristampe legate a quella che ci piace definire ‘l’età dell’oro’ per i Soft Machine, questo è l’unico brano che utilizza (e come la utilizza...) la voce, vero e proprio strumento che era stato invece in primissimo piano nei primi due album del gruppo. A testimonianza di come questo sia il ponte fra i Soft Machine precedenti e quelli che stanno sbocciando, va precisato che in questo brano Elton Dean è completamente assente e il contributo di Ratledge e Hopper è decisamente marginale. Puro distillato di Wyatt, insomma.
A chiudere il doppio album originale troviamo la sperimentale “Out-Bloody-Rageous”, una lunghissima incursione nei territori minimalisti di Terry Riley, un caleidoscopio di lente permutazioni che riempiono l’aria di arcobaleni che si intrecciano fra di loro nel disperato tentativo di riflettere la luminosità dell’anima. I loop si intrecciano come per magia e vengono irrobustiti da bizzarre melodie che diventano chiari segnali di fumo per ritrovare il percorso fra le macerie allucinate che ci circondano imperturbabili.
In questa riedizione rimasterizzata tutto il doppio album originale trova posto nel primo CD e lascia spazio, nel CD aggiuntivo, per i brani che arrivano da una performance dal vivo che si tenne il 13 agosto 1970 alla Royal Albert Hall di Londra, giusto un paio di mesi dopo l’uscita di Third. I tre pezzi che furono eseguiti in quell’occasione, nella quale il concerto dei Soft Machine era abbinato ad una esibizione del maestro Terry Riley, sono già stati pubblicati molti anni fa nell’album Live at the Proms ma da tempo erano di difficile reperibilità e la loro inclusione in questa riedizione è certamente un bellissimo regalo che la casa discografica fa a tutti i numerosi fans del gruppo. Il gruppo appare in ottima forma e le versioni leggermente più compatte di “Out-Bloody-Rageous” e di “Facelift” aprono la strada per la bellissima “Esther’s Nose Job” che chiude il concerto legando assieme, in una sorta di suite, i frammenti che arrivano dal recente passato per proiettarli verso un futuro che appare assolutamente promettente.
Nell’autunno del 1970 i Soft Machine registrarono l’album Fourth che venne poi pubblicato nel febbraio del 1971. In questa edizione rimasterizzata non sono presenti brani inediti e l’album scorre via con grande intensità a partire dalla meravigliosa composizione di Mike Ratledge “Teeth”, da molti considerata il punto più alto raggiunto dalla creatività di questo gruppo. Siamo dalle parti del free jazz innervato dall'energia del miglior rock artistico, ma la band inglese utilizza un approccio del tutto peculiare che morde e graffia in maniera assolutamente originale e lascia tracce indelebili che non possono essere identificate se non come provenienti da loro.
La formazione di base è quella del quartetto classico di cui abbiamo parlato sopra, ma nelle registrazioni vengono coinvolti ospiti-amici importanti: il bassista acustico Roy Babbington, il trombonista Nick Evans, il cornettista Marc Charig, il flautista e clarinettista Jimmy Hastings, il saxofonista Alan Skidmore. Sono amici prevalentemente provenienti del giro di Elton Dean, in parte prelevati dal gruppo di Keith Tippett che negli stessi anni aveva pubblicato un paio di album eccellenti che in qualche modo lanciavano un ponte verso il versante jazzistico e free dei Soft Machine, a cominciare dal brano di Hugh Hopper “Dedicated to You But You Weren’t Listening”, che era anche diventato il titolo dell’album più noto di quel gruppo straordinario che purtroppo ebbe vita breve. Album del 1971 nel quale troviamo impegnati, fra gli altri, Dean, Charig, Evans, Wyatt e Babbington.
Fourth è un album eccellente e dopo al partenza stellare di “Teeth” il prosieguo è decisamente all’altezza con “Kings and Queen”, un brano che ritroveremo spesso nei concerti dal vivo del gruppo, con la contorta e minacciosa “Fletcher’s Blemish” e con la lunga suite “Virtually” che in origine copriva tutto il secondo lato dell’edizione in vinile. La composizione delle quattro sezioni nelle quali si divide questo brano è affidata integralmente alla sagacia di Hugh Hopper e il sax di Elton Dean è il grande protagonista di lunghe cavalcate, senza dimenticare il lavoro degli altri musicisti presenti, sempre molto attenti a tenere desto il clima incantato che sorregge tutto il brano. Una sorta di canto del cigno per questa formazione che sta mostrando le prime crepe indicatrici di quel divorzio che si consumerà nell’estate del 1971, con l’allontanamento di Robert Wyatt, ritenuto non all’altezza da un punto di vista tecnico. Un clamoroso errore di valutazione che in realtà diventerà il sassolino che farà partire la valanga di detriti e scorie che nel giro di pochi anni travolgerà definitivamente il gruppo.
Negli ultimi mesi del 1971 e nei primi mesi del 1972 viene registrato l’album Fifth, il primo senza Robert Wyatt. Al suo posto arriva dapprima il batterista australiano Phil Howard, segnalato e praticamente imposto da Elton Dean. Howard è giovanissimo, impetuoso e molto dotato tecnicamente. Spinge il gruppo decisamente verso una dimensione free e la cosa non viene molto apprezzata da Mike Ratledge e da Hugh Hopper che si trovano un po’ a disagio nel turbinio percussivo che li circonda. Con l’album già registrato per un buon 60 per cento lo scranno della batteria passa a John Marshall, un batterista inglese molto noto che già si era segnalato nei Nucleus e con il gruppo denominato 'Jack Bruce & Friends' col quale il bassista dei Cream cercava di far ripartire la sua carriera.
Lo stile di Marshall è certamente più vicino al modo di pensare di Ratledge e Hopper, ma allo steso tempo la scarsa considerazione che i due membri storici del gruppo avevano riservato a Phil Howard pongono Elton Dean nella condizione di cercare altre avventure e di abbandonare il gruppo. Lo farà amichevolmente a fine primavera del 1972, al termine di un lungo tour che tocca anche l’Italia, a registrazione dell’album ampiamente concluse.
Fifth è fortunatamente un album eccellente e le tensioni che serpeggiano nel gruppo sono utilizzate per incanalare energia positiva che rende la musica nervosa e frizzante. Anche qui il brano di apertura è straordinario e diventa uno dei punti di riferimento per le esibizioni dal vivo. Il titolo è “All White” e il compositore è Mike Ratledge. In questa riedizione viene aggiunta una seconda versione del brano che era rimasta inedita sino ad ora. L’album prosegue alla grandissima con la fascinosa “Drop” e con tutta una serie di brani ben incastrati fra di loro. Marshall compare nei tre brani centrali (“As If”, la breve “LBO” e “Pigling Bland”) e mostra di essere sin da subito a suo agio nel ruolo che a questo punto è diventato probabilmente il più difficile da ricoprire all’interno della band. Il suo approccio è solido e fantasioso allo stesso tempo e sin dalla rullata iniziale di “As If” dimostra di essere ben consapevole di quello che ci si aspetta da lui e assolutamente all’altezza del compito assegnato.
La partenza di Elton Dean è decisamente la perdita più grave che il gruppo subisce in questi anni. Proprio da John Marshall arriva il suggerimento di chiamare al suo posto il saxofonista/tastierista Karl Jenkins che era stato con il batterista nei Nucleus. Jenkins è un prolifico compositore (talmente prolifico che a volte non si nega il ricorso al plagio evidente, come accade nel caso del brano "Day's Eye", contenuto in Seven e chiaramente derivato da "Follow My Heart" di John McLaughlin) e un ottimo polistrumentista che sa cavarsela egregiamente anche all’oboe e al sax baritono. Gli manca però quello spessore che aveva sempre caratterizzato l’avventura dei Soft Machine, quel gusto per il rischio e per il bizzarro che era la cifra stilistica più importante sin dai giorni di Canterbury. Le cose iniziano lentamente a farsi meno intense e l’acqua che scorre nei cieli della Morbida Creatura a forma di Macchina va a finire inopinatamente nel vino.
Il sesto album, intitolato Six (e non Sixth come ci saremmo aspettati), era un album doppio nell’edizione originale in vinile. I primi due lati contenevano brani tratti da esibizioni dal vivo a Brighton e a Guildford nell’autunno del 1972, mentre il terzo e quarto lato erano composti da quattro lunghe composizioni realizzate in studio più o meno nello stesso periodo. In questa riedizione in CD tutto il materiale viene riproposto in un unico dischetto e la parte dal vivo, caratterizzata da bozzetti che spesso sono di breve durata, assume la forma di una suite che tenta di ripercorrere velocemente le tappe dell’avventura precedente. Sin dalle prime note affidate al sax baritono di Karl Jenkins ci accorgiamo che lo scenario è mutato, seppure impercettibilmente: le trame pianistiche sono sempre più in evidenza, le discese in aree narcisistiche si fanno più evidenti, le schematizzazioni ritmiche diventano più frequenti. Il profumo del free jazz è un ricordo piuttosto remoto e avanzano le sottili seduzioni della fusion, spesso costruite con passo felpato e certamente sempre sviluppate con grande competenza, ma forse con un pizzico di passione in meno rispetto all’incedere impetuoso e affannato, per il troppo batticuore e la troppa adrenalina, degli album precedenti.
La parte in studio è un chiaro segnale che l’unità del gruppo si sta perdendo. Emergono atmosfere pastorali fra le brume delle tastiere e dei sequencer. L’impatto ritmico è decisamente più rarefatto e lascia emergere derive associate ad altre formazioni del jazz inglese, con particolare riferimento ai Nucleus. Le quattro composizioni sono suddivise fra Jenkins, Hopper e Ratledge (che ne firma due) e si propongono come manifestazioni che lasciano sfogare gli ego individuali più che vere e proprie avventure collettive. E’ sostanzialmente lo stesso schema che ci era stato proposto con Ummagumma dei Pink Floyd: un doppio album che vedeva il gruppo (in quel caso in grandissimo spolvero) impegnato dal vivo nei primi due lati e poi singole composizioni che mettevano in evidenza le individualità dei membri della band nel terzo e nel quarto lato dell’album. Anche il quel caso l’album fece da spartiacque fra la versione più creativa e coraggiosa del gruppo e la successiva reincarnazione più magniloquente, barocca e baciata dal successo di pubblico.
Nel caso dei Soft Machine questo successo non fu così fragoroso ma sicuramente il loro orizzonte commerciale cominciò ad allargarsi. L’album successivo, intitolato Seven, fu realizzato un po’ di corsa, dopo che anche Hugh Hopper aveva deciso di mollare. La band aveva un tour americano già programmato e decise che sarebbe stato opportuno utilizzarlo per promuovere un nuovo album. Per realizzarlo venne deciso di sostituire Hopper con Roy Babbington (in questo caso impegnato prevalentemente come bassista elettrico) e velocemente vennero realizzati i 12 brani che compongono l’album. Non ci sono brani particolarmente esaltanti, si continua nel progressiva tipicizzazione del gioco tastieristico ormai quasi costantemente basato su riff, anche se Ratledge sembra ormai l’ombra di se stesso e il peso della leadership è sempre più spostato verso Karl Jenkins che si spende soprattutto come tastierista e firma ben sette brani, mentre gli altri cinque sono spartiti fra Ratledge e Jenkins.
Dopo questo album, non troppo soddisfatti delle attività di promozione che la casa discografica stava mettendo in campo per loro, i quattro musicisti decisero di cambiare etichetta e continuarono a percorrere una strada in salita che ben presto si trasformò in un vero e proprio viale del tramonto. L’album successivo si chiamò Bundles e interruppe definitivamente il vezzo di utilizzare un numero progressivo per titolare i loro lavori. Per di più venne aggiunta una chitarra elettrica (quella eccellente di Allan Holdsworth) e cadde un’altra barriera importante: quella di essere stata una delle poche band di quell’epoca a non avere basato sulla chitarra elettrica il proprio suono.
Ad ogni buon conto, anche per merito dell’eccellente lavoro di rimasterizzazione effettuato in questa occasione, i cinque album dei Soft Machine, pubblicati in contemporanea dalla Sony, sono un’occasione decisamente imprescindibile per rileggere la storia di un gruppo che ha avuto un ruolo fondamentale nella musica del ventesimo secolo. I bei libretti allegati contengono un interessante saggio di Mark Powell, uno degli storici più accreditati della band, e belle fotografie che ci fanno riassaggiare anche visivamente un’epoca che ha lasciato straordinarie tracce benefiche per la cultura e la musica che ancora oggi ci portiamo in spalla. Che la Morbida Macchina sia con voi.
Foto di Claudio Casanova
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.