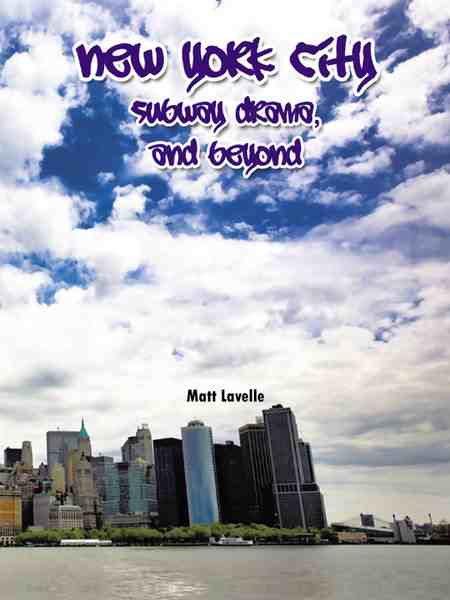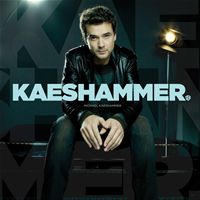Home » Articoli » Lyrics » Craig Harris: Di che colore è il trombone di dio?
Craig Harris: Di che colore è il trombone di dio?
"What color is virtue?" Duke Ellington, My People
Non si può dire che il nome di Craig Harris sia fra quelli che vengono citati per primi quando si tratta di nominare i protagonisti di uno stile o di un periodo storico. Come specialista del trombone, egli ha sofferto dell'improvviso (e doveroso) ritorno di popolarità dello strumento negli Stati Uniti verso la metà degli anni Settanta, esattamente il momento in cui cominciava a farsi notare: ha dovuto dunque fare i conti con un piccolo plotone di agguerriti colleghi-avversari, diversi dei quali avevano già conosciuto una notevole visibilità. Inoltre, la peculiare personalità di Harris lo ha portato a farsi valere in vari ambiti espressivi (benché riconducibili a un preciso contesto musicale) che forse hanno reso meno riconoscibile, almeno per qualche tempo, il profilo della sua poetica. Fra i suoi coetanei, a cavallo fra anni Settanta e Ottanta, è pacifico che George Lewis incarnasse ai massimi livelli l'estetica d'avanguardia di Chicago; Joseph Bowie e Ray Anderson si preoccupavano di intrecciare (da prospettive molto diverse) le sonorità sperimentali con la funkiness contemporanea; Gary Valente sottolineava la solennità quasi mistica dello strumento, soprattutto nelle tessiture orchestrali di Carla Bley; Robin Eubanks elaborava una radicale attualizzazione del trombone partendo dalla tradizione dell'hard bop; Steve Swell ne aggiornava le caratteristiche vocali esaltate dall'esperienza del free. E c'era anche qualche figura un po' più giovane a ritagliarsi spazi, come Conrad Herwig che sviluppava un originale lessico postcoltraniano o Frank "Kuumba" Lacy, espressionistico guastatore della formalità accademica. Craig Harris pareva uno degli "altri," un musicista caloroso e disponibile, un "uomo per tutte le stagioni".
Naturalmente non si vuole qui sostenere la tesi che un artista, per poter emergere, debba trovarsi una "nicchia" stilistica ancora inesplorata e rimanere all'interno di quei confini, ma certo l'ascoltatore - anche e soprattutto l'appassionato - si costruisce delle caselle mentali nelle quali si compiace di collocare i propri beniamini. In questo senso, era più facile nei primi anni rappresentarsi l'immagine di Harris attraverso un "colore" piuttosto che con un disegno ben definito. Emerso con funambolica robustezza all'interno dell'Arkestra di Sun Ra, annata 1976 (dove incarnava tutto solo la sezione dei tromboni, pur essendo affiancato da un suono analogo com'era quello del corno di Vincent Chancey), passato attraverso qualche formazione di Abdullah Ibrahim fra anni Settanta e Ottanta (con lui fu in Australia, dove si appassionò alla musica degli aborigeni e imparò a suonare il loro più celebre strumento, il didjeridoo), significativamente scelto da Muhal Richard Abrams per il suo primo disco orchestrale ("Blues Forever" del 1981), Harris si mostrava finalmente in piena luce nel 1982.
In quell'anno, esattamente il 30 giugno, suonava alla Carnegie Hall in un gruppone eterogeneo di talenti da poco emersi denominato per l'occasione "The Young Lions" (termine che avrebbe poi connotato solo una certa fascia stilistica di quella generazione): al suo fianco, fra i tanti, Wynton Marsalis, James Newton, Fred Hopkins, Hamiet Bluiett, Anthony Davis, Bobby McFerrin. Ma soprattutto era l'epoca in cui Harris si faceva ascoltare in due delle maggiori formazioni di ricerca dell'epoca: l'ottetto di David Murray - in cui aveva preso il posto di George Lewis - e il Sextett di Henry Threadgill. Ingaggi di grande rilievo, ma contrassegnati da quello che per un giovane solista poteva anche diventare un limite: la dominanza appunto del "colore," degli originali impasti timbrici, che Murray e Threadgill (dimostrandosi in pieno, loro sì, forze creative dominanti dell'epoca) rigiravano caleidoscopicamente attraverso gli arrangiamenti, mostrandone di volta in volta il fascino evocativo, la pregnanza ritmica, la ricchezza armonica, la potenzialità contrappuntistica. Stava poi ai singoli solisti ricavare da questa complessa tavolozza anche quello che nel jazz "classico" era dato per scontato, l'individualità melodica, la "voce" solistica.
Ora, l'immagine sonora del Craig Harris anni Ottanta si adeguava con energia e perfino con grazia a quelle necessità timbriche, cioè alle nuove istanze estetiche; eppure sollevava qualche dubbio sulle sue capacità di integrarle con tutta la tradizione (come invece stavano facendo magistralmente Murray e Threadgill). La sua propensione al "colore" si confermava nella militanza al fianco di Lester Bowie, nella sua popolare Brass Fantasy: gruppo esuberante e prestigioso, ma nel quale, ancora una volta, gli spazi solistici (leader a parte) potevano tradursi in episodi aneddotici, facilmente scalzati nella memoria dall'impatto d'insieme. Del resto, che Harris non fosse affatto disturbato da questa dimensione "coloristica" è confermato da alcune dediche presenti nei primi dischi a suo nome: un brano, Cootie, evocava il più pittoresco e pirotecnico creatore di "effetti" della maturità ellingtoniana; un altro, Song For Psychedelic Souls, rimandava invece all'"effettista" per eccellenza della fine degli anni Sessanta, Jimi Hendrix.
Invece, nonostante questi rischi, nonostante forse anche una certa cecità o disattenzione critica, nel corso degli anni Ottanta il trombonista creava un corpus di opere che delineava sempre più chiaramente un preciso solco espressivo. Un disco come "Blackout In The Square Root Of Soul" (che già nel titolo riesce a miscelare quasi parossisticamente tanti termini evocativi delle nuove tendenze musicali) non è più solo un repertorio di possibilità ma un ricco viaggio attraverso il multidimensionale mondo contemporaneo dei suoni, controllato con polso fermo da un leader che non arretra di fronte alla difficoltà di unire le tastiere elettroniche, la chitarra elettrica, le strutture funky-soul al didjeridoo, agli impasti da big band dei fiati, ai bordoni sonori ancestrali. Il "colore," insomma, si trasformava in poderoso affresco, nel quale proprio l'insistenza sulla sua natura cromatica dava vita a una qualità narrativa. E lo stesso avveniva, negli anni seguenti, con la gestione del gruppo Cold Play (ispirato alla musica orgogliosamente "sporca" di James Brown) o la nascita del superquartetto di tromboni Slideride, in cui incontriamo su un piano paritetico i virtuosi più estroversi di quella generazione: oltre a Harris, Ray Anderson, Joe Bowie e Gary Valente.
Ma nel frattempo Harris faceva un salto qualitativo e creava nel 1988 un'organizzazione senza fini di lucro, la Nation of Imagination Inc., con la quale realizzare lavori multimediali su larga scala; in questo modo il suo gusto coloristico assumeva una dimensione plastica, interagendo con scrittori, coreografi, registi teatrali e visivi. Un esempio di questa nuova ampiezza d'orizzonti, documentato su disco, è il mirabile album doppio "Souls Within The Veil", riflessione sul capitale testo dell'intellettuale afroamericano W.E.B. DuBois Le anime del popolo nero. Con un tentetto di grandi personalità (Hugh Ragin e Graham Haynes alle trombe, Hamiet Bluiett, Don Byron, Steve Coleman e Oliver Lake alle ance, Cecil McBee, Billy Hart e Kahil El'Zabar nella sezione ritmica), il trombonista parte nuovamente dal timbro e dalla passione per disegnare una mappa delle possibilità del jazz attuale di estrema dinamicità.
Nei numerosi lavori di vasta portata realizzati da Harris nell'ultima quindicina d'anni, è tutta la storia della nazione neroamericana ad essere esplorata e resa nuovamente attuale, in una significativa convergenza con gli affreschi sonori di altri autori di spicco della scena recente, da John Carter (Roots And Folklore) a Wynton Marsalis (Blood On The Fields) a Ernest Dawkins (il trittico di cui fa parte A Black Op'Era, presentata poche settimane fa in questa stessa rassegna), senza dimenticare David Murray, William Parker e tanti altri. In quest'ampio contesto è inserito anche God's Trombones, proveniente in prima europea direttamente dall'Apollo Theatre di New York. Rifacendosi liberamente all'omonima raccolta di poesie scritta da uno dei principali autori della Harlem Renaissance, James Weldon Johnson, Harris reinventa il paesaggio sonoro di un'America ormai lontana ma sempre viva nell'immaginario collettivo afroamericano. Johnson, nato nel 1871 all'indomani dell'Emancipazione, pubblicò nel 1927 una raccolta di poesie che riprendeva lo spirito dei sermoni tante volte ascoltati fin da bambino nelle chiese protestanti nere: discorsi vibranti non solo di orgoglio culturale e di sacrosante rivendicazioni egualitarie, ma anche di passione ritmica ed espressiva, di feeling e di soulness, di sapienza timbrica e dinamica. Lo scrittore li aveva tradotti in veri poemi, facendo emergere la naturale musicalità dei grandi predicatori (va ricordato che Johnson vergò anche il testo di quello che è divenuto uno degli inni dei neri statunitensi, Lift Every Voice And Sing).
Harris recupera il "canto" di quelle poesie (non è il primo: già nel 1969 Broadway produsse un dimenticato musical sui testi di Johnson, Trumpets Of The Lord) ma lo unisce alla selvaggia forza spirituale che emana dal suo strumento. "In tutta l'evoluzione del corno o della tromba, tanto nelle dimensioni gigantesche di alcuni di tali strumenti, quanto nel timbro metallico che a volte gli è proprio, nella rumorosa lacerazione dell'aria che vi si manifesta, sempre ritorna un'idea primitiva di orrore, di spavento (...) La loro forma, la loro materia o il loro stesso timbro evocano ancora uno stato di tenebre, di lotta, una volontà di annientamento, una contro-magia che non è da meno della magia," scriveva nel 1936 André Schaeffner nel suo Origine degli strumenti musicali. Con quattro tromboni, un eufonio e un basso tuba (suonati da buona parte della crème degli specialisti attuali: oltre al leader ci sono Joe Daley, Curtis Fowlkes, Alfred Patterson, Bob Stewart e di nuovo Valente), la dolente riflessione degli spirituals e la cupa ingiustizia della segregazione verranno sicuramente trasfigurati nelle tonalità più complesse e dissonanti che descrivono gli scenari contemporanei: quelle per le quali bisogna inventare colori forse finora mai immaginati.
Foto di Roberto Cifarelli (la prima) e Dario Villa (le altre).
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.