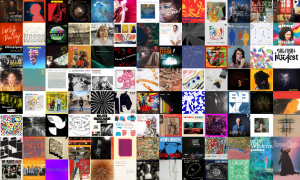Home » Articoli » Interview » The right time: intervista a Drew Gress
The right time: intervista a Drew Gress
All About Jazz: Partiamo dal tuo ultimo CD, The Irrational Numbers, il quarto in dieci anni. Come mai così poche testimonianze discografiche in una carriera come la tua? Colpa dei troppi impegni come sideman o semplicemente vuoi prenderti tutto il tempo necessario a concepire un nuovo lavoro?
Drew Gress: La questione è che sono molto lento nel comporre. Se non ho idee o ispirazione evito di costringermi a produrre: scrivo solo quando sento che ho veramente qualcosa di interessante da scrivere, senza impormi delle scadenze. Certo, sono molto impegnato come musicista, ma questo non mi impedisce di dedicarmi alla composizione o di prendermi il tempo necessario a far crescere i miei progetti. È solo che non ho alcuna fretta di accumulare dischi a mio nome.
AAJ: Parlando del tuo ultimo disco, la cosa che mi ha colpito maggiormente è proprio la felicità della tua scrittura. Come riesci a far convivere la tua formazione jazzistica, che dovrebbe spingerti verso l’improvvisazione, e la tua indole di compositore?
D.G.: Il contrasto tra improvvisazione e composizione è proprio quello che rende la scrittura nel jazz così affascinante: lavorare sul suono complessivo di una band in modo che rispecchi la tua idea di musica, senza trascurare di concedere spazio ai solisti, che a loro volta suonano per esprimere sé stessi. Quello che faccio di solito è cercare una mediazione, provando a calarmi nei panni dell’interprete e chiedendomi come si potrebbero sentire i vari musicisti a suonare la mia musica. Duke Ellington era un maestro nel fare questo. Io cerco di imitarlo applicando le sue teorie ai piccoli gruppi.
AAJ: In The Irrational Numbers hai voluto in studio la stessa band del tuo penultimo lavoro, 7 Black Butterflies. Hai trovato la band che stavi cercando?
D.G.: Assolutamente. Questa è davvero una band da sogno, fatta di splendidi improvvisatori che a loro volta sono dei grandi bandleader. C’è una totale empatia tra di noi, un senso di totale comunione che rende meravigliosa ogni nostra esibizione.
AAJ: Un altro dato che accomuna le tue ultime due produzioni è la presenza, come produttore e ingegnere del suono, di David Torn. Quanto è stato importante il suo lavoro?
D.G.: David è veramente un tipo in gamba e ha una mostruosa concezione del suono. Il sound dei miei ultimi due album è una sua creazione. Il suo primo missaggio di 7 Black Butterflies fu un’autentica rivelazione. Mi aprì gli occhi su come avrebbe potuto suonare la mia musica. Ti dirò di più, il suo mix per quel disco ha persino influenzato e continua a influenzare il mio modo di comporre. Ovviamente, ho grande stima e considerazione anche per il suo modo di suonare la chitarra e scrivere musica. Considero in qualche modo una benedizione che David, non so per quale strano motivo, si diverta a produrre i miei dischi.
AAJ: E a proposito di collaborazioni che si ripetono, la partnership con Tim Berne è senza dubbio una delle più importanti sviluppate nel corso della tua carriera. Tim suona in 3 dei tuoi 4 dischi da leader, mentre tu hai partecipato a un paio di lavori dei Paraphrase. Com’è iniziato il vostro sodalizio?
D.G.: La prima volta che suonammo insieme mi sembra di ricordare che fosse in una big band allestita dal batterista Phil Haynes, credo si chiamasse Corner Store Syndicate. La band era formata da nomi importanti della scena downtown newyorchese. Credo fosse il 1992 o giù di lì. Sembra passata un’eternità. Ma da allora Tim ha sempre rappresentato una fonte d’ispirazione inesauribile per me e la mia musica.
AAJ: Un altro musicista che considero molto affine alla tua sensibilità di compositore è Dave Douglas. Raccontaci qualcosa degli anni trascorsi nel suo String Quintet?
D.G.: Stare a fianco di Dave fu un’esperienza edificante. Mi stupiva ogni giorno con il suo modo di amare totalmente la musica. Fu un’assoluta fonte d’ispirazione. E poi si percepiva la sensazione di essere parte di una band che stava tentando di fare qualcosa di veramente nuovo. Suonare in band come quelle ti fa acquisire un nuovo livello di consapevolezza delle tue possibilità. È difficile da spiegare, ma quello che un musicista impara in quei momenti se lo porta dentro per sempre. Ti senti pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo e raccogliere qualsiasi sfida.
AAJ: Fra tutti i gruppi ai quali hai partecipato nel corso della tua carriera, Joint Venture è stato uno dei più duraturi, tre dischi pubblicati per la Enja se non sbaglio. Che cosa ricordi di quell’esperienza e di quegli anni, i primi a New York dopo un lungo periodo di apprendistato trascorso a Washington?
D.G.: Joint Venture è stata la prima band veramente cooperativa di cui abbia fatto parte. Si faceva ogni cosa in pieno regime democratico: ognuno contribuiva scrivendo musica e sviluppando idee che poi venivano integrate nel sound complessivo del gruppo. Lavoravamo per tentare di allargare i confini della nostra musica. In quella formazione cominciai a imparare come convogliare l’incredibile energia dei singoli musicisti, c’era gente del calibro di Ellery Eskelin, Paul Smoker, Phil Haynes, in un tutt’uno che fosse coeso e coerente. Inoltre, stare al fianco di improvvisatori eccezionali come Paul, Ellery e Phil, mi aiutò a trovare il suono che cercavo al contrabbasso.
AAJ: E oggi il Claudia Quintet. Raccontaci qualcosa di questa band e delle dinamiche interne al gruppo che da alcuni anni ormai condividi con John Hollenbeck, Chris Speed, Ted Reichman e Matt Moran.
D.G.: Beh, in verità il Claudia Quintet è nato da un’idea del batterista John Hollenbeck. La band è lo specchio delle idee di John e quando suoniamo sento che stiamo realizzando il suo pensiero musicale. Tra le sue influenze principali ci sono il minimalismo, la world music, il jazz, ovviamente, e un sacco di altri input che lui considera stimolanti. Trovare il modo di essere improvvisatori suonando materiale quasi completamente scritto è sempre una sfida, ma John ha scelto con cura i membri del gruppo: Chris Speed, Matt Moran e Ted Reichman sono dei veri maestri nell’interpretare le composizioni di John con spontaneità e freschezza. E anche io sto gradualmente trovando un mio modo di stare dentro al gruppo.
AAJ: Tim Berne, Ellery Eskelin, Ralph Alessi, Fred Hersch, ti senti parte di un movimento? Un modern jazz “bianco” che, partendo dalla lezione del free degli anni Sessanta e Settanta, ha reinventato il concetto di mainstream?
D.G.: Beh, non userei l’aggettivo “bianco” per connotare la cosa. Io suono con musicisti meravigliosi di ogni tipo, colore o grandezza, da qualsiasi parte del mondo provengano. Detto questo, suono e ho suonato con i musicisti che hai nominato e con quelli di cui abbiamo parlato in questa intervista perchè hanno tentato e stanno ancora provando a fare qualcosa di nuovo senza rinnegare alcuni insegnamenti del passato. Questi musicisti sono degli ottimi compositori che stanno cercando di traghettare la musica che suoniamo verso nuovi lidi. Questo è l’unico motivo per cui suono con loro. E sì, su questo sono pienamente d’accordo, stiamo lavorando e abbiamo lavorato per cercare un approccio più libero al mainstream. Che poi mi sembra un fatto inevitabile considerando quel che è stato e la storia di questa musica.
AAJ: Visto che hai parlato di passato e di insegnamenti che non vuoi rinnegare, qual’è il modello al quale ti sei ispirato come contrabbassista, quel musicista che ti ha fatto decidere di dedicarti al tuo strumento?
D.G.: Il primo a colpirmi veramente fu John Wooster, il bassista della big band di Stan Kenton. Fu grazie a lui che decisi di dedicarmi al contrabbasso. Poi, quando cominciai ad ascoltare ed apprezzare anche formazioni più ristrette, diventai un maniaco ascoltatore di Ron Carter, Buster Williams, Gary Peacock, Miroslav Vitous e Ray Brown. Anche se devo ammettere che Gary è sempre stato il bassista che sento spiritualmente più vicino.
AAJ: Tornando al presente, come ci si sente ad essere un musicista jazz nel nuovo millennio? Sei ottimista o pessimista sul futuro di questa musica?
D.G.: Credo che il Jazz in qualche modo sopravviverà anche a questo secolo, anche se il pubblico che lo ascolta è sempre stato, e sempre sarà, piuttosto esiguo. La mia speranza è che si possa continuare a seguire la nostra vocazione di musicisti jazz senza dover continuamente lottare. La strada che ha imboccato il mio paese mi spaventa, e non escludo che un giorno possa decidere di andarmene. Voglio mantenere il mio cuore puro e vivere con dignità.
AAJ: Andarsene in Europa? Ma allora ha ancora senso l’eterna dicotomia tra Stati Uniti ed Europa?
D.G.: L’Europa è diventata quello che gli Stati Uniti avrebbero potuto essere se non fossero stati politicamente dirottati e devastati da Ronald Regan nel 1981, colui che ha dato il via alla vorticosa spirale di decadenza nella quale ci troviamo ancora invischiati. Sono pessimista sul futuro del mio paese.
AAJ: Chiusura di rito. Dovremo aspettare altri quattro anni per un tuo nuovo disco?
D.G.: Tanto per cominciare è appena stato pubblicato un disco di una band che registrai nel 1989, per chi volesse scoprire che musica facevo quando ero giovane. Si intitola Tekke e ci suonano David Kane, Glenn Cashman e Mike Smith, grandi musicisti di Washington. Si può trovare facilmente su internet oppure ordinarlo sul mio sito. Un altro progetto riguarda un disco di contrabbasso solo, con strumenti elettronici ed altri aggeggi che ho costruito e che mi stanno aiutando a vedere sotto una nuova luce il contrabbasso. Inoltre, sto lavorando a un’altra registrazione in quintetto, anche se mi serviranno ancora alcuni mesi per finire di scrivere il nuovo repertorio. Infine, sto pensando di riesumare una mia vecchia band che si chiamava Jagged Sky, con Ben Monder, Dave Binney e Kenny Wollesen. Tutto quello di cui ho bisogno è un altro po’ di tempo.
Foto di Claudio Casanova
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.