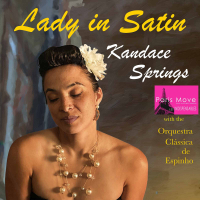Home » Articoli » Lyrics » Cal Tjader
Cal Tjader
your linen-gowned father stood
in the dayroom of the VA hospital
grabbing at the plastic
identification bracelet
marked Negro,
shouting, ''I'm not!
Take it off!
I'm Other!''
(Martin Espada)
Quella cultura latinoamericana che oggi diamo come scontata parte del melting pot americano ha a lungo tardato ad affermarsi negli Stati Uniti, salvo che in ambito musicale, dove ha invece goduto, soprattutto a livello popolare, di un consenso fuori del comune. La musica "latina" non ha dovuto, insomma, aspettare il 1990 ed essere la protagonista del best seller del vincitore del Pulitzer Oscar Hijuelos, The Mambo Kings Play Songs of Love, per potersi imporre presso il pubblico americano.
Alla fine del XVI secolo, Gaspar Perez de Villagrá, un ufficiale al servizio dell'esploratore Juan de Oñate, narra in versi la conquista del Nuovo Messico, Historia de la Nueva México, primo dramma e poema epico mai scritto negli Stati Uniti: quando il lavoro viene pubblicato, nel 1610 (ben quattordici anni prima della General History of Virginia di John Smith), gli inglesi sono giunti nelle Americhe e il testo di Villagrá narra ormai una storia superata. Circa poco meno di trecentoventi anni dopo, alle soglie della Grande Depressione, una vivace stampa ispano-americana lotta per affermarsi a New York, in California e negli stati del Sudest: il crollo di Wall Street cancella tutto ciò con la deportazione della maggior parte degli immigrati messicani. La Seconda Guerra Mondiale vede numerosi ispano-americani al fronte, senza che il contributo culturale della loro comunità venga riconosciuto. E solo nel 1986 il PEN americano si accorge dell'esistenza di una letteratura ispano-americana negli Stati Uniti, invitando una serie di scrittori latinos al 48.mo congresso; nel frattempo, case editrici come Quinto Sol o Arte Público si affermano, diffondendo gli scritti di autori come Gary Soto, Nicholasa Mohr, Rolando Hinojosa ed altri che, senza adottare una lingua ufficiale, scrivono indifferentemente in inglese, spagnolo, neorican, spanglish o calo. Come scrive Earl Shorris in In Search of the Latino Writer (New York Times, 15 luglio 1990): Were they still Latinos? Having come from Europe rather than this hemisphere, were they Latinos even before they took up Esperanto and French? No one is really quite certain about who exactly qualifies as Latino - or whether Latino, Hispanic, Spanish, Mexican, Mexican-American, Chicano, Nuevo Mexicano, Puerto Rican, Neorican, Borinqueno, Puertorriqueno or other appellations are proper names. Were John Dos Passos and George Santayana Latino writers? How shall the category be defined? By ancestry? Surname? Subject matter? Or geography? What about John Rechy, a Chicano from El Paso? Can Isaac Goldemberg, a novelist who lives in New York and writes in Spanish of his native Peru, be considered a Latino? Is Carlos Fuentes, who was raised in Washington, culturally a Mexican or a Latino?
Interrogativi che segnano l'intera esperienza culturale e sociale latinoamericana negli Stati Uniti, per quanto la musica latina abbia goduto di un'accettazione popolare pressoché immediata, ancorché spesso veicolata da personalità estranee alle radici culturali del fenomeno, come Cal Tjader o Larry Harlow. E proprio di Tjader, per lungo tempo uno fra i più popolari ambasciatori della cultura latina negli Stati Uniti, si intende approfondire la figura, oggi curiosamente dimenticata e sottovalutata.
Come si sa, quella ispano-americana è ormai la più ampia minoranza etnica negli Stati Uniti. Un elevato tasso d'immigrazione e un indice di natalità relativamente alto hanno dato un impulso alla crescita della popolazione ispanica che è stato eguagliato solo dal complesso delle minoranze asiatiche. Si prevede che nel 2050 gli ispanici negli Stati Uniti raggiungeranno il numero di circa cento milioni. Già da qualche anno, infatti, i cosiddetti "Latinos," un gruppo eminentemente radicato in aree urbane, rappresentano la maggioranza della popolazione californiana in età scolastica e costituiscono quasi il 30% della popolazione in Texas.
Come già detto, la storia delle popolazioni ispaniche in America precede la nascita degli Stati Uniti; ciononostante, negli anni Novanta, solo due terzi dei residenti negli Stati Uniti identificabili come Hispanics o Latinos sono immigrati o figli di immigrati. I bambini nati negli Stati Uniti da genitori di nazionalità americana sono meno di un terzo. Si tratta, dunque, di una popolazione recente che, pure, è l'erede di una prolungata, e talvolta turbolenta, storia di relazioni fra la maggioranza bianca e non ispanica e le genti del Messico e di altre nazioni dell'America Latina di lingua spagnola.
I Latinos sono il prodotto di una fra le più cospicue correnti migratorie della seconda metà del XX secolo, dall'America Latina verso gli Stati Uniti. Il loro alto numero li rende un importante e ben visibile segmento della popolazione americana ma altri sono i fattori che li portano spesso alla ribalta, soprattutto politica. Gli ispano-americani sono concentrati geograficamente in pochi stati e città; condividono un'eredità linguistica spagnola, uno status da minoranza svantaggiata ed un'immagine pubblica da nuovi venuti che li rende bene accetti per alcuni, invisi per altri. In più, le loro caratteristiche socio-economiche e demografiche stanno cambiando la faccia dell'America contemporanea.
L'immagine pubblica degli ispanici è, d'altronde, mal percepita per una serie di nozioni contrastanti: i cosiddetti Hispanics sono un gruppo etnico, non un gruppo razziale, secondo le classificazioni governative americane. Trattasi di una distinzione che sfugge a molti americani: gli ispanici possono appartenere a qualsiasi razza. Molti di loro si classificano come bianchi, una minoranza si definisce nera ed altri ancora, nel descrivere nei formulari governativi la propria razza, usa il termine "altro," a riprova dell'ambiguità esistente nelle definizioni di razza ed etnia negli Stati Uniti.
Popolazioni di ascendenza spagnola hanno vissuto in quelli che oggi sono gli Stati Uniti a partire dal XVI secolo. Gli spagnoli si stabilirono a St. Augustine, Florida, nel 1565, e a Santa Fe, in Messico, verso il 1609. Larga parte del Sudovest degli Stati Uniti è appartenuta agli spagnoli sino a metà del XIX secolo; dopo l'indipendenza del Messico dalla Spagna nel 1821, le aree di territorio spagnolo negli Stati Uniti finirono sotto l'egemonia messicana: il Texas conquistò la propria indipendenza dal Messico nel 1836, unendosi agli Stati Uniti nel 1845. Il restante territorio messicano venne ceduto agli Stati Uniti con il Trattato di Guadalupe Hidalgo nel 1848, a conclusione della guerra con il Messico: si aggiunsero così agli Stati Uniti aree che dovevano diventare gli stati di Arizona, California, New Mexico, Nevada, Utah, nonché parti del Colorado e del Wyoming. I cittadini messicani in tali territori divennero cittadini degli Stati Uniti, creandovi il nucleo della popolazione ispanica.
Sebbene, come è evidente, i cosiddetti Latinos siano stati presenti sin dalla genesi degli Stati Uniti, la popolazione ispanica continua a rinnovarsi attraverso le ondate migratorie provenienti dall'America Latina e dai Caraibi: più dei due terzi degli ispanici residenti negli Stati Uniti sono immigrati o figli di immigrati. Alla fine degli anni Novanta, più di un terzo della popolazione ispanica era costituita da americani di prima generazione, un terzo era costituita da americani di seconda generazione e solo il restante era rappresentato da americani di terza o più generazione. Solo i gruppi asiatici negli Stati Uniti vantano numeri più alti di americani di prima o seconda generazione.
Molti ispano-americani di prima generazione mantengono stretti legami con la loro patria, parlano poco e male l'inglese, vivono in aree etniche con altri immigrati. I loro figli, Latinos di seconda generazione, sono spesso dilaniati fra due culture contrastanti: l'eredità dei loro genitori e la società americana della loro quotidianità. Lo spagnolo è spesso la loro prima lingua, cui segue facilmente l'inglese non appena iscritti a scuola. Tali ispano-americani possono venire considerati cruciali per l'identità etnica dei Latinos in futuro: sapranno fondersi con il macrocosmo sociale, come fecero gli immigrati europei giunti negli Stati Uniti agli albori del Novecento? Mantenere un'identità Latina deve necessariamente implicare una condizione economica e sociale disagiata e svantaggiata? Come ha scritto uno scienziato della politica come Peter Skerry, il punto non è se i Latinos diventeranno come gli altri americani, ma in quali condizioni: While ... there is good reason to believe that Mexican Americans will advance socially and economically, ... it is not clear that these gains will be sufficient to satisfy [their] aspirations ... or to allay the fears of other Americans that this group will prove a net burden on this society. Much will hinge on the criteria used to evaluate the extent and pace of [their] advancement. Demografi come Frank Bean e Marta Tienda hanno evidenziato, ad esempio, come i messicano-americani siano vittime della discriminazione razziale: their brown skin and indigenous features encouraged racism and discrimination by the Anglo majority; un dato che ancora Peter Skerry non reputa significativo: the barriers [to socioeconomic advancement] facing Mexican Americans today have less to do with race than with language and social class, both functions of their position as recently arrived immigrants.
La maggior parte degli ispanici adulti negli Stati Uniti sono nati all'estero, eccetto i portoricani che, come si sa, sono cittadini americani, sia che nascano negli Stati Uniti o nel cosiddetto U.S. Commonwealth of Puerto Rico. Alla fine degli anni Novanta, 81% dei cubani e 87% degli ispano-americani adulti erano nati all'estero o nati negli Stati Uniti da immigrati. Solo il 2% degli adulti, e meno del 6% dei bambini, erano americani di terza generazione o oltre.
Centroamericani e sudamericani rappresentano la percentuale più ampia di immigrati. Quasi la metà (48%) dei 2.400.000 ispanici originari dal Centro e Sudamerica che risultavano presenti sul territorio americano al momento del censimento del 1990, erano entrati nel paese nel corso della decade precedente. Nel 1996 avevano superato i quattro milioni, costituendo quasi il 15% della popolazione ispano-americana. Più del 60% dichiarava di provenire soprattutto da El Salvador, Colombia, Guatemala, Nicaragua ed Ecuador.
Discorso a parte va fatto per la popolazione di origine cubana (circa il 4% della popolazione ispanica), che è pure costituita eminentemente da americani di prima e seconda generazione ma che è inserita in una più vecchia corrente migratoria, legata soprattutto alla rivoluzione cubana del 1959, tant'è che meno di un quinto degli immigrati cubani risulta essere entrato negli Stati Uniti dopo il 1980, al contrario degli immigrati messicani (64% della popolazione ispano-americana) che, nonostante i rapporti storici fra Messico e Stati Uniti, appartiene ad una serie di recenti flussi migratorî (meno del 30% può dichiarare di essere americana di terza generazione). Ad essi vanno ad aggiungersi dominicani e portoricani (11% della popolazione ispanica).
Questa popolazione (concentrata eminentemente in California, Texas, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Arizona, New Mexico, Colorado), che ha comunque rapporti costanti con gli Stati Uniti già a partire dall'Ottocento, ha esercitato e continua a esercitare ancora di più -la cosiddetta Reconquista- un'influenza culturale diffusa e significativa, che ormai rappresenta una componente linguistica pressoché fondamentale in molti ambiti creativi statunitensi.
Il caso di Cal Tjader rappresenta un episodio emblematico dei rapporti esistenti fra cultura ispanica e cultura americana e, soprattutto, pone in risalto una serie di peculiarità di quel Latin Jazz che, ancora oggi, esercita un fascino fortissimo anche su pubblici non ispano-americani.
Bisogna aspettare la metà degli anni Quaranta, quando inizia ad affermarsi l'opera di artisti come Dizzy Gillespie, Chano Pozo, Mario Bauzá, Machito, Stan Kenton (che già nel 1947 incide His Feet Too Big For De Bed, con i percussionisti José Mangual e Pedro Allende e cui nello stesso anno si aggiungono pagine come Cuban Carnival, The Peanut Vendor, Prologue Suite e Bongo Riff, con la partecipazione di José Mangual, Machito, Jack Costanzo e Carlos Vidal) e George Russell perché si avverta la necessità di definire con maggiore esattezza il jazz caratterizzato da elementi latinoamericani. In precedenza, una terminologia esatta veniva eminentemente applicata per identificare le variazioni stilistiche apportate dai gruppi musicali e che spesso includevano i nomi delle danze associate alle strutture ritmiche della composizione: rumba, tango, maxixe o altra dicitura, era quanto si trovava nelle incisioni di Xavier Cugat, Ernesto Lecuona, Don Azpiazú o Victor Lopez. Con il tempo, tali termini vennero usati meno frequentemente, man mano che nell'immaginario collettivo il jazz veniva sempre meno associato al ballo.
Nel 1946 si affermano due definizioni: Cubop e Latin Jazz.
Verso la metà degli anni Quaranta i musicisti più giovani definivano il be bop o il rebop in opposizione alla Swing Era. Tali nuove ideazioni, motivate da fattori sia musicali che extra-musicali, non alterano solo strutturalmente la musica improvvisata, ma anche la percezione di essa: per la prima volta si intende attribuire al jazz la patente di arte, estrapolandolo dal contesto delle musiche popolari e d'evasione. Il termine be bop evidenzia ulteriormente tale distinzione e assurge a veicolo promozionale di un modo diverso e nuovo di intendere la musica. E' Dizzy Gillespie a rendere popolare il termine Cubop, grazie anche alla presentazione alla Carnegie Hall, il 29 settembre 1947, della Afro-Cubano Drums Suite, da lui scritta con il celebre percussionista cubano Chano Pozo. A tale concerto -che includeva, oltre a lavori di Pozo e Gillespie (Manteca), anche un capolavoro del Cubop come Cubano Be Cubano Bop di George Russell- si fa risalire la nascita ufficiale del cosiddetto Latin Jazz (Roberts 1999; Delannoy 2001). In realtà, la combinazione fra l'alto profilo concertistico (il be bop allora non godeva di eccessivi consensi), le incisioni che seguirono, la statura intellettuale e musicale di Gillespie nonché il seguito di cui godeva Pozo fra la popolazione Latina di New York fece in modo che la musica cubana continuasse ad esercitare negli anni a venire.
Lo stesso termine Cubop, un'elisione delle parole Cuba e be bop, simbolizza un nuovo tipo di integrazione musicale. La musica trae ispirazione da ambedue gli stili a tal punto che non può più essere definita semplicemente come bop o come musica cubana. Il neologismo, dunque, rappresenta con esplicita adeguatezza il nuovo livello di integrazione musicale che si differenzia sia dal jazz che dalla tradizionale musica latina ma che, al contempo, richiede ai musicisti di ambedue i campi di ampliare le loro reciproche conoscenze.
Negli anni successivi numerosi jazzisti si indirizzano verso altri generi di derivazione Latina, come, ad esempio, la musica brasiliana, il che rende la definizione di Cubop estremamente limitante: si diffonde così il termine Latin Jazz, una denominazione estesa, che si riferisce a qualsiasi forma di musica improvvisata che accolga elementi musicali latinoamericani.
Sebbene la collaborazione fra Gillespie e Pozo fosse breve (1946-48), a causa della prematura scomparsa del percussionista, la sua influenza sul jazz è stata durevole e profonda: Pozo è diventato il simbolo del riconoscimento dei meriti Latini nella musica improvvisata, affermando inoltre l'uso costante e non più saltuario o esotico della conga nei gruppi jazzistici e perciò spianando la strada all'affermazione di una pletora di percussionisti latinoamericani: Mongo Santamaria, Ray Barreto, Sabu Martinez, Carlos "Patato" Valdez, Willie Bobo, Tito Puente, Dom Um Romão, Airto Moreira ed altri ancora. La collaborazione fra Gillespie e Pozo, inoltre, porta alla nascita di alcuni veri e propri standard di carattere latinoamericano, come Manteca o Tin Tin Deo (in realtà risalente ad un'incisione del 1948 di James Moody & The Modernists) e rende il Latin Jazz parte integrale dell'esperienza boppistica, tant'è che artisti come George Shearing, Cal Tjader, Stan Kenton e persino Charlie Parker (si ricordino incisioni come quelle raccolte in South of The Border, con José Mangual, René Hernández, Bobby Woodlen, Paquito Davila, Uba Nieto, Bobby Rodriguez, Luis Miranda, Mario Bauzá, Gene Johnson, Leslie Johnakins, José Madera e Fred Skerritt, o in Machito Jazz, con Flip Phillips) o Nat King Cole (Go Bongo) dedicano parte della loro opera al genere, acuendo il già avviato processo di internazionalizzazione del jazz: basti pensare al ruolo di Dizzy Gillespie come sorta di ambasciatore culturale americano in paesi come Cuba. D'altronde, si tratta della conclusione logica di un cammino iniziato fra gli anni Venti e gli anni Trenta, quando a New York, per l'esattezza nella cosiddetta Spanish Harlem, iniziano a stabilirsi musicisti cubani e portoricani che collaborano abitualmente con il mondo del jazz: si pensi al grande solista ellingtoniano, il trombonista portoricano Juan Tizol, o al band leader cubano Frank "Machito" Grillo, la cui orchestra (formatasi nel 1942) collabora con artisti quali Stan Getz, Stan Kenton, Dexter Gordon, Harry "Sweets" Edison, Zoot Sims, Johnny Griffin, Buddy Rich, Herbie Mann. Né possono dimenticarsi interpreti come il trombettista cubano Mario Bauzá (solista con Chick Webb e poi con Cab Calloway) o il flautista Alberto Socarras, solista nell'orchestra di Benny Carter. In poche parole, la partecipazione di musicisti Latinos alla scena jazzistica americana degli anni Trenta e Quaranta porta a un grande cambiamento stilistico nell'improvvisazione africana-americana: Gillespie stesso attribuisce le sue prime sperimentazioni con la tradizione afro-cubana alla sua amicizia con Mario Bauzá, così come Stan Kenton riconosce un profondo debito nei confronti del band leader Noro Morales.
Ben prima della nascita ufficiale del Latin Jazz nel 1947, il jazz e la tradizione musicale ispano-americana avevano condiviso una molteplicità di rapporti che addirittura precedevano la nascita del jazz stesso; a lungo legate all'intrattenimento della musica da ballo, le orchestre jazz erano use a presentare materiali la cui presenza era dettata dai gusti del giorno: accanto ai vari foxtrot e lindy del caso, si succedevano tanghi, rumbe, samba, merengue e conga. Fin dai suoi esordi il jazz presenta -come felicemente annotato da Jelly Roll Morton- una Spanish tinge che assume vesti più o meno preponderanti nel corso dei varî decenni: il Cubop e il Latin Jazz vanno così a definire, circoscrivere ed etichettare una zona grigia che esisteva dalla nascita della musica improvvisata africana-americana. Le creazioni di Pozo e Gillespie, così come altre, vanno a rafforzare un rapporto di lunga durata.
Il jazz che emerge a cavallo fra il XIX e il XX secolo, a New Orleans, eredita manifestamente i lineamenti carabici della cultura locale. Come fa notare Jelly Roll Morton nel corso delle sue varie conversazioni con Alan Lomax, nel 1938: If you can't manage to put tinges of Spanish in your tunes, you will never be able to get the right seasoning, I call it, for jazz. All'epoca di Morton il termine "spagnolo" poteva essere riferito a qualsiasi tipo di musica proveniente da un'area ispanica. Ma non era solo Morton a far riferimento a certe ascendenze; nel 1898, un compositore come Benjamin "Ben" Harney, pioniere del ragtime e autore di un testo come Ben Harney's Rag Time Instructor, scrive nell'introduzione al testo: Ragtime or Negro dance time originally takes its initiative steps from Spanish music, or rather from Mexico, where it is known under tbe head and names of Habanera, Danza, Seguidillo, etc. (Roberts 1999:10). Lo stesso Ellington commenta nel 1938: When I came into the world, Southern Negroes were expressing their feelings in rhythmic 'blues' in which Spanish syncopations had a part (Ellington 1938:14-18).
Se è pur vero che l'iniziale influenza ispano-americana sul jazz è stata primariamente ritmica, essa comunque lascia una netta impronta sul repertorio. Basti pensare al duraturo caso di The Peanut Vendor: nel 1930 Don Azpiazú e la sua Havana Casino Orchestra si presentano al Palace Theater di New York - il gruppo include una tipica sezione ritmica cubana (maracas, claves, bongos, timbales)- una fra le prime occasioni, per un pubblico non ispanico, di ascoltare una esecuzione cubana "autentica". Il successo di tale concerto e della successiva versione discografica di The Peanut Vendor realizzata dalla RCA, contribuisce a lanciare la moda della rumba, la cosiddetta rhumba craze: la composizione di Azpiazú viene poi ripresa, fra il 1930 e il 1931: al di là del fascino esercitato da tutto ciò che si presentava con le caratteristiche dell'esotico, The Peanut Vendor radica ulteriormente la musica Latina nel contesto jazzistico e lascia già intravedere i futuri sviluppi del Latin Jazz.
Lungo tutti gli anni Trenta materiali latinoamericani vengono incorporati nel repertorio di un vasto numero di complessi jazzistici: il Savoy Ballroom, come altre sale teatrali, concertistiche e da ballo di New York, in quel periodo annuncia costantemente sia gruppi swing che di rumba. Nel 1936, commentando il proprio ingaggio al Roseland, Woody Herman riporta: The blues were the best thing we knew how to play, but we had to do a lot of fighting to play them. The management preferred we play mostly dance music -foxtrots, rhumbas, and waltzes- to satisfy the dancers (Roberts, 1999:44). D'altro canto, anche i gruppi latinoamericani includono nel loro repertorio materiali dell'epoca swing, sebbene questo interscambio avvenga ben più nelle esibizioni dal vivo che non nelle registrazioni discografiche, ambito in cui i due linguaggi, più che interagire come nella realtà, tendono ad apparire erroneamente separati. E' pur vero che la cultura statunitense, dominata per lungo tempo dalla tradizione eurocentrica, ha per lungo tempo teso a etichettare ogni esperienza creativa extra-occidentale, anche accademica, come "esotica": interpreti popolari, celebrati dai rotocalchi, come Desi Arnaz e Carmen Miranda si sovrappongono così al processo creativo latinoamericano, inducendo il pubblico a trascurare il contributo culturale della musica Latina. Fra gli anni Trenta e gli anni Quaranta, ben di rado le copertine dei dischi riportano i nomi dei percussionisti latinoamericani che si esibiscono in orchestre americane: questo vale per The Peanut Vendor inciso da Louis Armstrong come per Goin' Conga di Cab Calloway (1940), che pure presenta per la prima volta un esteso assolo delle percussioni. Eppure il mondo latinoamericano emerge con sempre maggiore vigore: In the 1930s and '40s, Hollywood and Broadway had propelled celebrities such as Desi Arnaz and Carmen Miranda to stardom, Arthur Murray Dance Studios taught the nation the rumba and the conga, and dinner clubs in Havana, New York, and San Francisco created an imaginary Latin America, where dancing, music, food, and atmosphere celebrated a tropical paradise.27 Around the globe, Latino identities and histories were jumbled together in places like the Mocambo in Hollywood, the Copacabana Club in New Y ork, Havana, and San Francisco, and la Cabana Cubana in Paris, where Latino musicians and singers from diverse Latin cultures carne together and performed. In fact, the proliferation of Latin nightclubs in popular culture, combined with such prominent depictions as Desi Arnaz playing a Cuban bandleader for the Tropicana Club on I Love Lucy, intimately linked Latino identities with a celebratory nightlife (Cary Cordova, The Heart Of The Mission:. Latino Art And Identity in San Francisco, Dissertation, The University of Texas at Austin December, 2005). Come scrive Alberto Sandoval-Sanchez: In the 1930s and 1940s, Latin America became a postcard, a photograph, a tourist attraction, a night club, a type of theme park where fantasy and fun were guaranteed and escapism assured while U. S. national security interests were guarded (Alberto Sandoval-Sanchez, José, Can You See?, Madison: University of Wisconsin Press, 1999).
Per lungo tempo il cosiddetto Latin jazz è stato considerato un sotto-gruppo linguistico del jazz, più che un'altra, significativa espressione della diaspora africana nelle Americhe. La produzione discografica ispano-americana, d'altronde, è andata assumendo un ruolo indipendente o, se vogliamo, in parte isolato all'interno della discografia statunitense, con un Grammy apposito e una serie di stazioni radio interamente dedicate ad essa. All'interno di questo contesto il Latin jazz rappresenta una curiosa creatura perché, per quanto con il jazz condivida ben più delle semplici origini, al contempo il suo sviluppo è stato concepito in modo diverso, dal pubblico del jazz come dal quello latinoamericano: la sua hispanidad ha ostacolato, più che facilitato, una sua identificazione con il Canone africano-americano. In qualche modo il Latin jazz sembra partecipare al canone jazzistico, senza però appartenervi interamente. E' un dato interessante, se si considera che i cubani che emigravano negli Stati Uniti fra gli anni Trenta e Quaranta erano i portatori di un'orgogliosa négritude, già definita negli scritti in cui intellettuali come Fernando Ortiz e Nicolas Guillén predicavano un'orgogliosa riscoperta e riappropriazione delle radici africane della cultura cubana. Non è forse casuale che Machito denominasse la sua orchestra newyorkese The Afro-Cubans, così come non è trascurabile l'entità del contributo di Chano Pozo alla diffusione di una sensibilità afrocentrica nell'ambiente jazzistico di New York. Artista virtuoso, con una profonda conoscenza degli aspetti sacri e profani della cultura musicale cubana, Pozo introduce il jazz americano alla profonda spiritualità che caratterizza molte aree della musica tradizionale di Cuba e che era virtualmente assente nel jazz in voga negli anni Trenta negli Stati Uniti. Le interiezioni di Pozo in lingue africane, il suo uso delle musiche religiose connesse al credo Abakwa (o Abakuá) e uno strumento originario dell'Africa, come la conga da lui usata, illustrano ai musicisti africani-americani, attraverso il legame con Cuba, una connessione diretta con l'ancestralità africana, con quella patria africana il cui nome ispira il nascente movimento per i diritti civili. Non è una coincidenza, infatti, che la nascita del Cubop affianchi il nuovo interesse per la diaspora africana da parte degli intellettuali africani-americani. A proposito della sua storica collaborazione con Pozo, commenta infatti Dizzy Gillespie: I found the connections between Afro-Cuban and African music and discovered the identity of aur music in theirs (Gillespie 1979:290). Lo svilupparsi di una coscienza diasporica fra gli intellettuali africani-americani negli anni Quaranta e Cinquanta rende la musica afro-cubana essenziale nella triangolazione fra Africa e America africana: musicisti come Art Blakey (basti pensare a lavori discografici come Orgy in Rhythm, Holiday for Skins, Cu-Bop!, The African Beat o alle collaborazioni con artisti ispanoamericani come Sabu Martinez e Carlos "Patato" Valdez) e Max Roach, influenzati da Chano Pozo e Machito, adattano i ritmi afro-caraibici alla batteria africana-americana e li incorporano all'interno di strutture improvvisative di matrice jazzistica, in un'epoca in cui è certamente più facile usare gli artisti latinoamericani come mediatori che non rivolgersi direttamente alle fonti africane. Non casualmente, ai giorni d'oggi un artista come David Murray commenta: I'm not interested in going to Cuba and mixing, I mean that's been done. I'm not from Cuba; I'm from somewhere in Africa. I'd just like to find that place and know that I've touched home.
Con l'espansione della sua popolarità, la musica latinoamericana negli Stati Uniti adotta due tipi di comportamento: da un lato si allarga verso un suono più potentemente orchestrale, dall'altro si contrae in una versione cameristica che poteva essere più facilmente utilizzato dal linguaggio jazzistico post-bop (come provano alcuni dei lavori di Dizzy Gillespie). Dopo le varie innovazioni apportate alla tradizione musicale cubana da artisti come Miguel Matamoros, Ernesto Lecuona, Lázaro Herrera, Xavier Cugat, che la adattano ad un contesto urbano, è ad Arsenio Rodriguez che si deve l'idea di un maggior respiro orchestrale, nelle forze strumentali come nel suono, con l'aggiunta -alla strumentazione abituale- di almeno un'altra tromba, del pianoforte e della conga: questa è la formula che Rodriguez esporta a New York, ai primi anni Cinquanta. Nella città americana già si erano affermati gruppi come quelli di Machito, Mario Bauzá, Perez Prado e si stava per imporre un artista geniale e dal forte senso teatrale come Tito Puente, divulgatore della Charanga cubana e dei ritmi del cosiddetto Cha Cha Cha. Un mondo che presto crolla sotto i colpi dell'avvento del rock'n'roll e della rivoluzione castrista: i rapporti fra Cuba (dove peraltro il jazz viene fortemente osteggiato da Fidel Castro, che lo considera espressione dell'imperialismo americano) e gli Stati Uniti si interrompono, la musica Latina conosce un progressivo declino (e una progressiva ibridazione con il pop, da Joe Cuba a Joe Bataan) da cui si riprende lentamente solo a partire dagli anni Settanta.
E' in questo contesto che si situa il grande e grandemente sottovalutato contributo di Cal Tjader allo sviluppo del cosiddetto Latin Jazz e, dunque, al jazz tout court a partire dagli anni Cinquanta. Artista oggi quasi del tutto dimenticato dal pubblico, questo vibrafonista di origine svedese, sin dai suoi brillanti esordi nell'ambito del cosiddetto West Coast Jazz, mostra un peculiare penchant per la cultura latinoamericana: a partire dagli anni Cinquanta sperimenta una sintesi fra materiali ritmici afrocubani e progressioni armoniche di uso jazzistico che trasformerà la musica afrocubana negli Stati Uniti, nonché suoi derivati come la cosiddetta salsa (termine che prende vita proprio da un celebre lavoro discografico di Tjader, Soul Sauce, e che va a sostituire Azúcar, coniato da Eddie Palmieri e dai musicisti afrocubani di New York), contribuendo in modo estremamente originale allo sviluppo di una peculiare area della cultura popolare americana e altresì sottolineando il contributo culturale di gruppi etnici ampiamente disprezzati negli Stati Uniti (e non solo: anche a Cuba, ad esempio, i musicisti di colore erano fortemente osteggiati. Come ricorda il celebre percussionista Mongo Santamaria: Those old people in that movie Buena Vista Social Club, they're 90 years old. They never had any chances. They grew old, and nothing happened. One time in Cuba there was a problem with color. I used to play good, yeah. But one band, they were white people. They used to call me to make a recording. But they didn't want me in the band on stage. That's what it was like in those days. You worked good and everything, but you never had any chances. In the nightclubs and everything there was too much discrimination. That happened in many places. But today you have white and black together. That band Irakere was whites and blacks together, and they didn't have any problem. That problem was eliminated. A lot of things in Cuba the American people don 't know about. But I was born over there. And I saw many, many things, in the nightclubs, many things that were happening over there).
Ricorda Tjader di essere andato nel 1953 al Palladium Ballroom di New York, assieme al contrabbassista Al McKibbon (strumentista di fama e valore, letteralmente rapito dalla cultura afro-caraibica), ad assistere ad un concerto delle orchestre di Machito e di Tito Puente: They fractured me! I had never heard such sounds ... Soloists were playing jazz and I was unfamiliar with the rhythms ... they were jazz oriented. I didn 't know what mambo was ... but WOW! I was knocked flat when I saw how Puente utilized his vibes in Latin music. I got hooked on Puente. Alla fine di quell'anno, il vibrafonista, allora membro del gruppo di George Shearing, partecipa all'incisione di Latin Satin ed è pronto ad iniziare il percorso che lo porterà al successo.
Shearing e Tjader condividono un interesse per la cultura musicale ispanoamericana: negli anni Quaranta, negli Stati Uniti, era dilagata la cosiddetta mambo craze, che aveva portato alla ribalta numerosi musicisti Latinos. Ricorda il celebre percussionista Mongo Santamaria, che agli inizi del 1953 si esibiva con un altro percussionista, Willie Bobo, nell'orchestra di Tito Puente: We played San Francisco's Club Macumba. One night, Willie, Bobby Rodriguez and I sat in with Tjader and the audience went crazy. They loved us. After the gig, Willie and I played several Cuban rhythms for Tjader. We taught him 6/8 time (Rumba Colombia) and we explained it to him until 6 AM. Everywhere we played after that, Tjader was in the audience watching us. (...) Willie, Bobby and I recorded with Tjader, and Tito got mad when the album came out. Tjader mentioned he was going to reorganize his band in six months and would love to have us. In the meantime Willie and I organized a band with Ray Coen, Chombo Silva (who appeared on a Tjader recording), and Marcelino Guerra which Frederico Pagani baptized 'El Conjunto Manhattan.' In March, 1958, 'Manhattan' was hot so I told Willie I was not going to join Tjader. Willie became upset. The next day Willie called me to say that Tjader was forming a new group and that our piane tickets were on the way. I broke up 'Manhattan' and went to California with Willie (Smithsonian Institution Jazz Oral History Program, 1996).
Sia Santamaria che Bobo e Armando Peraza (altro illustre percussionista ispanoamericano) beneficiano del successo ottenuto come solisti nei gruppi di Tjader: il loro lavoro eredita e sostituisce quello di Chano Pozo con Dizzy Gillespie e crea le basi per fenomeni successivi come salsa, Latin Jazz e Latin Rock (non casualmente, Peraza otterrà ulteriore successo nei gruppi di Carlos Santana).
Chi è, dunque, Cal Tjader, artista oggi pressoché dimenticato fuori dagli Stati Uniti, creatore di un laboratorio culturale determinante per la cultura ispanoamericana?
Callen Radcliffe Tjader, Jr era di origini svedesi. Suo nonno, Anton William Tjader, un apprezzato chirurgo nel Nevada, era stato citato da Mark Twain in Early Tales and Sketches. La famiglia del futuro musicista apparteneva comunque al mondo dello spettacolo: madre pianista, padre produttore e animatore di spettacoli di vaudeville. Il giovane Tjader viene avviato al mondo dell'intrattenimento in giovane età: a quattro anni già si esibisce come ballerino di tip tap. Con i familiari si trasferisce poi in California, dove inizia a praticare la batteria e ad esibirsi con alcuni gruppi di jazz tradizionale: il 7 dicembre 1941 vince anche un'importante competizione dedicata a Gene Krupa ma il suo successo viene oscurato da una notizia più rilevante: l'attacco giapponese a Pearl Harbour. Dal 1943 al 1946 Tjader, perciò, combatte in Marina, sul fronte del Pacifico. Al ritorno dalla guerra studia al San Jose State College e al San Francisco State College, dove incontra il contraltista Paul Desmond e, al Mills College, altri futuri protagonisti della musica improvvisata nella West Coast, fra cui Dave Brubeck, del cui ottetto e trio fa parte dal 1949 al 1951, esibendosi al Blackhawk di San Francisco quasi ogni settimana.
Grazie alla conoscenza con Desmond e Brubeck, Tjader ottiene di incidere fra il settembre e il novembre 1951 una serie di brani per l'etichetta discografica Fantasy: The Cal Tjader Trio, pubblicato nel 1953, è un lavoro tutt'altro che banale, soprattutto per un esordiente. Oltre a vantare in alcune pagine la presenza di un futuro, geniale ma sottostimato protagonista della West Coast come il pianista Vince Guaraldi (lo si ascolti in Three Little Words), l'incisione è premonitrice della più matura opera del vibrafonista (in questo caso soprattutto batterista e percussionista; va peraltro ricordato che nel 1953 una pubblicazione come Down Beat premia Tjader come miglior batterista emergente) nell'ambito del Latin Jazz, come nel caso di pagine quali Mambo Chopsticks, Ivy, Charlie's Quote, Give Me The Simple Life.
Ancora nel 1951, il gruppo di Dave Brubeck si scioglie a causa della prolungata inattività del leader, costretto all'immobilità dopo un grave incidente: Tjader si esibisce soprattutto in trio con il pianista John Marabuto e il contrabbassista Ron Crotty (talvolta sostituito da Jack Weeks). Nel 1953, dopo avere collaborato con l'orchestra di Alvino Rey, Tjader si trasferisce a New York, dove entra a far parte del gruppo del pianista inglese George Shearing, anch'egli fortemente interessato alla musica ispanoamericana ed influenzato dalla mambo craze. Del complesso del pianista -esponente di una versione addolcita e popolarissima ma estremamente sofisticata del bop- fanno anche
parte il già citato contrabbassista Al McKibbon e, poco dopo, il percussionista Armando Peraza, nonché Willie Bobo e Mongo Santamaria. Shearing incide una molteplicità di lavori discografici chiaramente influenzati dalla musica Latina e con la partecipazione di percussionisti come Armando Peraza, Emil Richards, Willie Bobo, Candido: Latin Satin (con Cal Tjader e Toots Thielemans), Shearing in Hi-Fi (con Cal Tjader), George Shearing Caravan, An Evening with George Shearing, The Shearing Spell, Velvet Carpet, Latin Escapade, Black Satin, In The Night, Burnished Brass, Blue Chiffon, Latin Lace, George Shearing On Stage, Latin Affair, Beauty and the Beat, On The Sunny Side Of The Strip, Satin Affair, White Satin, The Swinging's Mutual, Mood Latino, San Francisco Scene, Love Walked In, Rare Form, Latin Rendez-vous, Satin Latin, The Shearing Spell, Latin Escapade.
Tjader lavora con Shearing come vibrafonista e percussionista per un breve periodo. A New York incide nel 1953 per la Savoy a fianco del trombettista e vibrafonista Don Elliot (Cal Tjader/Don Elliott - Vibrations, Savoy MG 12054) e a suo nome (Cal Tjader Vibist, Savoy MG 9036, con Hank Jones, Al McKibbon e Kenny Clarke), prima di tornare a San Francisco dove, l'anno dopo, crea The Cal Tjader Modern Mambo Quintet, per il quale ottiene un contratto discografico con la Fantasy Records (pagine come Midnight Sun, Cherry, I'll Remember April, Bye Bye Blues sono raccolte in Mambo with Tjader, Fantasy LP 3202). Nel marzo 1954 il Cal Tjader Sextet (con Jerome Richardson, Richard Wyands, Al McKibbon, Roy Haynes e Armando Peraza) e il Cal Tjader Quintet (senza il sassofonista e flautista Jerome Richardson e con il pianista Eddie Cano al posto di Richard Wyands) realizzano alcune pagine raccolte dalla Fantasy sotto il titolo Ritmo Caliente! (Fantasy LP 3216, integrato da altri brani realizzati nel novembre 1955 con Jerome Richardson, Manuel Duran, Al McKibbon e Armando Peraza): si tratta di uno fra i primi e più riusciti esperimenti del vibrafonista nella sua opera di contaminazione fra il linguaggio improvvisativo di derivazione jazzistica e le tradizioni musicali afro-ispanoamericane. Soprattutto, Tjader conferisce una nuova e diversa complessità ai materiali latini, la cui struttura armonica era allora relativamente semplice. Si noti inoltre la sua capacità di giocare di sponda fra le diverse tradizioni: Cubano Chant di Ray Bryant, ad esempio, si sviluppa in tre diversi tronconi, in un gioco di echi e di rimandi fra jazz, swing, rumba, mambo. Allo stesso tempo, Panchero Mambero (in cui Tjader si alterna al vibrafono e ai timbales), come Ritmo Caliente, rilegge il mambo nell'elegante stile creato da George Shearing, laddove Afro-Corolombo, col suo peculiare 6/8, non solo evidenzia la notevole adesione linguistica di Tjader alla tradizione afro-cubana ma anche lo straordinario contributo ritmico fornito da Armando Peraza. Ancora più efficace è la trasformazione di una composizione puramente jazzistica come Bernie's Tune in un montuno pronunciato inizialmente dal pianoforte di Richard Wyands.
Tjader, non casualmente, vive e lavora a San Francisco, città che da tempo accoglie le minoranze latinoamericane. Come scrive Leonard Austin nel 1940: North Beach has been since the early days the Mexican quarter. Recent immigrants have settled in other parts of the city; notably, Hayes Valley, along Fillmore Street, along Folsom and Howard Streets from Tenth to Sixteenth Streets [in the South of Market area], in the vicinity of Treat Avenue and Twenty-second Street [in the Mission District] and in Butchertown [now Bayview] - but North Beach still remains the center of the Mexican population. Along Broadway and Powell Streets are the little shops and the cantinas, always gay and noisy. One can spend a whole day strolling along these streets, shopping in the little stores with their counters piled high with goods made in Mexico (Leonard Austin, Around the World in San Francisco, Palo Alto, CA: James Ladd Delkin, Stanford University, 1940). Ancora Austin nota il forte senso di hispanidad che unisce la locale colonia di origine spagnola e la forte diffusione del flamenco: One time in the year when one can see the true Spaniard is at their celebration honoring the discoverer of America, Christopher Columbus, or as they call him Cristóbal Colón. The whole colony comes to watch the singers and dancers of their race and encourage them with shouts of 'olé, olé'; and tremendous applause. Northern Spaniards dance their jota and Andalusians sing and dance the thrilling flamenco, and the 'cante Jondo,' or deep song. This is the most popular of the foreign folk festivals in San Francisco and brings out alI the vividness and emotion of Spanish life. Negli anni Cinquanta, alcuni locali notturni situati nei quartieri ispanoamericani della città, come El Matador, divengono popolarissimi: The last time we were there John Steinbeck was carrying on a spirited literary discussion with Barnaby, while Jane Russell, an ardent aficionada, came in to lay a rose at the feet of the Manolete painting. José Ferrer was sipping a specialty concoction known as a Picador, next to Henry Fonda and Deborah Kerr (Barnaby Conrad, Name Dropping: Tales From My Barbary Coast Saloon, New York: Harper & Collins, 1994). Al contempo, l'intera Bay Area attrae intellettuali, stimolati dal clima culturale creato dai cosiddetti beatniks (la cultura Beat trova in San Francisco la sua capitale). Come ricorda un autore e leader controculturale ispanoamericano quale René Yafiez: I was very attracted by the Beat thing when I was growing up - the beatniks - and I had seen some movies ... I came up one time and I loved San Francisco. At that time, North Beach was like a little village ... Italian restaurants and coffee houses, and it was very European, very hip, and I thought this is for me, and then I got drafted! La frenesia controllata e rilassata di Tjader riporta inequivocabilmente, d'altronde, a tale contesto socio-culturale, in cui si andavano formando sia una cultura Latina che, soprattutto, una controcultura.
Nel settembre del 1954 Tjader incide come Cal Tjader And His Orchestra, alcune composizioni raccolte sotto il titolo Tjader Plays Mambo (Fantasy LP 3221) con i trombettisti Dick Collins, John Howell, Al Porcino e Charlie Walp, il pianista Manuel Duran, il contrabbassista Carlos Duran, i percussionisti Edgard Rosales e Bayardo Velarde. Tjader suona il vibrafono e i timbales in un repertorio che include sia pagine di sapore ispanoamericano come Mambo Macumba che standard quali It Ain't Necessarily So o I Concentrate On You. A dicembre il Cal Tjader Quartet (con Bob Collins al trombone, Eddie Duran alla chitarra e Al McKibbon al contrabbasso) incide Tjader Plays Tjazz (Fantasy LP 3211, cui si aggiungono alcune pagine incise nel Marzo 1955 con Brew Moore, Sonny Clark, Gene Wright e Bobby White), essenzialmente dedicato ad un repertorio di standard: durante l'intera carriera, infatti, Tjader si alternerà brillantemente fra l'ortodossia del repertorio improvvisativo e l'esplorazione della tradizione musicale Latina, contribuendo a ricostruire il perduto ponte fra i due mondi, uno dei quali veniva ignorato non solo etnicamente, ma anche in tutto il suo peso culturale persino dalle élite intellettuali americane. Tant'è che nel 1980, il poeta Juan Felipe Herrera, rivolgendosi a Lawrence Ferlinghetti, ricorda in Ferlinghetti on the North Side of San Francisco anche all'establishment culturale statunitense l'aberrazione di un gruppo etnico in costante progresso ma non molto meno invisibile di quello africano-americano: still no one has seen you taking your beat to the mission. Taking your rap on alienation & your sketch pad half- full of mex landscapes.& nights (...) to the place where one thousand fingers tear out from silent flesh & shoot red verses through the walls. flying.across grant street. unlocking the syllables of the moon.
Per la Fantasy [Nota 1] Tjader incide numerosi dischi, in cui non solo si rivela profondo indagatore della realtà musicale ispanoamericana e del mainstream del be bop, ma anche brillantissimo strumentista dall'infallibile senso ritmico e dalla sonorità lieve e cristallina. Si succedono album come Cal Tjader Quartet (Fantasy LP 3227, con Gerry Wiggins, Gene Wright, Bill Douglass), Latin Kick (Fantasy LP 3250, con Brew Moore, Manuel Duran, Carlos Duran, Luis Miranda, Bayardo Velarde), Cal Tjader Quintet (Fantasy LP 3232, con Manuel Duran, Carlos Duran, Luis Miranda, Bayardo Velarde), Jazz At The Blackhawk [Nota 2] (Fantasy LP 3241, con Vince Guaraldi, Gene Wright, Al Torres), Cal Tjader (Fantasy LP 3253, stessa formazione di Jazz At The Blackhawk), Tjader Goes Latin (Fantasy LP 3289, con Paul Horn, Vince Guaraldi, Gene Wright, Luis Kant, Bayardo Velarde, José "Chombo" Silva, Willie Bobo, Mongo Santamaria), Mas Ritmo Caliente (Fantasy LP 3262, con diverse formazioni e musicisti quali Vince Guaraldi, Al McKibbon, Bobby Rodriguez, Mongo Santamaria, Luis Kant, Armando Peraza, Willie Bobo, Al Torres).
Dopo avere partecipato, nel 1958, a un'incisione a nome di Brew Moore Brew Moore (Fantasy LP 3264, con Vince Guaraldi, Dean Reilly, Bobby White), Tjader co-firma nello stesso anno, assieme a Stan Getz, un piccolo, sofisticato capolavoro come Stan Getz/Cal Tjader Sextet (Fantasy LP 3266, con Vince Guaraldi, Eddie Duran e due musicisti caldamente consigliati da Tjader a Getz per un suo ingaggio al Blackhawk di San Francisco: Scott LaFaro e Billy Higgins): elegante ed efficace bop -non dimentichiamo che Stan Getz è stato fra i più impressionanti strumentisti bopper- in cui il leggendario sassofonista si misura con degli standard e, soprattutto, con alcune belle composizioni di Tjader (in particolare la soffice "ballad" Liz-Anne) e Guaraldi (Ginza Samba). Allo stesso anno risalgono Latin Concert (Fantasy LP 3275, dal vivo al Blackhawk di San Francisco, con Vince Guaraldi, Al McKibbon, Al Torres, Mongo Santamaria, Willie Bobo), A Night At The Blackhawk (Fantasy LP 3283, con José "Chombo" Silva, Vince Guaraldi, Al McKibbon, Willie Bobo, Mongo Santamaria), San Francisco Moods (Fantasy LP 3271, con Manuel Duran, Eddie Duran, John Mosher o Jack Weeks, John Markham), Latin For Lovers (Fantasy LP 3279, con Paul Horn, Vince Guaraldi, Al McKibbon o Jack Weeks, Willie Bobo, Mongo Santamaria e una sezione d'archi).
Il 1959 è l'anno della definitiva affermazione di Tjader, grazie anche al Concert by the Sea (voll. 1 & 2) al secondo Monterey Jazz Festival, in aprile. Con un gruppo che include l'ottimo Paul Horn al flauto e al sassofono contralto, Lonnie Hewitt al pianoforte, Al McKibbon al contrabbasso, Willie Bobo e Mongo Santamaria alle percussioni, Tjader esplora compiutamente sia la sua eredità jazzistica (Doxy, We'll Be Together Again, Bess You Is My Woman Now, 'Round Midnight, Walkin' With Wally, S. S. Groove, Lover Come Back To Me) che il fascino esercitato su di lui dalle tradizioni afro-ispanoamericane (Tu Crees Que, Afro-Blue, A Night In Tunisia, Tumbao): l'equilibrio formale quasi classico delle sue improvvisazioni, la chiarezza delle sue linee (che Tjader eredita, soprattutto nell'attacco, da Lionel Hampton e ancora di più da Milt Jackson [Nota 3], per quanto l'arricchisca verticalmente con un uso più esteso della pedalizzazione e dei cosiddetti double stop e con l'uso di terze, quarte, seste, ottave), caratterizzate da un suono limpido e da un raffinato gusto timbrico, la sua abilità nell'improvvisare in densi contesti poliritmici (l'apporto di Mongo Santamaria e di Willie Bobo si dimostra ancora una volta di fondamentale importanza) rendono chiara la sua influenza su strumentisti come Dave Pike, Dave Samuels e persino Gary Burton. Va peraltro fatto notare che Tjader non opera solo come vibrafonista, ma anche come percussionista, soprattutto ai timbales, strumenti che richiedono, nel campo della musica afro-caraibica, una profonda conoscenza linguistica. Essa lascia marcate tracce nella tecnica con cui Tjader lavora al vibrafono, ad esempio l'uso dell'emiola (il passaggio da una suddivisione binaria in una ternaria, o viceversa: egli spesso sconfina dal 3/8 al 4/4) che assume una veste peculiare in una pagina come Tropicville (dall'album Latin Kick), in cui, su di un flusso di crome, il vibrafonista fa uso di due note separate da una terza minore rievocando in modo estremamente evocativo le sonorità diverse del maschio (macho) e della femmina (hembra) dei bongos e dimostrando così una conoscenza che va ben oltre il mero dato tecnico. Benjamin Thomas, in The Development of Cal Tjader's Latin Jazz Vibraphone Style cita anche il caso di Armando's Hideaway (dall'album Mas Ritmo Caliente), in cui Tjader utilizza il 3/8 in modo tale da rievocare i tipici artifizi linguistici di un timbalero. Egli sa inoltre usare l'emiola in modo tale da movimentare e conferire tensione a momenti di stasi armonica. Ancora di più, egli evidenzia una perfetta conoscenza della prassi esecutiva della clave [Nota 4] (e del montuno), di cui sa fare abile uso anche in fase di composizione (il già citato Tropicville, Mambo Macumba, Viva Cepeda) e, ancor più chiaramente, in ambito improvvisativo (lo si ascolti in Tenderly, dall'album Mambo with Tjader).
Nel maggio 1959 Tjader partecipa (con Vince Guaraldi, José "Chombo" Silva, Al McKibbon e Willie Bobo) alla registrazione di Mongo (Fantasy LP 3291), a nome di Mongo Santamaria; in seguito completa la realizzazione di Tjader Goes Latin. Per la Fantasy torna a registrare nella primavera del 1960, dopo una serie di esibizioni che portano il gruppo anche nelle università californiane: nasce così Concert On The Campus (Fantasy LP 3299) e, fra maggio e ottobre, vengono raccolte le pagine che verranno pubblicate anni dopo sotto il titolo di Concerts In The Sun (Fantasy FCD 9688-2). A novembre Tjader, assieme ad un'orchestra d'archi arrangiata e guidata dall'eccellente e sottovalutato pianista Clare Fischer, ed integrata dal contrabbassista Red Mitchell, dal batterista Shelly Manne e dal percussionista Milt Holland, incide una serie di pagine tratte da West Side Story di Sondheim e Bernstein (West Side Story, Fantasy LP 3310). Nel frattempo pubblica, a nome del Cal Tjader Septet (con il trombettista Teddy Torran, il flautista e sassofonista Modesto Briseno, Eddie Cano, Al McKibbon, Willie Bobo e Mongo Santamaria), un'altra incisione di carattere latino: Demasiado Caliente (Fantasy LP 3309), che raccoglie anche alcuni brani incisi dal vivo al Blackhawk di San Francisco con un sestetto che include il flautista José Lozano, il contrabbassista Victor Venegas, Lonnie Hewitt, Willie Bobo e Mongo Santamaria: egli continua, infatti, a mantenere l'alternanza costante fra i due diversi mondi musicali di provenienza, fra l'ortodossia del mainstream e quelle forme improvvisative che, con il riallaccio alle radici afro-ispanoamericane ritrovano l'originaria, archetipica e storica raison d'être. Il vasto successo popolare gli giunge, peraltro, da un pubblico in non piccola parte ispanico, che non solo apprezza l'opera divulgativa di Tjader nei confronti delle tradizioni musicali afro-ispanoamericane ma anche la sua manifesta ostilità nei confronti delle varie forme di discriminazione razziale esistenti negli Stati Uniti: i gruppi del vibrafonista sono multietnici sin dalle origini. Tjader (che come vibrafonista è profondamente influenzato anche da Tito Puente, il primo strumentista a fare uso del vibrafono in contesti afro-ispanoamericani), inoltre, "sdogana" la cultura musicale afro-caraibica presso il pubblico bianco, attratto da tutto ciò che è "esotico"; non casualmente, le copertine dei dischi dell'artista abbondano di immagini stereotipe: pretesi simboli aztechi, personaggi con indosso sombreri di varia foggia e misura e dai volti baffuti, foto o disegni di lande desertiche e ornate di qualche solitario cactus, quasi a suggerire una curiosa -e, oltretutto, inesistente- vicinanza con il Messico, segno comunque evidente, da parte della casa discografica, della volontà e convenienza di rivolgersi a tutti i Latinos indistintamente.
Fra il 1960 e il 1961, ancora con un'orchestra d'archi arrangiata e diretta da Clare Fischer, ed integrata dal pianista Buddy Motsinger, da Al McKibbon o Red Mitchell e Willie Bobo o Johnny Rae, Tjader incide una serie di pagine scritte da Harold Arlen e che andranno a costituire una produzione come Cal Tjader Plays Harold Arlen (Fantasy LP 3330). Il suo successo ormai è tale che può permettersi un contratto più vantaggioso con una casa discografica di maggior peso: nell'agosto 1961, con Paul Horn, Lonnie Hewitt, Al McKibbon, Johnny Rae e i percussionisti Wilfredo Vicente e Armando Peraza, Tjader incide In A Latin Bag per la Verve (Verve V/V6 8419), etichetta in cui domina la figura del noto produttore Creed Taylor, da sempre interessato alle contaminazioni (a lui si devono in gran parte la diffusione negli Stati Uniti della bossa nova e i rapporti di Stan Getz con la musica brasiliana). Segue la realizzazione di Saturday Night, Sunday Night At The Blackhawk (Verve V/V6 8459), con Lonnie Hewitt, il contrabbassista Freddy Schreiber e Johnny Rae. Con lo stesso gruppo (e con la presenza occasionale del pianista Robert Corwin al posto di Hewitt), Tjader incide, nel febbraio 1962, Anita O'Day/Cal Tjader - Time For Two (Verve V/V6 8472), deliziosa riuscita in cui la O'Day mostra di sapersi agilmente districare nella fitta ma elegante ed efficace trama ritmica elaborata dal vibrafonista (che si fa ascoltare occasionalmente anche come voce di supporto) per ravvivare pagine altrimenti un po' logore come Mr. Sandman, Under A Blanket of Blue, Just In Time, It Shouldn't Happen To A Dream, Spring Will Be A Little Late This Year. In occasioni come queste Tjader mostra di avere assimilato interamente una serie di stilemi afro-caraibici all'interno di un sapiente e brillantissimo fraseggio boppistico (cui egli non rinuncerà mai. Nonostante l'iniziale insegnamento di Brubeck, autore interessato all'irregolarità metrica, Tjader prediligerà costantemente lo swingante 4/4): la sua è di rado musica drammatica. Per quanto egli conosca perfettamente il meccanismo della teatralità, il pathos gli è essenzialmente sconosciuto: della sua infanzia gli è forse rimasto il gusto gioioso e quasi infantile di quell'intrattenimento il cui fine ultimo ed esclusivo è il piacere del pubblico. Come ispirato da Bentham, Tjader sembra voler ottenere, attraverso la sua musica, la maggior felicità possibile per il più gran numero possibile di individui. Non casualmente, egli commenta: I like people to dance to the Latin stuff. (...) At one of our dances in the Sombrero ballroom, for example, you can play a montuno, and everyone is responsive to it. Of course, in clubs you have to gear it more to the listener; but to me this is much more rewarding than playing to row upon row of concert listeners (John Tynan).
Artista ormai popolarissimo, si concede, fra il febbraio e il marzo 1962, di dedicare un intero lavoro discografico alle nuove musiche di valore che giungono dall'America Latina. L'intento è evidente sin dal titolo (certamente di poca attrattiva per un pubblico di massa a caccia di edonismo esotico) della nuova produzione per la Verve: Cal Tjader Plays The Contemporary Music Of Mexico And Brazil. Tjader vi interpreta (con il supporto di, fra gli altri, di Clare Fischer -che cura inoltre alcuni arrangiamenti per legni-, Johnny Rae, Milt Holland, Laurindo Almeida) alcune composizioni del compositore messicano Mario Ruiz Armengol (Silenciosa, Preciosa, Imagen, Que Tristeza, Sone) ed una serie di raffinate pagine scritte da Antonio Carlos Jobim (Meditação), Laurindo Almeida (Choro e Batuque), Clare Fischer (Elizete), Carlos Lyra (Se è tarde, me perdoa) e altri. Tjader affronta così altro repertorio latinoamericano e, nel pieno della bossa nova craze, si rivolge, a fine gennaio 1963, con maggiore intenzionalità alla musica brasiliana: nell'album Sona Libre (Verve V/V6 8531, con Clare Fischer, Freddy Schreiber, Johnny Rae e il percussionista Bill Fitch) interpreta, fra le altre, composizioni come O Barquinho e Manhã de Carnaval, con risultati francamente non memorabili: la sofisticazione della bossa nova, estremamente cool e formalmente composta, poco si adatta ad un temperamento viscerale che tende ad esplicitare quell'eredità africana-americana che, al contrario, la bossa nova implicita. Tant'è che, anni dopo, a contatto con artisti brasiliani meno inclini alla "occidentalizzazione" della loro tradizione musicale, Tjader, in un'incisione di grande pregio come Amazonas, saprà rendersi ben più significativo. Bisogna però ricordare che Tjader cresce esteticamente all'interno della cultura ispanoamericana di San Francisco, in cui intere generazioni di intellettuali insistono sulla raza, sui rapporti che legano fra di loro tutti i latinoamericani. Rivolgersi perciò anche ad una cultura latina, sebbene profondamente diversa, come quella brasiliana fa parte di un processo di "pan-latinizzazione" cui l'artista istintivamente e naturalmente aderisce.
Non si deve pensare che Tjader fosse un interprete in qualche modo prosaico o poco sensibile o, peggio, un semplice animale da palcoscenico, un virtuoso in grado di far leva su semplici istinti: in un'incisione come Several Shades Of Jade (Verve V/V6 8507), dell'aprile 1963, realizzata con un'orchestra guidata ed elegantemente arrangiata da Lalo Schifrin (ed in cui spiccano musicisti come l'ottimo batterista Ed Shaughnessy, i trombettisti Clark Terry e Ernie Royal, il cornista Bob Northern, il trombonista Urbie Green, il chitarrista Jimmy Raney, il contrabbassista George Duvivier), Tjader si misura con una serie di bozzetti, spesso imparentati con il kitsch, la cui ispirazione è -pur senza autenticità- di matrice dichiaratamente orientale e che risultano di sapore pressoché cinematografico. Il vibrafonista vi fa uso di tutta la sua sottigliezza ritmica e del suo innato gusto per il colore, creando un'elegante trama sonora dalla squisita gamma timbrica e che, quasi funambolicamente, riesce ad evitare la trappola del genere cosiddetto Exotica, "passapporto musicale" alquanto oleografico e allora ancora in voga negli Stati Uniti, innocuo "viaggio intorno al mondo in meno di ottanta giorni" per una nazione essenzialmente isolazionista. Laddove autori come Arthur Lyman, Martin Denny o Juan Garcia Esquivel più o meno astutamente ed ingegnosamente costruiscono degli ammiccanti e lussureggianti baedeker musicali più onirici che reali, Tjader e Schifrin utilizzano la (presunta) musica orientale come pretesto per creare un contesto sonoro che non ha alcuna pretesa di "informazione," ma che aspira ad essere un objet d'art fine a se stesso. Pur in un ambito così particolare, il vibrafonista (che con Schifrin condivide l'interesse per la cultura afro-ispanoamericana) riesce ad alludere sottilmente alle tradizioni dei latinos e a confermarsi un eccellente improvvisatore con una solida conoscenza del Canone africano-americano., sorretto da arrangiamenti solidi ed efficaci. Che Schifrin avesse i suoi meriti nei risultati è provato dalla replica dell'operazione: a novembre del 1963 Tjader incide Breeze from the East (Verve V/V6 8575), con un gruppo di strumentisti (fra cui il flautista e altista Jerry Dodgion, George Duvivier, Lonnie Hewitt, Dick Hyman) esilmente guidati dal violoncellista e arrangiatore Stan Applebaum: ancora una volta è la pretesa musica asiatica a far da comun denominatore, trasformata in questo caso nel plastificato cardine di un pastiche in cui il kitsch spadroneggia in modo persino divertente (basti ascoltare Stardust o East of the Sun in versione simil-orientale o Poinciana trasformata in un curioso mambo "abbellito" da melismi tratti da un Oriente vicino come una cartolina illustrata d'antan), fra accenni afro-caraibici, organo e chitarra che oscillano fra surf e mod, accordi orientaleggianti da colonna sonora di film d'azione anni Sessanta e alcuni pregevoli, efficaci quanto incongrui assolo di vibrafono. Creato ai giorni d'oggi, passerebbe per un delizioso esempio di post-moderno minore (di quelli, tanto pe intenderci, che John Zorn, nei momenti in cui agisce come una sorta di Quentin Tarantino musicale, ama rievocare): negli anni Sessanta non era che il frutto di una culturale poubelle de table.
Pochi mesi dopo Tjader torna a misurarsi con un'orchestra, probabilmente su volere del produttore Creed Taylor, che in quegli anni metteva a punto un modello estetico che si sarebbe rivelato appieno nella successiva (e di gran lunga sottovalutata) produzione per l'etichetta CTI. Warm Wave (Verve V/V6 8585), inciso l'8 maggio 1964, accoppia il settetto di Tjader (con Jerome Richardson o Seldon Powell ai sassofoni, Patti Bown, Hank Jones o Bernie Leighton al pianoforte, Kenny Burrell o Jimmy Raney alla chitarra, George Duvivier, Ed Shaughnessy e il percussionista Willie Rodriguez) al gruppo vocale francese Les Double Six ed un gruppo di archi guidati da un abile arrangiatore come Claus Ogerman: il vibrafonista si misura con un repertorio essenzialmente composto da standard, da Where or When a Ev'rytime We Say Goodbye, People o Poor Butterfly e con ottimi risultati, che forse potranno sembrare sorprendenti ad alcuni. Tjader, infatti, non è passato alla storia come un artista di pensiero, il suo ruolo di eccellente solista è stato messo in ombra dalla sua capacità di interagire con un'altra cultura, il cui peso -nonostante molte resistenze- si andava facendo sempre più avvertibile nella cultura americana; la stessa tradizione musicale afro-ispanoamericana, di cui egli sapeva cogliere con grande sensibilità numerose istanze, è stata a lungo fraintesa, ridotta a luogo di mero intrattenimento etnico e prima ancora che il Latin Jazz venisse assimilato nel Canone africano-americano era piuttosto il Latin Rock a imporsi e a ottenere successo (e a riconoscere un debito non indifferente proprio nei confronti di Tjader).
Il 20 novembre 1964 segna per Tjader il compimento finale di una sintesi: con il sincretismo da lui operato fra improvvisazione jazzistica e materiali linguistici afro-caraibici e afro-ispanoamericani, il Latin Jazz si presenta contemporaneamente come passato e presente del jazz, conquistando inoltre un successo di pubblico inusitato. Gli ascoltatori Latinos, infatti, si riconoscono nel Nuovo Mondo scoperto dal vibrafonista: vi ritrovano le proprie radici ma anche l'affermazione del loro ruolo nella contemporaneità dell'irrisolto melting pot americano. Con la registrazione di Soul Sauce (Verve V/V6 8614) si può affermare che Tjader conclude la sua opera, raggiunge la sua classicità, soprattutto nel campo del sincretismo afro-ispanoamericano (non a caso, Soul Sauce è, fra le realizzazioni del vibrafonista, quella meno linguisticamente legata al mondo degli standard e della loro rilettura jazzistica). A capo di un settetto che comprende Lonnie Hewitt, il contrabbassista John Hilliard, Johnny Rae e tre percussionisti (Armando Peraza, Willie Bobo, Alberto Valdes), e che viene integrato da strumentisti come Donald Byrd, Jimmy Heath, Richard Davis, Grady Tate, Kenny Burrell, Tjader crea uno fra i simboli musicali della emergente cultura Latina: Soul Sauce, brano che che dà il titolo all'album, è la rielaborazione non casuale di una pagina creata da Dizzy Gillespie e Chano Pozo, Guachi-Guaro, riletta come un trascinante cha-cha-cha. Pagine come Afro-Blue, Pantano (notevole anticipazione del cosiddetto boogaloo), Somewhere In The Night (trasformato in un sensuale bolero, come anche Spring Is Here), Tanya non sono certo tutte nuove, molte di loro fanno parte già da tempo del repertorio di Tjader: in Soul Sauce esse, in un certo senso, acquisiscono una veste definitiva ed entrano a far parte permanente del vocabolario musicale di quella che ben presto verrà denominata salsa. Non casualmente, l'album diventa un campione di vendita, con 100.000 copie e l'anno dopo, nel 1965, è ancora fra i 50 dischi più venduti negli Stati Uniti secondo la classifica stilata da Billboard. Poche opere artistiche hanno contribuito così tanto ad integrare un gruppo etnico in una società: Tjader può vantare un pubblico etnicamente misto, i suoi gruppi da sempre sfidano la segregazione razziale e accolgono musicisti provenienti sia dalla East Coast che dalla West Coast. Non solo, tutti gli artisti di origine extra-americana che collaborano con il vibrafonista, da Armando Peraza a Mongo Santamaria, fino a Poncho Sanchez, diventano delle celebrità. Con Tjader, il sincretismo del jazz non appare più come una dicotomia fra americani bianchi e africani-americani, ma una vera e propria triarchia, creata con l'indispensabile contributo afro-ispanoamericano. Egli riesce a dare voce ad una popolazione che fino ad ora è stata riluttante ad affermarsi ma che ormai ha allevato una classe intellettuale in grado di esercitare un'azione simile a quella esercitata circa quarant'anni prima dagli esponenti africani-americani della Harlem Renaissance: For above all else, the story of the Renaissance is one of the manipulated manipulating, the subordinated subverting, and of the politically and economically impuissant attempting to acquire political and economie advantage by other means (David Levering Lewis, When Harlem Was in Vogue, New York: Penguin Books, 1997).
Il vibrafonista coglie i frutti più maturi della sua arte in un momento in cui il rock'n'roll sta iniziando la sua irresistibile ascesa ed in cui è soprattutto il R&B a godere di crescente popolarità: con Soul Bird (Verve V/V6 8626), inciso nel giugno 1965 con il pianista Paul Griffin, il contrabbassista Richard Davis, Armando Peraza e Grady Tate che si alterna alla batteria assieme a Sol Gubin, Tjader cerca di avvicinarsi al pubblico giovanile, utilizzando ritmi latini ma anche sonorità del soul jazz e trasformando Doxy di Sonny Rollins in un trascinante esempio di disinibito funky.
Nel febbraio del 1966 Tjader incide l'album Soul Burst (Verve V/V6 8637), in cui più marcato è l'utilizzo di materiali latinos, questa volta sontuosamente arrangiati in parte da Oliver Nelson (Manteca, Cuchy Frito Man, My Ship, Bilbao Song): il vibrafonista sa però sfuggire agli stereotipi e in alcune pagine fa eccellente uso di uno o due flauti (Jerry Dodgion, Seldon Powell o Jerome Richardson) che, in elegante dialogo con il vibrafono, sanno creare delle sonorità morbide, inusuali per il più esplicito e usuale Latin jazz. Nel complesso spiccano le presenze di percussionisti come José Mangual, Victor Pantoja e Carlos "Patato" Valdes e, soprattutto, di strumentisti del calibro di Grady Tate, Attila Zoller e Chick Corea (autore di un interessante assolo in una sua eccellente composizione, Oran, decisamente la pagina più originale dell'intero lavoro), che arricchiscono una delle opere discografiche più interessanti e riuscite di Tjader.
Si potrebbe pensare che il vibrafonista avesse concluso la sua missione, quella di riportare la cultura musicale afro-caraibica nell'alveo del mainstream jazzistico, un'impresa che ha reso Tjader particolarmente popolare presso il pubblico americano ma decisamente meno presso la critica, chiaramente poco sensibile ad una tematica che, invece, s'è fatta particolarmente sentita ed importante con il trascorrere dei decenni. Ancora nel 1966, fra il 24 e il 26 di maggio, Tjader unisce le sue forze a quelle di uno fra i più significativi creatori della cosiddetta salsa, il geniale pianista, compositore e band leader Eddie Palmieri [Nota 5] : El Sonido Nuevo ("Il Suono Nuovo") è un titolo (Verve V/V6 8651), adeguatissimo, che non nasce certo da falsa modestia: il lieve ma scintillante vibrafono di Tjader, erede della versione cool del be bop, dialoga con la forza scatenata di un gruppo strumentale che alla briosa ariosità di San Francisco e della West Coast oppone l'energia centrifuga e tagliente della concrete jungle di New York e di El Barrio. Musica densa, scura, ipnotica, talvolta persino obliquamente dissonante, che sovrappone il blues e il funky delle strade all'eredità afro-caraibica più urbanizzata, con la collaborazione di alcuni straordinari musicisti, dallo stesso Palmieri agli eccezionali trombonisti Barry Rogers, Mark Weinstein e Julian Priester, al batterista Manny Oquendo, al contrabbassista Bobby Rodriguez o al percussionista Ismael Quintana: i composti ma sofisticati interventi del vibrafonista (che adotta una sonorità più "sporca," più "vetrosa"), lungi dallo stridere con il contesto ebulliente mettono invece in risalto la compatezza di un esperimento linguistico originale quanto compiutamente maturo. El Sonido Nuevo è uno fra i capolavori di quella nuova improvvisazione americana che si avvia a conoscere, grazie anche alla coeva esperienza del free jazz, un nuovo processo di vibrante internazionalizzazione e di impegno intellettuale e politico. Perché, come El Sonido Nuevo sta a dimostrare e prefigurare, la cosiddetta salsa non è solo curiosa musica d'evasione etnicamente caratterizzata: il lavoro di Eddie Palmieri (ricco di accenni a McCoy Tyner come a Thelonious Monk) e Cal Tjader esibisce una sofisticazione fuori dell'usuale e una capacità straordinariamente creativa nel recitare il vocabolario ricco, aggressivo, colorito e orgoglioso di una parte della società americana che si sta preparando per la futura Reconquista. E altrettanto entusiasmante, forse persino di più, è Bamboleate (Tico LPS-88806 - Fania/Emusica 130 217), che pochi mesi dopo Tjader, assieme a La Perfecta (Give me your band, the whole shit, pare sia stata la proposta del vibrafonista a Palmieri), realizza per l'etichetta del pianista, la Tico Records. Come afferma lo stesso Palmieri: The key was Bobby Rodríguez, the greatest Latin bass player we ever had. The band was at its peak. Più flessibile del precedente lavoro, Bamboleate vanta un versante jazzistico decisamente inusitato per il genere linguistico praticato allora da Palmieri: Tjader, ancora una volta, conferisce una quasi distaccata eleganza ad un possibile tumulto musicale e sa imporre un disciplinato senso della forma ad un eloquio che, altrimenti, sarebbe incontenibile e che nuovamente beneficia di superbi strumentisti.
E' questo il momento in cui il vibrafonista raggiunge il picco della sua arte; prima di cristallizzarsi progressivamente in una ricca classicità, egli riesce a far compiere alla sua arte un salto quasi azzardato: niente più estetismi, niente più mainstream o standard su cui operare con eleganza quasi sartoriale, ma il pulsare oscuro di un materiale musicale che sembra avere distillato nella contemporaneità l'enfasi corale di migliaia di riti afro-caraibici, con i tromboni che volgono al cielo la loro più veemente e stentorea imitazione vocale, di belluina eccitazione. Con El Sonido Novo e Bamboleate, Cal Tjader, che pure già se lo era conquistato, guadagna la certezza di un posto nella storia delle molte musiche americane.
Dopo la sperimentazione con Eddie Palmieri, Tjader si unisce nel marzo 1967 al grande e sottovalutato arrangiatore Chico O'Farrill per un eccellente lavoro come Along Comes Cal (Verve V/V6 8671), cui partecipano Chick Corea, Bobby Rodriguez, Armando Peraza e Ray Barreto, Grady Tate e Derek Smith (all'organo). A settembre dello stesso anno realizza The Prophet (Verve V6 8769), primo passo verso una classicità edonistica, con casuali ammiccamenti ai linguaggi più aggiornati della musica popolare cui fa da cornice una opulenta sezione d'archi. Lo stesso può dirsi di Hip Vibrations (Verve V/V6 8730), inciso il 12 dicembre 1967, con una serie di ammiccanti arrangiamenti scritti da Benny Golson e Bobby Bryant per un'orchestra infarcita di eccellenti musicisti, da Herbie Hancock a J. J. Johnson, da Marvin Stamm a Richard Davis e Mel Lewis.
In un periodo in cui per il pubblico giovanile americano il jazz pare materiale obsoleto, Tjader cerca di mantenersi au courant, utilizzando strumenti elettrici e approfittando del repertorio popolare: a questi parametri si uniforma la sua produzione per la Skye Recordings, etichetta discografica che egli fonda con il noto chitarrista ungherese Gabor Szabo e con il sottovalutato arrangiatore e vibrafonista Gary McFarland (che aveva collaborato con Tjader in alcune realizzazioni discogrfiche mai pubblicate dalla Verve). Nel 1968 pubblica Solar Heat (Skye SK-1), che si avvale degli eleganti arrangiamenti di McFarland (che in una pagina duetta al vibrafono con Tjader) ma che si basa su materiali non sempre suscettibili di essere trasformati egregiamente: pagine come La Bamba, Never My Love, Ode To Billy Joe e persino Afro-Blue non riescono a prendere il volo, nonostante la partecipazione di musicisti di qualità come João Donato all'organo, Mike Abene al piano elettrico, Chuck Rainey al basso elettrico. Il clima è di banale adeguamento ai tempi, ed è lo stesso che si respira in posteriori incisioni come Cal Tjader Sounds Out Burt Bacharach (Skye SK-6, 1968, con arrangiamenti di Gary McFarland, Mike Abene, Allan Foust e la partecipazione di musicisti come Garnett Brown, Jerry Dodgion, Harvey Newmark, Jerome Richardson, Marvin Stamm, Jim Keltner), Cal Tjader Plugs In (Skye SK-10, f ebbraio 1969, con Al Zulaica al piano elettrico, Jim McCabe al basso elettrico, Johnny Rae e Armando Peraza).
Tjader torna ad incidere per la Fantasy, riproponendo costantemente il repertorio e la formula che gli avevano dato la celebrità: il suo è un autunno del Patriarca tutt'altro che banale, come testimoniano alcune riuscite prove strumentali dal vivo (Live At Funky Quarters, 1972, Fantasy F 9409, con Al Zulaica, l'ottimo contrabbassista John Heard e il non meno valido batterista Dick Berk; The Grace Cathedral Concert, 1976, Fantasy F 9677, con Lonnie Hewitt, il contrabbassita Rob Fischer, il batterista Pete Riso e il conguero Pancho Sanchez, valentissimo strumentista scoperto proprio da Tjader) nonché opere come Agua Dulce (Fantasy F 8416, 1971, con Luis Gasca, Pete Escovedo, Coke Escovedo, Bill Perkins, Ron McClure, Dick Berk e altri ancora) e Primo (Fantasy F 9422, 1973, con, fra gli altri, Tito Puente, Jack Jeffers, Charlie Palmieri, Bobby Rodriguez, Ismael Quintana), brillanti e aggiornate riletture di un repertorio pre-salsa. Spicca, invece, a testimonianza delle straordinarie e ancora vivide risorse intellettuali di Tjader, quando sottoposte ad adeguata sollecitazione, un'affascinante incisione del 1975 come Amazonas (Fantasy F 9502), che il vibrafonista, prodotto dal percussionista Airto Moreira, realizza con una serie di artisti brasiliani votati al rinnovamento della propria tradizione come Raul De Souza, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Luiz Alves, Robertinho Silva, cui si aggiungono il chitarrista David Amaro e il tastierista George Duke. Per quanto l'opera possa apparentarsi alle molte operazioni di crossover dell'epoca, essa possiede una notevole forza evocativa e, soprattutto, evidenzia uno straordinario virtuosismo posto al servizio di un incantatorio lirismo tropicale di cui Tjader sa farsi naturale interprete. Amazonas costituisce il suo ultimo, ma altamente significativo, capolavoro (anche se egli pubblicherà ancora numerose incisioni per l'etichetta Concord Picante, come l'ottimo La Onda Va Bien, costanti rivisitazioni del suo passato con la collaborazione di ottimi interpreti quali Poncho Sanchez, l'eccellente pianista Mark Levine, il flautista Roger Glenn o il sassofonista Gary Foster): lontano, molto lontano dal mondo afro-caraibico che gli era caro, affacciato sulla soglia di un Nuovo Mondo in espansione come quello del post-tropicalismo brasiliano, connubio fremente e sinuoso di modernità e regno della Natura, una concezione che il tranquillo intellettuale allevato ai miti della West Coast americana dimostra di comprendere appieno, forse colto da emozionante capogiro fra i conturbanti e magici vapori di una foresta tanto vicina quanto lontana e inavvicinabile, ennesimo miracolo di quell'eredità africana cui il bianco di origine svedese Callen Radcliffe Tjader aveva generosamente dedicato la vita, con un'ammirazione che non aveva mai rinunciato ad una sorta di timoroso rispetto.
John Storm Roberts (Latin Jazz: The First of the Fusions: 1880s to Today, 1999, New York, Schirmer Books) sceglie giuste parole di apprezzamento per un artista profondo quanto poco appariscente: Playing a style most jazz writers did not understand, and in an age when then old European Romantic concept of the suffering artist had to some extent infected jazz, the modest, decent, talented, and agreeable Tjader did not get the critical respect he deserved. But whether you think jazz is about creating honest and complex music or expressing the deepest aspects of the artist's own personality (another Euro-Romantic concept, of course), Tjader's work should rank high, even if he was fortunate enough to have a temperament and a life that weren't the stuff of dramatic anecdotes.
Note
1) La Fantasy, fondata da due fratelli di origine ebraica, Max e Sol Weiss, con le sue scelte orientate verso una costante modernità e in grado di testimoniare il clima da "villaggio globale" di San Francisco, crea una vera e propria cultura per la città. Come srive Ted Gioia nel suo volume sul West Coast Jazz: If San Francisco could ever lay claim to a truly indigenous jazz style, it sprang from the sui generis modernism fostered by the Blackhawk and Fantasy Records.
2) Small clubs were flourishing all over the city, including the Blackhawk [Tenderloin District], where Art Tatum played one of his last residencies; the Jazz Workshop [North Beach], where Cannonball Adderley recorded with his quintet; the Club Hangover [Downtown], where Earl Hines performed; Earthquake McGoon's [Downtown / North Beach], where Turk Murphy's trad-jazz band played for 20 years; and Bop City [The Fillmore], where Dexter Gordon and Sonny Criss once played (Christiane Bird, The Da Capo Jazz and Blues Lover's Guide to the U.S.: Completely Revised and Updated, 3rd Edition, Cambridge, MA: Da Capo Press, 2001)
3) Come scrive Ted Gioia: Tjader seemed to draw on the instincts of a horn player in shaping his improvised lines. They did breathe. One might expect, given this distinctive quality, that Milt Jackson, whose horn-line approach revolutionized vibes playing in the 1950s, had been Tjader's prime influence. Indeed, in 1962, he said: "l'm so influenced by what Milt Jackson has done. He has been the Lester Young of the vibes. I find myself always thinking, 'How does this compare with something Milt did?' ... Milt just revolutionized the instrument."
4) Antonio Gentili spiega con chiarezza in cosa consista la clave: La clave come concetto musicale è un pattern o patron, per dirlo in spagnolo, di due misure; una sincopata composta di tre colpi ed una lineare di soli due.
Questa suddivisione asimmetrica e binaria (nel senso che è composta da due misure) del tempo caratterizza e condiziona fortemente la musica cubana e latina in generale. In che modo? è molto semplice. Tutti gli elementi costitutivi di un brano musicale ovvero pattern ritmici, melodie e cambi armonici sono sempre perfettamente correlati con la clave e si appoggiano o si intersecano sui suoi accenti. La battuta sincopata, considerata forte è sempre contrapposta a quella lineare o debole ed il loro accoppiamento crea un continuo alternarsi di tensione e rilassamento ritmico della musica.
Questa è senz'altro una delle implicazioni più evidenti di questo tipo di concezione ritmica ma, dal punto di vista pratico ne abbiamo una ben più importante: la direzione della clave. Con direzione della clave si intende definire quale delle due battute forte o debole venga per prima, dato per assunto che in un brano musicale la clave non si interrompe mai dall'inizio alla fine. Detto in parole più semplici un brano musicale o anche un semplice pattern può iniziare giocoforza o con la battuta forte o con quella debole. Essendo la musica latina una risultante della sovrapposizione di diversi pattern ritmici e melodici, conoscere la direzione della clave di un brano o di un pattern da parte di tutti gli esecutori è di fondamentale importanza per la perfetta esecuzione degli incastri ritmico-melodici. Facciamo un esempio concreto.
Nel caso di una piccola sezione ritmica composta da congas, timbales, contrabbasso e pianoforte ogni strumentista dovrà eseguire un proprio pattern ritmico-melodico di due misure. Ogni pattern è stato concepito per contribuire a bilanciare perfettamente la tensione ritmica tenendo come unico riferimento la clave. Questo significa che ogni pattern avrà una precisa distribuzione di accenti e di note che tiene perfettamente conto di ciò che viene suonato dagli altri musicisti. L'effetto voluto viene raggiunto solo se tutti suonano nella stessa direzione. Se uno dei musicisti rovescia il proprio pattern invertendo l'ordine delle due misure si troverà traversado o cruzado ovvero rovesciato rispetto agli altri con evidenti effetti di fastidio da parte di tutti. L'unico modo per non correre questo rischio è essere perfettamente coscienti del rapporto che lega il proprio pattern alla clave ed usare quindi la direzione della clave come nuovo codice di comunicazione tra i musicisti.
Proprio in questo ambito si parla spesso di clave 2-3 e clave 3-2 come se fossero due cose differenti. In realtà con queste due indicazioni numeriche si intende definire proprio la direzione della clave in un preciso brano musicale o in un pattern. In poche parole, su uno spartito la scritta "clave 3-2" significa che il brano o il pattern iniziano con la battuta forte (3 colpi) mentre la scritta "clave 2-3" che iniziano con la battuta debole (2 colpi). Questa indicazione è sufficiente a far si che tutti i musicisti inizino a suonare in maniera corretta, senza rovesciare il proprio pattern.
Ma veniamo alla soluzione di un altro dilemma, il più temuto dai percussionisti. Dato un brano o un pattern, scritto o registrato, come riconoscere la direzione della clave?
Per ciò che concerne un brano musicale, specie se cantato, la risposta è quasi sempre molto più semplice di quanto si creda. La melodia indica quasi sempre chiaramente la direzione della clave. Ebbene si. Nella musica latina tutto si poggia sulla clave, anche la melodia. Questo significa che la metrica degli accenti di una melodia, sia cantata che strumentale, si poggia perfettamente o si incastra ancor più perfettamente sugli accenti della clave, rivelandocene inevitabilmente la direzione.
Arriviamo quindi alla definizione delle seguenti regole generali per l'individuazione della direzione della clave:
1. la metrica della melodia del pezzo si poggia sugli accenti della clave
2. la metrica della melodia del pezzo si incastra sugli accenti della clave
3. la metrica della melodia del pezzo si poggia e si incastra sugli accenti della clave quando queste regole non ci sono sufficienti possiamo ricorrere alle seguenti:
4. la metrica delle parole del coro si poggia e/o si incastra sugli accenti della clave
5. gli stacchi obbligati dei fiati si poggiano e/o si incastrano sugli accenti della clave quando neanche questo ci è sufficiente ci rimane solo una risorsa: cercare un pattern a noi ben noto del quale siamo ben certi di conoscere la relazione con la clave e dopo averlo individuato cercare di risalire alla direzione della clave fin dall'inizio del pezzo.
A questo punto nasce immediata l'esigenza di trovare qualche regola generale per l'individuazione della direzione della clave in un pattern di due misure. Pur enunciandola dobbiamo dire che non sempre è possibile applicare questa regola. Esistono infatti pattern di una sola misura che non ci danno questa possibilità. Esistono anche pattern che apparentemente non seguono la regola generale che andiamo ad esporre:
la misura che corrisponde alla parte 2 della clave (debole) spesso è la più lineare ed ha una nota in battere sul primo movimento.
la misura che corrisponde alla parte 3 della clave (forte) spesso é la più sincopata o variata ed ha una pausa sul battere del primo movimento.
5) Eddie Palmieri nasce a New York il 15 dicembre 1936 da genitori portoricani. Con suo fratello maggiore Charlie ha scritto gran parte della storia el pianismoa portoricano nella Salsa. Fin dalla tenera età viene iniziato al pianoforte da suo fratello e nonostante la sua grande passione siano le percussioni ed il suo idolo Tito Puente, Eddie all'età di 14 anni già organizza una sua orchestra. Nei 10 anni seguenti il suo pianoforte è presente nelle migliori formazioni dell'epoca a fianco di Tito Rodriguez, Vicentico Valdes, Johnny Seguì.
Nel 1961 forma il gruppo La Perfecta, una formazione che rivoluzionerà la musica latina introducendo nell'originale formato cordofono cubano della Charanga il suono rauco ed aggressivo dei tromboni. La Perfecta ha segnato la storia della Salsa, da essa sono passati eccezionali musicisti: da Cheo Feliciano ad Andy Gonzalez e Manny Oquendo (futuri fondatori del Conjunto Libre), da Jimmy Bosh (che fu allievo di Barry Rogers, celebre trombonista del complesso) a Giovanni Hidalgo, da David Sanchez (il sassofonista portoricano oggi uno dei protagonisti della scena jazzistica di New York) a Lalo Rodriguez (che, separatosi dai gruppi di Palmieri, è diventato il cantante della Salsa Romantica) alla "India" lanciata da Palmieri stesso nel '92 con il disco Llegò la India.
Le nuove sonorità ed una grande libertà creativa decretano il successo di Palmieri nella New York pre-salsa. Nel 1968 scioglie il suo gruppo e si dedica alle contaminazioni musicali più svariate spaziando dal boogaloo al R&B alla musica afro-liturgica, non trascurando il jazz. in una ricerca sonora che accompagna tutta la sua carriera.
Nel 1974 esce "The sun of latin music" il disco che darà a Palmieri il suo primo premio Grammy. A questo disco seguirà una serie di lavori spesso di rara sofisticazione. Negli anni '80, Palmieri colleziona altri Grammy con una produzione musicale all' avanguardia e nella quale si ritrovano il Son cubano, l'influenza del Jazz ed una certa asprezza nel suono che è il riflesso della durezza e della marginalità del Caribe urbano. Negli anni '90, con l'avvento della Salsa erotica Palmieri si dedica quasi a tempo pieno al Latin Jazz. Agli inizi del 2000 produce con Tito Puente il disco Obra maestra che gli varrà il suo sesto Grammy.
Palmieri è stato definito "il Miles Davis" della Salsa.
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.