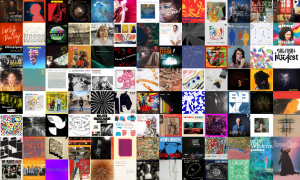Home » Articoli » Live Review » Ernest Dawkins Chicago 12
Ernest Dawkins Chicago 12
Auditorium Parco della Musica - Roma - 11.05.2006
Si sfoglino anzitutto gli avvenimenti in filigrana e si considerino in proiezione i protagonisti.
Ernest Dawkins leggeva il Chicago 7 Trial, processo che si tenne nel 1969, contro otto attivisti accusati di aver innestato i disordini al ciglio della Convenzione Democratica del 1968. Manco a dirlo, l’unico attivista afro-americano fra quelli imputati, Bobby Seale, fondatore con Huey Newton del Black Panther Party, non se la passò tanto bene. Non è la prima né l’ultima storia del genere che si celebra nella musica afroamericana: certo una delle pagine più incredibili a riguardo non può che essere quella di Mingus/Faubus. Sarebbe tutta un’altra storia. O forse non proprio, visto che le idee che hanno sostenuto entrambi i musicisti in questa loro socio-musica non è poi così dissimile. La filigrana: un remix di parole vecchie e simboli nuovi, si celebrava il gusto per lo slittamento. La proiezione: neroamericani ieri e neroamericani oggi, sempre qualcosa in più o in meno degli americani. Ma si potrebbe anche leggerla così: l’avant garde di ieri e quella di oggi. Somiglianze e differenze.
Dawkins, dunque. Misconceptions of a Delusion Shades of a Charade (Dawk Musica, Usa 2005 - per leggerne la recensione clicca qui) non è mai arrivato in Italia. Almeno nei negozi di dischi. E’ però approdato in forma di performance sul palco dell’Auditorium Parco della Musica, prima assoluta. Nell’ambito del Le labbra nude (11-14 maggio), rassegna nata dalla collaborazione tra Musica per Roma e Rai Radio3 nella persona specifica di Pino Saulo, pensata come la costola sonora del Festival della Filosofia. Voce e musica, allora. Non solo spoken word, bensì una realtà ambigua, prima e dopo l’hip hop, al di qua e al di là dei Last Poets e sopra e sotto il jazz, il soul, il funk (il New Grass dell’Ayler fenomeno sarebbe stato il manifesto spirituale). Certo la Ursula Rucker, che ben si incastra in un’estetica vocale musicale ritmata, è parsa una donnina piccola piccola se solo si considera la potenza incendiaria dell’ampio organico che Dawkins ha diretto, controllato e istigato nella seconda parte della prima serata.
È l’attuale presidente dell’AACM, Dawkins. Al di là del recupero sul razzismo - che certo chi non conosce la teoria del la proiezione prima citata potrebbe scambiare per retorica - c’è il punto fermo sulla musica. È un ritratto a collage di un percorso, più o meno quello del disco, legato in lunghe catene: così si costruisce un’opera nuova. Si rimane incantati e stupiti. L’ostinato dei due contrabbassi (Josh Abrams è quello che più sa sorprendere) riprende, certo, l’idea dell’orchestratore Ornette Coleman, però non si ha neanche il tempo di pensarci che irrompono le due batterie. E una è la possente martellata di Hamid Drake, vero legame tra le generazioni. Già, perché questa del Dawkins è una formazione molto giovane. Ce n’è uno noto anche a chi non conosce troppo la realtà di Chicago: Corey Wilkes. Uno sperpero di eccentricità, che però era funzionale al suo hard bop che trascolorava spesso in un’estetica onnivora, frammentaria e ricombinatoria. Quasi l’iterazione fosse un modo per dar consistenza e stabilità, si alternavano lunghi assoli della prima linea, così estesi che quasi si dimenticava il tema. Qualcuno rimaneva più vicino a questo, qualcun altro partiva alla deriva (in tutto erano cinque fiati e un pianoforte). Piaceva, tra quelli della seconda specie, l’altosax di Greg Ward.
C’è un unico disegno melodico in tutte le fasi dell’opera, anche quando sale sul palco Khari B., disco poet (definizione ripresa dal disco). Rapper di vecchia risma sarebbe stato più o meno uguale. In fondo non è certo lui il personaggio da tenere a memoria; meglio ricordare la tensione, la dinamica, quel substrato nero blues e cavernoso che permane in tutta l’esecuzione.
Foto di Stefania Errore
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.