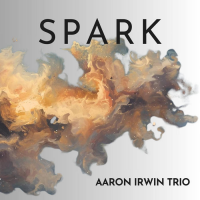Home » Articoli » Live Review » Salso Jazz
Salso Jazz
Eppure in questa situazione penalizzante ci sono festival che hanno il coraggio di aprire i battenti come il festival di Salsomaggiore Terme. L'importante è poter contare su un minimo di risorse economiche, ma soprattutto essere animati da molta buona volontà e da una precisa idea progettuale.
A Salsomaggiore l'idea è partita paradossalmente da esponenti della musica classica: Carlo D'Alessandro Caprice e il violinista Alessandro Quarta, rispettivamente presidente e insegnante dell'Accademia I Musici di Parma. Entrambi convinti sostenitori del fatto che sia opportuno e più gratificante abbandonare una pedissequa aderenza allo spartito per proiettarsi nell'improvvisazione interpretativa; per questo motivo hanno deciso di organizzare delle masterclass intensive riservate a pochi allievi selezionati, stimolandoli verso un approccio interpretativo che ben difficilmente hanno avuto modo di apprendere nei corsi di conservatorio. In sintesi, il loro metodo consiste in una sorta di "maieutica dell'interpretazione," che aiuta gli allievi a dare forma ad una personale e consapevole visione interpretativa. Il percorso didattico si articola in tre fasi concatenate: la riscrittura di una composizione classica, la propria conseguente interpretazione e successivamente una più completa capacità improvvisativa.
Nel fine settimana dal 17 al 19 maggio, un primo esperimento di tale percorso ha coinvolto quattro allievi (un oboista, due violiniste e una cantante di età comprese fra i 22 e i 25 anni), partendo dalla partitura del famoso "Adagio" di Alessandro Marcello (tradizionalmente attribuito al fratello Benedetto), tratto dal Concerto in re minore per oboe e orchestra. Nel pomeriggio di domenica, con l'accompagnamento di Alessandro Quarta al piano elettrico, i quattro strumentisti si sono esibiti uno dopo l'altro dimostrando i risultati raggiunti in questa breve esercitazione di riscrittura e reinterpretazione. Certo non si è trattato di risultati definitivi, ma solo di un primo passo; è stato tuttavia estremamente significativo vedere come in poche ore Quarta sia riuscito ad innescare in loro un'apertura mentale, una motivazione tali da spingerli a superare una lettura preoccupata e piatta della partitura ed intravvedere ben altre possibilità d'interpretazione.
Un programma ambizioso dunque quello dell'Accademia, che deve svolgersi nell'arco di un intero anno accademico e che, se non indulge a soluzioni di dogmatismo didattico ma si plasma sulle reali possibilità/caratteristiche dei singoli studenti, può ottenere risultati sorprendenti. In pratica si tratterebbe di favorire un accesso all'improvvisazione jazzistica partendo da una formazione prettamente classica.
D'altra parte ci troviamo di fronte al medesimo atteggiamento mentale che oggi genera progetti artistici di grande successo da parte di tanti protagonisti della scena contemporanea; in Italia Giovanni Sollima ne è uno degli esempi più eclatanti. Se invece ribaltassimo l'ottica partendo dall'esperienza del jazz, sarebbe perfino scontato ricordare la rivisitazione obliqua di pagine classiche operata sistematicamente da Uri Caine negli ultimi vent'anni.
Nei fine settimana del 24-26 maggio e 7-9 giugno le masterclass (e i relativi concerti) saranno tenute rispettivamente dal contrabbassista Yuri Goloubev e dal pianista Michele Di Toro, strumentisti ferratissimi e ben noti nell'ambito jazzistico. Per inciso, una breve considerazione merita la prestigiosa location dei corsi e dei concerti: quel monumentale Palazzo dei Congressi, di proprietà comunale, che ospita fra l'altro la stessa Accademia I Musici di Parma. Costruito nei primi anni del Novecento in stile bizantino-arabeggiante, il Palazzo a pianta centrale intercala le ricche decorazioni in stucco agli allegorici affreschi d'impronta klimtiana dipinti da Galileo Chini: ...una tipica e fastosa manifestazione dell'eclettismo della Belle Epoque, prima che giungesse la Grande Guerra a spazzare via definitivamente quel mondo.
Ma veniamo finalmente alla recensione del momento spettacolare della rassegna. La sera di sabato 18 maggio Alessandro Quarta, assecondato da due ospiti, ha sostenuto un concerto probante degli esiti perseguiti dalla sua personale ricerca. Nel già citato "Adagio" di Marcello il violinista era affiancato da Christoph Hartmann, primo oboe della Filarmonica di Berlino, e da Michele Di Toro al piano. Dapprima l'esposizione del tema è stata rispettosa; le variazioni sono intervenute solo nel finale con l'introduzione quasi trasgressiva del piano elettrico da parte di Quarta.
Il secondo brano, in completa solitudine, si è rivelato invece un'esibizione sfrenata di virtuosismo, in cui si potevano riconoscere citazioni, sviluppi, deformazioni dal "Capriccio n. 1" di Paganini, dalla "Ciaccona" di Bach, dal "Labirinto Armonico" di Locatelli... Il violinista ha espresso una sonorità piena, quasi di aspra concretezza, un drive nervoso e perentorio, perfino qualche inflessione di sapore lontanamente etnico. Le sue variazioni/improvvisazioni si sono innestate creativamente sul patrimonio classico, quasi a ricordarci che un simile procedimento interpretativo non è certo una prerogativa esclusiva del jazz, ma anzi è stata prassi comune nel Sette-Ottocento da parte degli strumentisti/compositori europei.
In tutti gli altri brani Quarta, che si è alternato al violino ed al piano elettrico, per lo più usato come bordone basso, è stato affiancato da Di Toro. Mentre in "Panem Angelicum" di Mozart il pianista è risultato pertinente e corretto ma con funzione subalterna, di sostegno al solista principale, in altri brani ha conquistato un ruolo paritario, confermandosi performer non solo di tecnica solidissima, ma anche di forte personalità.
Sono così emerse le interpretazioni di famosi temi ellingtoniani ("It Don't Mean A Thing" e "Caravan") e di Piazzolla ("Oblivion" e "Libertango"), che hanno rappresentato gli episodi più convincenti del concerto, intrisi di concitazione e passionalità, di estroversione e cadenze danzanti, di un intenso interplay e abbandoni lirici.
In conclusione come possiamo definire il jazz di Alessandro Quarta? Che analogie possiamo scorgere con altri esponenti del suo strumento? Ben difficilmente sono riscontrabili parentele con i violinisti dell'attualità jazzistica americana (Mark Feldman, Mazz Swift, Regina Carter...) e anche di quella europea (Dominique Pifarély o il nostro Emanuele Parrini). L'approccio delle sue variazioni/improvvisazioni si avvicina invece alle dinamiche evoluzioni di Stéphane Grappelli, che egli dichiara di ammirare particolarmente, e semmai alle deformazioni del primo Jean-Luc Ponty e alla accattivanti e plateali digressioni di Didier Lockwood.
Insomma il nostro violinista leccese (classe 1976) sembra guardare principalmente alla tradizione dello Swing, ma anche ai fermenti di matrice rock e agli esiti della Fusion. Egli è partito dalla sua formazione ed esperienza professionale all'interno della musica classica per contaminarla con l'esuberanza ritmica e la densità sonora proprie di altri generi musicali. Tutto sommato, mutatis mutandis, si agiva così anche negli anni Cinquanta, quando certo jazz costituiva la colonna sonora della ricostruzione postbellica, quando Piero Umiliani, prima di passare a prove più impegnative, jazzificava con brio "Scalinatella" o "Funicolì Funicolà".
Operazione legittima quella di Quarta, con risultati tecnico-espressivi più che apprezzabili, a tratti esaltanti, con una comunicativa ammiccante (certo non sono molti i violinisti di estrazione classica capaci, senza uno spartito davanti, di suonare con tanto divertimento, tanta naturalezza, tanta energica libertà e con tali risultati), ma più problematica diventa la giustificazione concettuale/culturale di tale operazione. Il suo linguaggio infatti al momento attuale appare ancora ibrido, un po' datato, senza quella profondità e originalità di sintesi, quell'autonomia che possono permettere al violinista di raggiungere un'incontestabile identità, un protagonismo assoluto nel panorama internazionale del jazz e non solo. Forse un carattere tanto entusiasta e tanta facilità tecnica, che spingono l'autore ad un'espressione onnivora e spettacolare, andrebbero tenuti sotto controllo e finalizzati ad un progetto musicale più circoscritto.
Frames da video di Francesca Clementoni
Tags
PREVIOUS / NEXT
Support All About Jazz
 All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.
All About Jazz has been a pillar of jazz since 1995, championing it as an art form and, more importantly, supporting the musicians who make it. Our enduring commitment has made "AAJ" one of the most culturally important websites of its kind, read by hundreds of thousands of fans, musicians and industry figures every month.